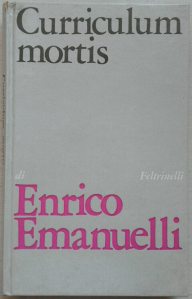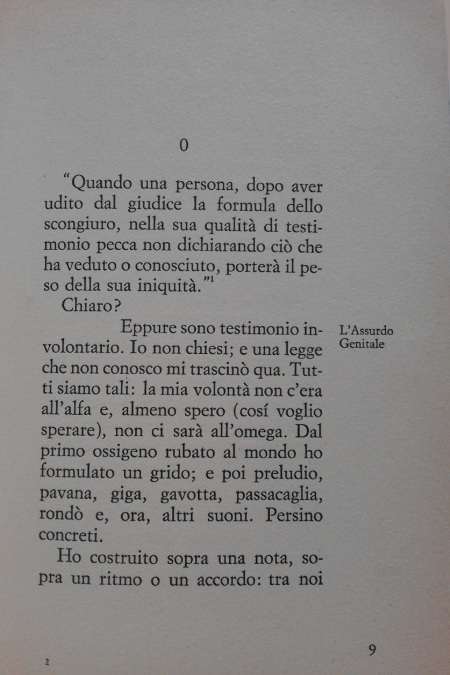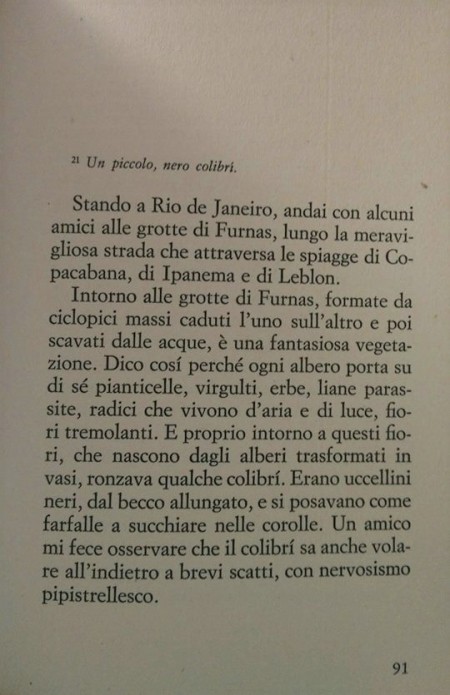Archive for the ‘PUBBLICATO su’ Category
Come un’onda che si tuffa sullo scoglio: la storia vera di Roberto Tancredi, portiere della Juventus
L’amore bianco di Francesca Piovesan. Parlando di A pelle scoperta, di Francesca Piovesan


Questa recensione è stata pubblicata su «Letteratitudinenews» il 21 dicembre 2019.
_________________________________________________________________________________________
Benché Francesca Piovesan sia veneta, c’è qualcosa di eracliteo nella sua raccolta di racconti A pelle scoperta (Arkadia, collana Sidekar, 2019, 128 pp.), qualcosa in continua trasmutazione: che è quello, ma che è anche non quello; un dinamismo della realtà che è stallo.
Un romanzo psicologico (e perché leggerlo). Parlando di A Bordeaux c’è una grande piazza aperta di Hanne Ørstavik
Questa recensione è stata pubblicata su «Letteratitudinenews» il 3 dicembre 2018.
Perché parlare di Hanne Ørstavik e del suo romanzo psicologico A Bordeaux c’è una grande piazza aperta (Ponte alle Grazie, 2018, 228 pp.)? In fondo – pur conosciutissima all’estero, tanto da esser stata tradotta in ventisei lingue e aver recentemente partecipato alla finale dei National Book Awards nella Shortlist della sezione «Translated Literature» – è una scrittrice norvegese tradotta per la prima volta in Italia, per giunta senza nemmeno essere una giallista.
Perché, allora?
Breve topologia letteraria della follia
Questo articolo è stato pubblicato sul n. 22 di aprile di «FuoriAsse – Officina della Cultura»
________________________________________________________________________
http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/119-fuoriasse-n-22/935-fuoriasse-22.html
C’è una tela di Goya, esposta alla Real Academia de San Fernando, a Madrid, intitolata la Casa de Locos. Finita nel 1812 dopo alcuni anni di saltuario lavoro, evoca un luogo – manicomiale – dove si aggirano, sotto le volte di uno spoglio stanzone, grottesche figure di alienati seminudi appena rischiarati da una luce opaca e stagnante. Sulla parte sinistra dell’opera, proprio dove nella penombra si ammassano più numerosi i segregati, campeggia un uomo dai mustacchi lunghi e neri, dallo sguardo esaltato e sostenuto, con uno strano copricapo munito di penne. Al suo fianco, come si potrebbe omaggiare un capo o una personalità di spicco, una donna, china, bacia devotamente la sua mano destra.
La suggestione (e, come ogni suggestione, potenzialmente fuorviante) esercitata dalla visione del pittore aragonese, se serve bene a sollevare i temi di cui argomenteremo – il viaggio nella ferita della mente umana e nei luoghi della contenzione manicomiale – serve pure, attraverso un semplice scarto analogico, a sorprenderci già nel vivo di quel racconto/reportage che De Amicis pubblicò (siamo già all’altro capo del Secolo XIX) prima sulle pagine della «Rivista d’Italia» del dicembre 1899[1], poi per i tipi del livornese Belforte e, in seguito, dei Fratelli Treves[2].
Nel giardino della follia (questo il suo titolo) coglie, infatti, lo scrittore alle prese con una cleptomane, gioviale donna di mezz’età, «vestita con garbo» e «con tre penne di cappone piantate nel nodo dei capelli, in forma di raggiera»[3] la quale, più avanti, spiritosamente paragona De Amicis a Pallavicini di Priola, generale vittorioso sui drappelli garibaldini in Aspromonte e, in seguito, comandante impegnato nella repressione del brigantaggio meridionale. I due, in effetti, si somigliano, anche accomunati da due folti baffi neri, ma come il risvolto negativo – biografico, politico e morale – dell’altro. Non a caso la donna «da quel momento, come se si fosse fatta nella sua mente una sostituzione di persona, non mi chiamò più che “generale”»[4].
E così già il titolo stesso dato alla pagina giornalistica, Nel giardino della follia, altro non è che stridente ossimoro, Eden e Limbo dove si trascinano le non battezzate dalla ragione, e dove si rifugiano le inquietudini suscitate dai ricordi del figlio Furio, da poco suicidatosi con un colpo di rivoltella a Torino, al Valentino (un parco!); e le apprensioni per la tenuta mentale della moglie, che si aggraverà più avanti.
Inizia, in questo modo, per lo scrittore una sorta di strano viaggio, di girovagare a più dimensioni: lungo i sentieri del giardino, intersecati da sensi di pena e corrispondenti volontà di fuga; e tuttavia anche della singolare sensazione di essere, oltre che tra le mura del giardino, anche tra quelle della mente delle alienate: «Ebbi un senso di pena, non mai provato, e che non saprei bene esprimere. Ero dunque vissuto un tempo in quell’anima: v’ero vissuto e v’ero morto; il mio nome non era più nella sua mente che un suono, come la mia persona un’ombra al suo sguardo. E continuando a passarsi la mano sulla fronte, pareva che mi volesse dire: – Vedi, questa è una tomba, e anche tu ci sei sepolto»[5].
Ma restano lampi, come, del resto, l’apparizione della giovane inginocchiata e assorta in giochi regrediti di bambina, fasciata in un busto che sembra allo scrittore, in un primo momento, un curioso «abito da ginnastica», ma che si rivela essere, con un brivido, una camicia di forza «in riposo, per adesso»[6]. Le pagine di De Amicis, come nel suo stile, non avevano e non avrebbero potuto avere alcunché di calcato, di espressionistico o di visionario. Come ha ben scritto Carlo Alberto Madrignani, Nel giardino della follia manca «di vistosi elementi coercitivi» e anche questa pagina «vuol, forse, suggerire una latente dimensione di violenza, che tuttavia l’autore evita di enfatizzare»[7]. C’è poco di naturalistico, di fotografico o, all’opposto, di carduccianamente oratorio nello stile di De Amicis; semmai il tentativo, con i suoi pregi e i suoi rischi sentimentalistici, «di offrire al lettore una riproduzione letteraria che lo induca a trovare uno status emozionale specifico»[8]. E tuttavia, nelle pagine del Giardino c’è pure un controllo della pagina che non può che ritrovare le sue ragioni nelle recenti tragedie familiari, tra l’altro sottolineate dalla presenza, nel prosieguo del racconto, del secondogenito dello scrittore, Ugo. Ma se è pur vero che lo sguardo di De Amicis resta «preideologico», resta, cioè, una «forma dello sguardo capace di cogliere le movenze emotive e i bisogni affettivi intesi come esigenze materiali altrettanto urgenti di altre (fame, sesso, denaro) esaltate dalla coeva antropologia positivistica»[9], è anche vero (come pure in Cinematografo cerebrale[10]) che, in più punti, la prosa deamicisiana finisce per incagliarsi e sfumare la sua forza tra la resa colloquiale e l’esigenza del distacco, tra il tentativo di confrontarsi attrezzato di uno stile letterario formalmente composto e una materia, la follia, che continuamente gli si oppone nei fatti.
E se ciò non impedisce allo scrittore di intuire – a proposito dell’improvvisa apparizione della donna agitata «da impeti furiosi di baccante»[11] – quanto limitata possa essere l’analisi positivistica e bonaria del dottore che lo accompagna e, cioè, che la sopravvenuta pazzia non porti con sé, se non in casi rarissimi, una trasformazione radicale dell’indole, allo stesso modo non impedirà a De Amicis di sentirsi superiore nel suo dolore di “uomo pienamente cosciente” rispetto a quello possibile delle sofferenti rinchiuse in manicomio. La qual circostanza rivela, in altre parole, come la frenologia e la prima psichiatria non andassero troppo per il sottile nella distinzione dei casi patologici inserendo, in poche larghe categorie, il disadatto sociale, l’emarginato, il disturbato e il delirante. Di lì a poco, infatti, l’esigenza di giungere a una regolamentazione degli istituti psichiatrici unica per tutto il territorio nazionale portò ad approvare la proposta Giolitti del 1902 nella Legge 36/1904 che avrebbe ispessito le mura di quel giardino fino ad allontanarle definitivamente in un luogo altro, separato e lontano anche se ancora dentro il corpo della città. Se dunque è vero, come scrive Madrignani, che la pazzia per De Amicis è la pericolosa constatazione di «una parzialità, non un segno organico che separa totalmente i malati dai sani»[12], pare anche chiara la contraddizione (che lascia qualche non fugato sospetto di apotropaicità) di mantenere, da parte sua, ogni compostezza formale nella descrizione propostane e ogni distacco dalla sua patente irrazionalità.
I folli sono come sonnambuli, spiega allo scrittore il dottore: soffrono poco perché la loro coscienza è anestetizzata dal male che rende rapsodico il loro dolore. In tal modo anche il savio può, in alcuni casi, soffrire di periodica follia. Il dubbio si insinua così tra le maglie delle solite sicurezze e apre le porte all’introspezione. Avviene quando irrompe sulla scena la giovane bionda cantante sull’aria (guarda caso) della belliniana Sonnambula: è qui, con questo richiamo all’Opera e all’Arte o a un effetto di specchio, che la riflessione sulla fragilità mentale più colpisce i pensieri di De Amicis. Ma anche qui l’episodio non resta che un momento, un lampo, incapace di dare ulteriore sangue allo stile certo caldo, ma mai definitivamente coinvolto dello scrittore.
Del resto, a che pro insistere in un dialogo se adoperare coi pazzi lo strumento della ragione sarebbe – sono ancora le parole del dottore – «come suonare il violino a un sordo o scrivere la lettera a un cieco»[13]?
Cosa, a Torino, sarebbe diventata questa apparente resa della razionalità rispetto alla mente ferita dei ricoverati ce la racconterà, poi, il Novecento, con l’aggiunta del peso di due guerre devastanti, della scoperta dell’universo concentrazionario, del controllo politico del privato dei totalitarismi e dell’abdicazione a ogni verifica democratica dei poteri da parte della nuova società affluente e del “benessere”. Da questo pozzo fondo, verrà tirato su un Leviatano o, che è lo stesso, le parole agghiaccianti di un ormai quasi del tutto dimenticato Giorgio Coda: «Portami su quello che canta!». È lo scandalo che Alberto Papuzzi, con l’ausilio di Piera Piatti, riportano a galla nell’omonimo libro pubblicato da Einaudi[14] con un linguaggio ormai scarno, giornalisticamente maturo eppure coinvolto, partecipato. Non si tratta più, infatti, di parlare ai sordi, come nelle parole del dottore del giardino di De Amicis, ma di riconoscere l’identità dei reclusi di Collegno, di riconoscerne i diritti a un trattamento pienamente umano. Sono gli anni dell’antipsichiatria che porteranno di lì a poco alla frettolosa approvazione antireferendaria della “Basaglia” (180/13 maggio 1978). Anni che avrebbero chiuso definitivamente la pagina pure coraggiosamente aperta da De Amicis con la condanna a cinque anni di reclusione e e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici di Giorgio Coda per maltrattamenti e applicazione indiscriminata e punitiva del mezzo più noto come elettroshock.
______________________
Note:
[1] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, «Rivista d’Italia», a. II, vol. III, dicembre 1899, pp. 581-600.
[2] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, con disegni di G. G. Bruno, Livorno, S. Belforte e C. Editori, 1902; con qualche variante in più rispetto alle precedenti l’edizione milanese dei F.lli Treves del 1904 alle pp. 147-176 della raccolta Nel regno del Cervino. Nuovi bozzetti e racconti.
[3] Tutte le citazioni del racconto deamicisiano saranno qui riprese dall’omonima edizione, a cura di Roberto Fedi, Firenze, Le Càriti Editore, 2002. Cfr. pp. 33-36.
[4] Ivi, p. 36. La donna, così come la figura del dottore che accompagna De Amicis, non è, in realtà, che la figura di uno psicopompo dantesco: l’ambasciatrice della follia nel mondo dei sani, così come il dottore (e lo stesso scrittore), è il mediatore con il mondo dei matti. Tuttavia, vedremo che, nonostante le reciproche fascinazioni, i mondi resteranno sempre ben distinti e separati.
[5] Edmondo De Amicis, Op. Cit., p. 34.
[6] Edmondo De Amicis, Op. Cit., pp. 57-58.
[7] Carlo Alberto Madrignani, Verità e narrazioni. Per una storia materiale del romanzo in Italia, a cura di Alessio Giannanti, Giuseppe Lo Catro e Antonio Resta, p. 261. Il titolo è di prossima uscita per i tipi di ETS, Pisa. Il testo raccoglie, tra l’altro, quanto prodotto da Madrignani nella curatela del libro di De Amicis, Il giardino della follia, Pisa, ETS, 1990. Ringrazio il professor Giuseppe Lo Castro per avermi dato la possibilità di consultare il libro in anteprima.
[8] Madrignani, Op. cit., p. 258.
[9] Madrignani, Op. cit., p. 260.
[10] De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995.
[11] De Amicis, Nel giardino della follia, cit., pp. 40-41.
[12] Carlo Alberto Madrignani P. 263.
[13] Edmondo De Amicis, Il giardino della follia, cit., p. 45.
[14] Alberto Papuzzi, Portami su quello che canta. Processo a uno psichiatra (scritto con la collaborazione di Piera Piatti), Torino, Einaudi, 1977.
Prigioni, camere, cinematografi e altri strani viaggi da fermo

Questo articolo è stato pubblicato sul n. 21 di dicembre di «FuoriAsse – Officina della Cultura»
________________________________________________________________________________________
http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/cooplett-news/118-fuoriasse-21/832-fuoriasse-21.html
In un passo dell’autobiografico Il frutto del fuoco (Adelphi, 1982)¹, Elias Canetti racconta del suo casuale incontro, in un caffè del quartiere viennese di Hacking, con un gruppo di gente di malaffare, dal linguaggio rozzo e violento. Tra questi, spicca un certo Poldi, alto e minaccioso, che una sera lo segue, col malcelato tentativo di estorcergli informazioni sulle ville della strada che Elias frequenta. Per distoglierlo, Canetti gli indica, invece, la casa dove abita un paralitico di nome Marek. Quest’ultimo, pur assomigliando molto, nei tratti del viso, a Poldi, non può assolutamente muoversi e gira le pagine dei libri che legge con un colpo di lingua. Poldi è dapprima incredulo (lui così forte potrebbe mai assomigliare a uno «sciancato», sia pure così intelligente?), poi, sempre più sconvolto dalle parole di Elias finisce singolarmente per bloccarsi sui suoi piedi, dimenticando di camminare e, solo alla fine, trovando la forza di tornarsene indietro, senza portare a termine il suo compito. Tempo dopo, Canetti, viene a sapere che la banda di Poldi è stata catturata e, immaginando quell’uomo, così fisicamente energico, assaggiare nuovamente le restrizioni di una cella angusta, improvvisamente gli si rivela il perché della bizzarra reazione di blocco del ladro durante quella sera.
Ecco, dunque, il luogo, il crocevia di temi dove Canetti ci pone con il suo peculiare stile da talpa, sempre capace di intersecare e annodare gallerie e strade provenienti da direzioni apparentemente lontane ed eterogenee. Tensioni, equilibri o cortocircuiti tra il muoversi e lo stare fermi in un luogo, tra liberazione e costrizione, fino al paradosso del viaggio da fermo o quello del riuscire a spostarsi, pur in una condizione di prigionia.
Un crocevia dove ritroviamo alcuni personaggi letterari, tra i quali, a esempio, il «Cavaliere» protagonista del breve racconto deamicisiano Cinematografo cerebrale (pubblicato la prima volta, insieme ad altri racconti, su «L’Illustrazione Italiana» tra il 1906 e il 1907), che un giorno si ritrova – fin là sempre preso dall’ufficio, dalla casa, dagli amici – inusualmente solo con se stesso, sprofondato in una poltrona davanti al camino di casa. Onde far trascorrere prima le ore, prende una decisione curiosamente contraria al Porthos, moschettiere tutto azione, ricordato dal filosofo Brice Parain nel film Vivre sa vie (regia di J.-L. Godard, 1962), il quale, fuggendo, si sorprende a pensare per la prima volta e, facendolo, si arresta, trovando la morte.
Risolvendosi a non voler pensare a nulla, il Cavaliere scopre, invece, che la mente può essere una casa usata da idee e visioni nomadi. Essa appare «aperta da ogni parte, senza battenti e senza imposte, come un edifizio non finito, dove entra chi vuole»². Inizia così un inarrestabile flusso di coscienza che, di associazione in associazione, porta il protagonista a un forte stato di spaesamento e di angoscia. E, nonostante l’uomo cerchi di far mente locale, tentando di volgere o guidare quei pensieri da qualche parte, finisce per ritrovarsi prima nella soffitta delle cianfrusaglie del pensiero, poi nella cantina delle pulsioni primarie, della trasgressione, della collera e della disonestà.
È questo il De Amicis più tardo, forse letterariamente meno efficace di Amore e ginnastica (Treves, 1892) o di Il giardino della follia (Belforte, 1982)³. E, tuttavia, è pure il più amaro e sulfureo: quello, per dirla con Biagio Prezioso (nella sua introduzione a Cinematografo cerebrale, Roma 1995), che porta il Franti di Cuore a farsi, da elemento deviante della società, momento perturbatore dell’Io. Del resto De Amicis ha, in questa ultima fase della sua vita, già consumato la sua crisi con le idee socialiste, il rapporto tormentato con sua moglie e il suicidio di suo figlio Furio. Uno snodo storico da dove, oltre ogni dissolto positivismo, De Amicis realizza, finalmente e col dovuto sarcasmo, che la mente «è un meccanismo da nulla, che può incepparsi all’improvviso»4 e in qualsiasi momento della vita.
Prima di De Amicis e patendo una più forte costrizione, anche il savoiardo Xavier de Maistre aveva tentato, sul piano creativo, la via di una liberazione attraverso un «viaggio da fermo» che, al di là delle sue ragioni originarie, chiunque potrebbe facilmente sperimentare. Infatti, nel 1790, durante il carnevale di Torino, Xavier, a causa di un diverbio, si era battuto in vittorioso duello d’onore con l’ufficiale Patono de Meyran. Fu quindi, per questo, arrestato e condannato per legge a 42 giorni di cattività da scontare nella Cittadella di Torino. Seguirono giorni oziosi, grigi e destinati al rimpianto della libertà perduta. E, nondimeno, furono proprio i disagi seguiti a quella esperienza di spaesamento a creare l’esigenza di un nuovo impaesamento, cioè la possibilità di un felice ritorno a casa, sia pure letterario. Ritorno che si realizza, «avventurosamente», tra influenze Rousseauiane e digressioni di ascendenza sterniana, tra briose flânerie, meditazioni sul tempo, e pigri, quanto pericolosi, spostamenti «a cavallo» del proprio seggiolone (del quale scosta da terra, per avanzare, alternativamente le zampe a destra e a sinistra, con effetti di buffa instabilità).
Fratello del più noto Joseph, Xavier fu scrittore in definitiva episodico, ma sempre umanamente e moralmente partecipato, «pieno di grazia, delicato e commovente» (così Sainte-Beuve, nel 1839, sulla «Revue des deux mondes»). Perdigiorno indolente e svagato, intellettualmente vivace, ma pure capace di affrontare ascensioni in mongolfiera, campagne militari e poi lunghi e faticosi viaggi, Xavier sempre apparve un carattere curiosamente polarizzato. Condizione che, insieme agli aspetti contenutistici propri della sua opera, non manca di permeare e di illuminare, ancora oggi, la sua produzione, come pure ha fatto notare Carmelo Geraci (curatore dell’edizione italiana di Voyage autour de ma chambre e di Expédition nocturne autour de ma chambre, Bergamo 1999)5.
Del resto, de Maistre stesso si persuase di questa sua inclinazione caratteriale se, dopo i primi convenevoli, scrive del suo Viaggio che: «Esso farà piena luce sulla natura umana; è il prisma con cui si potrà analizzare e scomporre le facoltà dell’uomo»6 sebbene, in realtà, il prisma altro non si rivelerà essere che il dispositivo rivelatore della natura del savoiardo. E il congegno atto a far funzionare l’intera struttura del libro, che, non a caso, si dipana dal ricordo di una banale scottatura delle dita frutto di una paraprassia, di una distrazione generata da un sovrappensiero.
Atto sintomatico che presto rivela la sua origine platonica, essendo composto l’uomo «di un’anima e di una bestia […] assolutamente distinti, ma talmente compenetrati l’uno nell’altro, oppure uno sull’altro, che l’anima deve aver proprio una certa superiorità sulla bestia per essere in grado di distinguere l’uno dall’altro»7. Un’idea di bestia, dunque, forse non così sovrapponibile a quella di corpo inteso come pura vegetatività. Perché la bestia (l’altra, come la chiama, platonicamente, Xavier) rivendica una sua volontà, una sua sensibilità e un suo gusto autonomi. Ne deriva che: «La grande arte di un uomo di genio è di sapere bene educare la propria bestia a tal punto che questa possa andarsene da sola, mentre l’anima, libera da quella penosa intimità, si eleva fino al cielo»8. Oppure, quando così ben allenata, trovandosi la bestia in stato di cattività, possa ogni giorno volare a riaprire la porta di casa ritrovando i libri, i quadri, le esperienze là vissute, e raramente percorrendo una linea retta nel muoversi, a esempio, dalla tavola al letto, abbracciando il cane o parlando con il proprio maggiordomo.
Ecco, allora, che nel suo commiato, alla sua scarcerazione, Xavier potrà farsi beffe di chi pretende restituirgli la libertà, pur rammaricandosi di dover riprendere le catene della quotidianità, degli affari, della convenienza, del dovere. E tuttavia, de Maistre coglie, nel rimpianto delle sue «gioie» di prigioniero, la consolazione di una «forza segreta» che lo trascina dicendogli che ha «bisogno di aria e di cielo, e che la solitudine somiglia alla morte»9. Che è quel sentirsi «duplice» che Xavier risolverà solo molti anni dopo, tornando da una nuova spedizione intorno alla sua camera una notte lunga una guerra e un’epoca.
_______________
Note:
¹Ed. orig.: Die Fackel Im Ohr, Lebensgeschichte 1921-1931, Munchen-Wien, Carl Hanser Verlag, 1980.
²Cfr. Edmondo De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 29.
³L’articolo Nel giardino della follia, scritto a seguito di una visita presso l’allora ospedale psichiatrico femminile di Torino, fu pubblicato prima di uscire in volume, sulla «Rivista D’Italia», 15 dicembre 1899.
4Biagio Prezioso, Introduzione, in Edmondo De Amicis, Op. cit., p. 14. Il curatore sintetizza un passo tratto da E. De Amicis, Nel giardino della follia, a cura di carlo Alberto Madrignani, Pisa, ETS, 1990, pp. 66-68.
5Ed. orig.: Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre e Expédition nocturne autour de ma chambre, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1896.
6Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera, traduzione, introduzione e note di Gennaro Auletta, Catania, Edizioni Paoline, 1961, p. 27.
7Ivi, p. 28.
8Ivi, p. 29.
9Ivi, pp. 133-134.
La masseria di Giuseppe Bufalari e la modernizzazione del Sud – Intervista a Antonio Celano di Sara Calderoni su Fuori/Asse, novembre 2016, n.18

La copertina del n. 18 di “Fuori/Asse” illustrata da Lucio Schiavon

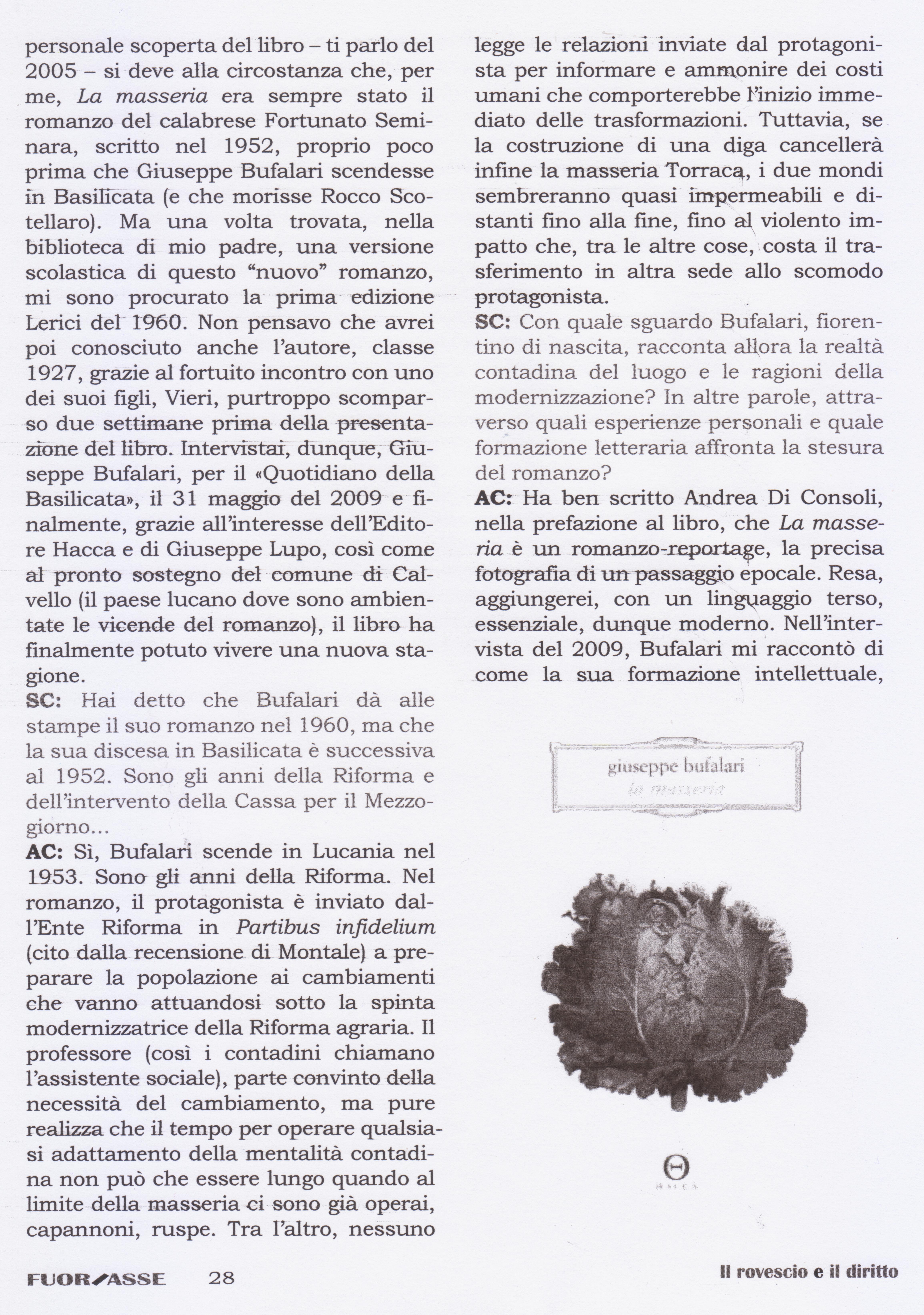

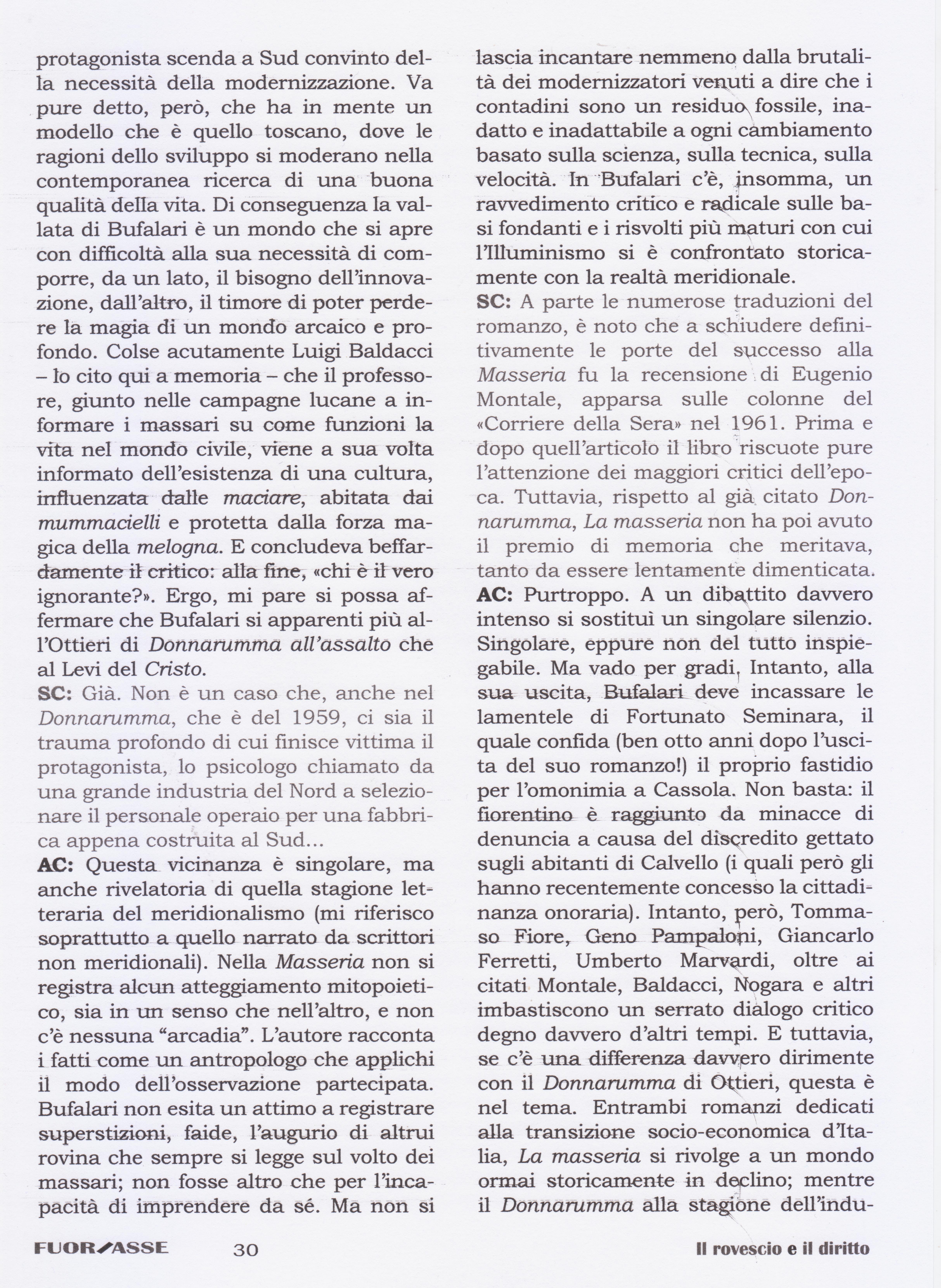
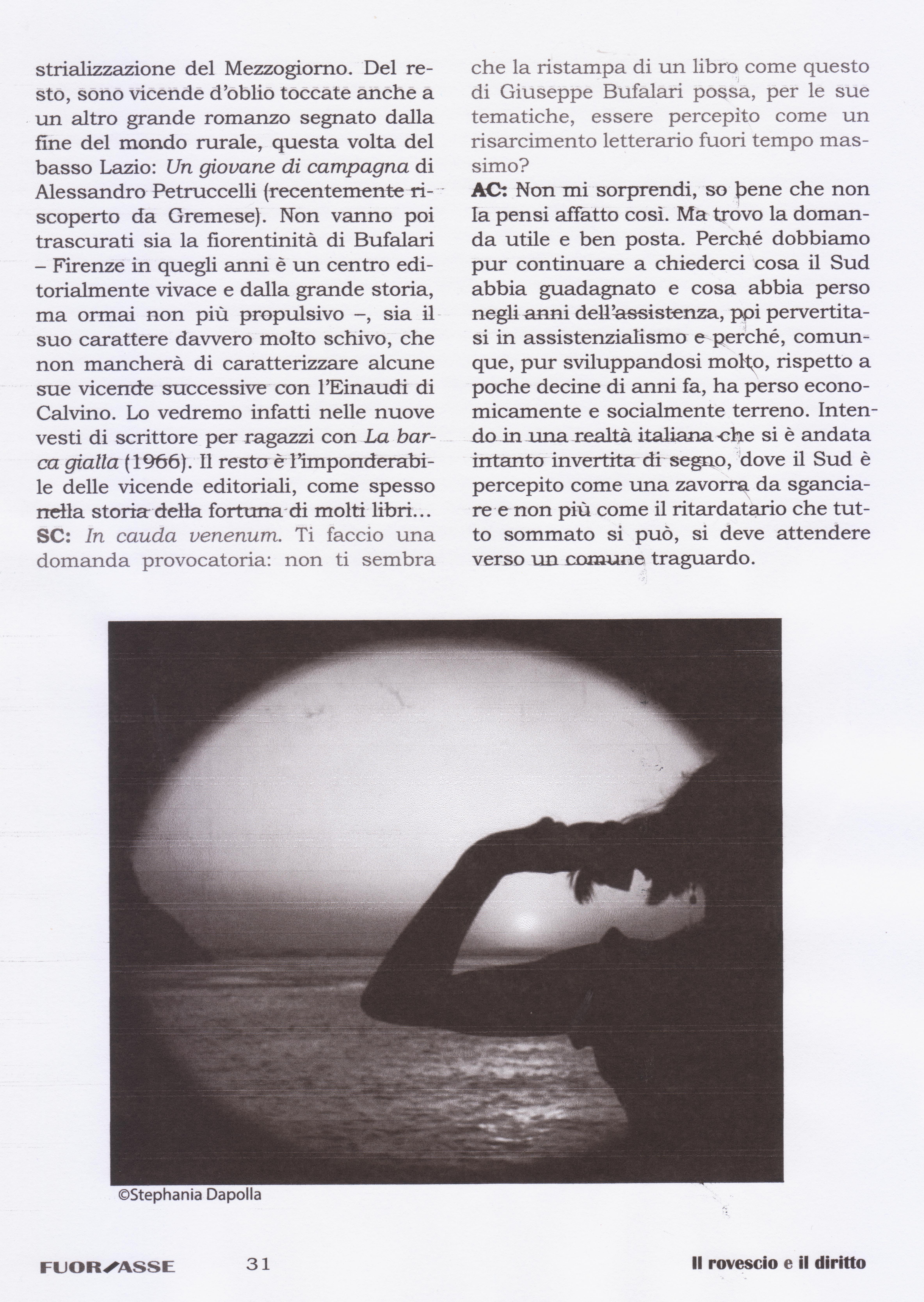
http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/115-fuoriasse-18/744-fuoriasse-18.html
Italo Calvino e Baccinin nei gerbidi

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 7 (2206)/2013.
——————————————
La raccolta di racconti “Ultimo viene il corvo” fu data alle stampe da Italo Calvino, per i tipi dell’Einaudi, nell’agosto del 1949. Raccoglieva trenta racconti brevi, diversi già apparsi su quotidiani e periodici, scritti tra l’estate del ’45 e la primavera del ’49. Di questi trenta racconti, alcuni furono ricollocati in successive raccolte, altri scartati e sostituiti con scritti posteriori. Dal ’76 in poi, infine, si tornò all’esatta riproduzione della prima raccolta, ché tutti i racconti furono in ogni caso ritenuti validi per la ricostruzione di un clima e di un’epoca. È infatti la stagione migliore del neorealismo, quella più immediata, espressiva. Come scriverà lo stesso Calvino, in un quadro condiviso che era stata l’esperienza collettiva e devastante di una guerra: “si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva avuto storie drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca”. Di qui pure il recupero positivo del parlato, delle espressioni dialettali, di una certa “mimica dei personaggi”. Ma che in Calvino hanno già qualcosa di nuovo, una scrittura urgente, senza compiacimenti eppure ironica, favolistica, quasi l’autore avesse già ben chiari quegli elementi stilistici di leggerezza, rapidità ed esattezza che sono il lascito più tangibile della sua successiva produzione.
Ingredienti che è possibile trovare anche nei racconti rusticali dedicati a episodi di caccia: basti pensare al capolavoro che ancora oggi dà il titolo alla raccolta, ad esempio, oppure all’ironica favola “Il bosco degli animali”. Brani che pongono, però, questioni morali per cui la perizia nello sparo o nel raggiungimento del bersaglio mai si slegano dall’episodio resistenziale ai tedeschi.
Racconto, invece, pienamente ispirato a un episodio venatorio è un altro piccolo capolavoro: “Uomo nei gerbidi”. Albeggia, dalla costa si scorgono le coste della Corsica, segno che il tempo sarà buono. Due cacciatori, padre e figlio, si inerpicano alle spalle del paese. Come in altre storie di Calvino, si intuisce tra i due una difficoltà di relazione. Tuttavia il padre presto lascia il ragazzo a un incrocio tra sentieri, dice: “Io andrò all’altro passo. Quando arrivo fischio e tu slegherai il cane. Tieni aperti gli occhi che è un momento a passare la lepre”.
Intanto, mano a mano il sole si alza, prendono forza i colori, il paesaggio si fa riconoscibile, si scorge “la nera nuvolaglia degli uliveti” e un bosco spelacchiato e bruciato. Tutto è come quando gli occhi si riaprono alla luce: lame di foschia sul mare impediscono di cogliere pienamente l’orizzonte, mentre la città, di sotto, emerge dalle ombre. Il luogo, Colla Bella, finalmente si mostra per quello che è, una terra scabra, di erbe dure, di rade piante stentate.
In cima a questi gerbidi c’è la casa di “Baccinin il beato”, un contadino anch’egli con la passione per la lepre: un uomo “magro che per vederlo bisognava si mettesse di profilo”. Non è un caso, dunque, che, in un numero dell’”Unità” del ’47, il racconto prendesse in un primo momento il titolo di “La casa di Baccinin”. C’è sempre, in Calvino, una stretta rispondenza tra l’uomo e il paesaggio che abita. E come lo stesso scrittore aveva già fatto notare, il contadino ligure è solitario, scontroso, proprietario e schiavo di fasce di terreno strappate alla costa. In perenne lotta con tutti, dal governo alle erbacce, persino con se stesso, questo lavoratore, aggiunge Andrea Dini, resta però ammalato di terra, ossessionato dalla “roba” tanto quanto un contadino del Sud.
Baccinin vede il giovane, scende da lui, gli chiede se la guerra è finita, anche se è finita da un pezzo. Ma forse ha timore delle sue personali o di quelle che pensa verranno. Baccinin rimastica continuamente le parole, le ripete; pone domande retoriche di cui sa già la risposta, che è “Scarogna, scarogna”: i carciofi non hanno preso, le fave son seccate, come cacciatore è uno “schiappino”, manca sempre la lepre e, quando la prende, la cagna scappa. Anche sua figlia Costanzina è “selvatica come una capra” e ha la faccia, la bocca e gli occhi a oliva. È immersa nella vita dei campi ma, come il ragazzo, è diversa dal padre: la notte, quando spariscono le luci della città, ha paura, ricorda ancora le bombe. La città l’affascina, l’altra sorella se ne è già andata.
Pendolando tra la casa e la posta, Baccinin finisce per frapporsi tra il giovane cacciatore e il cane che torna dietro la lepre. Staziona, chiacchierando, all’incrocio, come inconsapevole di ogni gioco di squadra, incapace di partecipare, di collaborare, di uscire dalla sua condizione ostinatamente isolata. E così la lepre balza via. Spunta il padre sacramentando dietro al cane. Chiede se qualcuno l’ha vista, ma Costanzina è già su, alla casa, e Baccinin non s’è accorto di nulla. Il giovane, che non ha chiesto al “beato” neppure di scansarsi, tace. Il gruppo si disperde, ognuno distante e silenzioso.


Piuma di fagiano: un racconto di Enzo Siciliano

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 15-16 del 31 agosto 2012.
——————————————
Scritto e pubblicato dieci anni prima che il grande Enzo Siciliano morisse, Piuma di fagiano – la storia del contadino Santino che non sa smettere la sua passione per la caccia – è senza dubbio uno dei più bei racconti venatori del secondo Novecento, dalla curiosa genesi editoriale e letteraria.
Pensato appositamente per il volume numero 42 della collana “Racconti brevi”, Piuma di fagiano è stampato, nel settembre del 1996, dalla fiorentina Pananti in soli 300 esemplari fuori commercio arricchiti, sull’antiporta, dal particolare di un disegno di Venturino Venturi. Esaurita la raffinata plaquette, l’esperimento è ripreso nel 2002 con un’edizione commerciale tirata in 50 (+ XV) copie dall’editore Motta di San Marco in Lamis e giustapposta, per la bisogna, a un’acquaforte acquatinta di Piero Guccione (“La maschera e l’ibisco”). Per la lettura da parte di un pubblico più vasto si deve attendere, invece, che l’anconetana Italic rimpolpi con nuovi racconti, nel 2009, Cuore e Fantasmi, una raccolta di Siciliano già pubblicata da Mondadori nel 1990.
Le radici letterarie e umane della genesi di Piuma di fagiano vanno ricercate, tuttavia, anni prima, quando Enzo Siciliano decide, nel 1971, (anticipando future tendenze in anni di caotici inurbamenti e scandalizzando Moravia) di acquistare un casale nei pressi del Vertano, tra Terni e Perugia: landa già nota per essere prediletta più dai cinghiali che dall’umano genere.
Qui – come ebbe a raccontare Paolo Conti, tra intervista e ricostruzione, su una pagina del “Corsera” guarda caso del ’96 – la famiglia Siciliano fa l’incontro con Santino, nel ’71 neanche sessantenne: contadino “dalla fantasia lieve”, il cui intercalare affascina Siciliano tanto da aiutarlo a meglio comprendere Jacopone da Todi durante un lavoro sul grande poeta medievale. Ammalato di caccia (cinghiali, lepri, quaglie, fagiani) Santino, da buon contadino, sa far quadrare queste avventure con la pratica “quotidianità del pollaio” e della difesa degli orti in una lotta con volpi, faine e donnole senza esclusione di colpi (anche bricconi); fino a essere “capace di rimanersene acquattato una notte intera su un albero per spiare l’arrivo di un cinghiale pronto a divorargli un filare di granturco o a sterrargli le patate ancora verdi”.
Nel 1996, Siciliano ha 62 anni e “sappiamo com’è”: come prima non accadeva, “la mattina ci si sveglia prima di svegliarsi. S’imbianca la coscienza di una luce allarmata e dolorosa” che non è altro che il tempo. Santino invece è ormai un ruvido vecchio di 83 anni, “magro: l’età sembra avergli divorato tutto il superfluo dello stomaco, del punto vita”, e la cintura spessa regge su “calzoni con qualche piega di troppo”. Eppure, come ha scritto recentemente Andrea Caterini, l’uomo è “voce” schietta, “segno malandrino di una vitalità che non desiste” che imprime, dice Siciliano, un “sentimento di scommessa con il quale guadagna nelle sue giornate un minuto sull’altro”.
Come se fosse armato ancora del magnetofono con cui, tra il ’67 e il ’71, aveva iniziato a intervistare Moravia, Siciliano incalza questa volta ben altro protagonista. Sa che il suo contadino, come i contadini, è capace di elusione: traguarda nel campo di pannocchie una coppia di fagiani e non lo dice. Siciliano indovina, poi chiede: “vola il fagiano?”. Ne riceve “un sorriso sfumato di avidità, un sorriso pungente e ardito”. L’uomo risponde: “S’alza e poi dopo s’abbassa”. Come i contadini è incapace di allusione e il volo del fagiano è quello esplicito del suo sesso, di una voglia che “c’è, e punge. Ma.”. Il fagiano “‘va su, appena appena, delicato dapprincipio. E poi cade giù’. E quando dice ‘cade giù’, ride ancora. La sua felicità, diresti, è tutta affondata nel passato: eppure il presente, la manchevolezza del presente, gliela rende sempre salda, gliela fa concreta, attiva”. Perché la radice di noi stessi è il sesso, e il sesso è il tempo.
Dunque, mentre lo scrittore è assorto su una sedia avviluppato dal peso dell’età, da certe distrazioni, sente lo sparo. Una fucilata che rasserena l’aria. Il vecchio risale la collina come danzando. “‘Santino, ho sentito uno sparo.’ Lui, ‘quale sparo?’ ‘Sparo di fucile.’ ‘Ma la caccia è chiusa.’ ‘Appunto’”. Santino allarga le mani, le mostra nette dell’arma: “E che vi dico?… Si sarà schiantato un salice giù alla forra?”, “quando si schiantano fanno un botto come una fucilata”. Santino ha ora una stanchezza improvvisa negli occhi, va via tradito dalla coda del maschio che saluta dalla tasca posteriore del gilet. Ecco, Santino ha provato a congelare per sempre il tempo della sua vitalità in quel volo. Siciliano – con una voce umana, urgente – è rimasto a misurarne il mistero teso tra quel vecchio e la propria interiore ricerca.
Un racconto di Maurizio Corgnati
Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 18 del 28 settembre 2012.
——————————————
Cosa resta, oggi, nella memoria dei lettori, di Maurizio Corgnati? paradossalmente – se ne intuirà il perché – poco o niente; tranne, forse, la sua decennale, burrascosa vicenda d’amore con l’allora “Pantera di Goro”, la cantante Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, lungo gli anni Sessanta. Ma non è da escludere, come pure è stato detto, che abbia pesato il fatto che Corgnati (1917-1992) sia stato, in vita, tante cose, benché laureato in legge: giornalista, regista teatrale e televisivo, grande gastronomo, appassionato musicologo, critico d’arte ed esperto d’antiquariato ma, più di tutto, – come scrisse di se stesso – “obbligato” ad andare a caccia “da una forza sorella a quella che spingeva Dostoevskij al tavolo da gioco”. Scontando, dunque – come ricostruito da Beppi Zancan –, di non poter “essere definito uno scrittore a tempo pieno”, pur conoscendo tutto della scrittura. Dimostrazione ampiamente datane in saggi e libri dello spessore de “Il tarlo”, letterariamente ambiziosi e dal “linguaggio complesso e studiato”.
Sfaccettature e capacità che, però, non passano inosservate a uno dei più grandi intenditori di cose editoriali del secondo Novecento, quel Raffaele Crovi che ne scovava, postuma (siamo già nel 1995), una raccolta di racconti per la collana – precisione del caso! – Fantasia & Memoria, la più importante della casa editrice milanese Camunia, fondata dallo stesso Crovi nel 1984 e interessata, tra l’altro, alla mescolanza tra linguaggi di diversa provenienza.
Il libro – è stato notato sempre da Zancan – non è una comune raccolta di racconti, quanto di “brani autobiografici”, ma senza una precisazione circostanziata di fatti, senza nessun intento ricostruttivo o storico. Si tratta di una sorta di frammenti (scritti dall’autore poco prima di morire dopo una lunga sofferenza) dove si incrociano volti e amicizie, campagne, laghi e fiumi, animali e tanta passione venatoria: insomma, “tutta quella parte della vita che non è ufficiale ma scorre nei momenti più liberi che ci sono concessi. Quella parte della vita che può sembrare accidentale, che compare dove non era attesa, né dal cane né dal cacciatore”, come la beccaccia del racconto che dà anche il titolo, dall’atmosfera misteriosa, a tutto il libro.
Il fatto è che si ha l’impressione che, per Corgnati, la realtà, tutta la realtà esterna, spazio e tempo, pare non possa esistere oggettivamente, ma solo come parto della mente. Poco prima di morire – la storia è riportata da Marisa Fumagalli in un “Corsera” del marzo ’92 – lo scrittore, rivelando a Ludovico Terzi di aver elaborato a casa una ricetta per cucinare il cinghiale togliendogli il gusto di selvatico, gli dice, in ospedale: “Stanotte ho ripensato al cinghiale… l’ho assaggiato… no, non è ancora a puntino”. Tuttavia, tutta la realtà è ricostruita dalla memoria (necessariamente imprecisa o espressiva) che, come un acquerello, può rapprendersi precisa nel colore oppure confondersi col sogno o sconfinare nel fantastico, liberare sensazioni (il profumo di una cartuccia sparata al mattino dal padre, ad esempio), scoprire misteriosi passaggi per luoghi sconosciuti, o abbandonati.
Con un linguaggio completamente diverso dai precedenti libri – sempre colto, certo, ma allo stesso tempo colloquiale, urgente e intimo come se raccontasse a se stesso e a pochi amici – Corgnati ricorda, allora, la mattina di un 3 novembre. Il giorno prima ha nevicato e poi piovuto, bagnando le colline, ma gli indugi sono rotti da un sole che sale e scalda, e dagli occhi dei cani, forse un bracco e una setter, che ridono di voglia tra i castagni e le querce, “una vigna ogni tanto”, i fazzoletti di felci. L’anno è irrecuperabile, ma importa se il tempo, appunto, lo si ha ormai dentro come fosse ora, qui, sempre presente? La setter giunge sparata, consente al bracco e il sangue è già in tumulto: “Fulmineamente, tutte le ipotesi” sul piazzamento più favorevole per le starne, per la lepre. “Ma no, son tutti arzigogoli inutili… lo fai apposta a pensare ad altro perché non vuoi dirti quello che è” e che anche i cani sanno: una Regina, preziosamente rara da quelle parti, una beccaccia che prima non c’era e inventata, per un errore?, dai cani. È a questo punto che il tempo e lo spazio si distorcono (la realtà torna dal passato con un volto inedito) e la beccaccia – in una pagina davvero memorabile di letteratura – nella sua invisibilità, ma per il fatto stesso di esistere, obbliga il cacciatore “e i cani e il bosco e il tempo alla definitiva immobile perpetua infinità”, in una zona d’ombra che è opaca eppure placata, quasi desiderabile. Fino all’improvviso rombo metallico, i nervi che sparano, la beccaccia abbattuta: “tutto intorno alla sua morte” può così rinascere alla vita, “in un’orgia di rumori e di moti, mentre i cani freneticamente” cercano “la preda puntata dall’altro”. “Solo la Regina, la beccaccia, poteva salvarci”.

Recensione a: Serena Gaudino, Antigone a Scampìa (Il Primo Amore/Effigie, 2014)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata» lunedì 29 giugno 2015.
_____________
Che suggestivo titolo l’Antigone a Scampìa (Effigie/Il Primo Amore 2014, 128 pp., 12.00 €) di Serena Guadino. Enigmatico, come forse apparve ai suoi lettori il Cristo si è fermato a Eboli di Levi prima di addentrarsi nel suo sangue. Un libro che mai evita, al femminile, di confrontarsi con una tradizione meridionalistica di ricerca e impegno già avviata con quel “Cosa vorremmo tenere e sviluppare, e cosa cambiare nella vita di questa zona?” che, nei primi anni Sessanta, Danilo Dolci pose ai contadini delle sue Conversazioni.
E dunque, cosa ci fa Antigone a Scampìa? E perché la partenopea Serena Gaudino, fin qui musicologa e giornalista, scrittrice di racconti e storie per bambini, l’avrebbe condotta fino al quartiere dell’estrema periferia Nord di Napoli – circa quattro chilometri quadrati, settantamila abitanti, tra registrati e non, che mette accanto classi e etnie della più eterogenea provenienza, lumpen e classi medie, immigrati e “deportati” del dopo terremoto – su cui, più efficacemente di altri, Saviano ha saputo accendere i riflettori sul suo degrado dopo anni di dimenticanza quasi totale?
Scampìa, in napoletano, indica un “incolto improduttivo”, un terreno non coltivato o un ex-campo poi abbandonato. Valutazione topologica oggettiva e priva di ulteriori implicazioni valoriali in un mondo largamente ancora dominato dalla cultura contadina, dove di scampìe ce ne sono sempre state tante in ogni paese. Ma che non ha mancato di segnalare scivolamenti di senso sul piano morale man mano che la periferia metropolitana a nord ne ha inglobato l’area, infine imponendola all’opinione pubblica come luogo del degrado. Un posto fatalisticamente segnato e condannato già nel nome anche da giornalisti impegnati a rivelarne il malaffare di camorra: “Scampìa ha la condanna incardinata nel suo stesso nome. La fotte pure l’etimologia”. Un giudizio tanto persistente quanto avvitato in bizzarre contraddizioni. Se, infatti, quella Scampìa, tra le altre, è stata lottizzata e riempita di palazzi e condomini “grazie alla legge 167 che, fino a che prendesse piede il nome attuale, serviva per indicare il nuovo quartiere a nord della città, accanto a Secondigliano: ’A Cientesissantasette”, si può, poi, concludere con un “be’, viene da rimpiangerlo quel nome che faceva un po’ New York, anche se si andava, nella numerazione, ben oltre Harlem, verso il Bronx”?
Eccola, allora, Scampìa sinonimo di “scampare”, di “scappare”. Mentre dovrebbe essere ribattezzata “Accampìa”, cioè un luogo dove il mutamento storico torna a misurarsi contro ogni presunta invariante antropologica. Scampìa non più soltanto, allora – dice Gaudino –, non luogo di cemento da attraversarsi velocemente in auto come un palombaro con lo scafandro, ma un quartiere restituito agli abitanti, ai suoi attori principali, riconquistato dalle istituzioni e dalle associazioni che operano, dal basso, in quella porzione di territorio. In tal senso, la stessa struttura del volumetto della Gaudino non sembra mai porgere, al lettore, la frantumaglia di un mondo per cui poco può valere mettersi a incollarne i cocci. Le sue pagine, invece, accumulano e dispongono svariati materiali di riflessione (“Alfabeto Scampìa”, ad esempio) solo apparentemente eterogenei ma, al contrario, già capaci di anticipare un’organizzazione di senso ancora non risolta, certo, ma già propositiva e in cammino sul piano degli obbiettivi. Segno di un tempo che cambia.
Dopo un lungo impegno al progetto culturale del “Centro Hurtado”, Serena Gaudino diventa socia di “Dream Team – Donne in rete per la RiVitalizzazione urbana”. L’associazione, fondata da Patrizia Palumbo, propone alle donne del quartiere un progetto educativo alternativo ai normali piccoli interventi di formazione affidati al volontariato. L’idea è quella “di promuovere un percorso che, partendo dal loro vissuto, le invitasse a riflettere sulle loro condizioni di vita” favorendone il cambiamento. La Palumbo apre, così, uno sportello d’ascolto che accoglie le socie, ma offre loro anche tempo per ascoltarne il disagio, le storie, tutto quello che non si potrebbe riferire nemmeno “al confessore e men che meno alle assistenti sociali”. Nel frattempo la Gaudino si è imbattuta in un piccolo libro, il racconto di Antigone che Simone Weil aveva iniziato, con alterne fortune, a scrivere attorno alla metà degli anni Trenta del Novecento; e ha fatto conoscenza con Beatrice Monroy, una cantastorie siciliana interessata alla narrazione dei classici letterari che la incoraggia su questa strada.
Dunque, per un anno intero, tra il 2008 e il 2009, più o meno alla fine della cruenta guerra di camorra che aveva travolto Scampìa, Serena Gaudino ha narrato a un gruppo di una cinquantina di donne la storia di Tebe, di Laio, di Edipo e di Antigone: “perché, come scriveva Simone Weil, solo la grande poesia greca riesce a parlare al cuore delle persone, inducendole a riflettere sulla propria condizione di vita”. In seguito sono iniziati i racconti delle donne che, “immedesimandosi nell’eroina sofoclea e trovando analogie tra la loro lotta e quella di Antigone, hanno iniziato a rileggere la loro vita alla luce del mito e a darne una nuova autentica interpretazione”. Struggenti le pagine della madre che racconta la morte del figlio Tonino, vittima innocente di un agguato di camorra, esposto al fuoco perché i suoi problemi motori non gli consentono di fuggire in tempo. Oppure drammatiche quelle della donna che vuol darsi fuoco perché stretta, lei e il suo giovane figlio, tra le violenze degli spacciatori del quartiere e quelle della polizia, fino a condizionarne pesantemente persino i ritmi di vita.
Serena Gaudino porta, così, Antigone a Scampìa prendendone il testimone da Simone Weil, la grande figura dell’emancipazione sociale e femminile che, per prima, sperimentò un analogo confronto tra la condizione delle operaie inglesi e quella delle donne della tragedia greca. Con l’intenzione di sollecitarne, attraverso il coinvolgimento e l’identificazione, una maggiore presa di coscienza e una più forte convinzione al cambiamento. E tuttavia l’Antigone di Scampìa, più delle altre, trova, nella sua base sofoclea, la tragedia tutta moderna di un più profondo scarto nomologico tra il concetto di giustizia, rettitudine e amore da un lato e di legalità e diritto dall’altro, ponendo così in essere una figura di forte complessità anche tra il binomio individuale “diritto/amore” riflesso in quello collettivo “oppressione/rivendicazione”.
È così che, grazie all’esperienza sul campo con le donne di Scampìa, la Gaudino ci consegna un’interpretazione nuova e originale al mito sofocleo, che fin qui ha spesso letto, troppo nettamente, l’Antigone come beniamina positiva di una giustizia antisistema. Certo Antigone resta una “vittima che rivendica la legge dell’amore” e la “salvezza della memoria, verità e giustizia”, ma nello stesso tempo sa vestire anche i panni del boia e dell’aguzzino, se è capace di coinvolgersi nelle logiche di camorra, rivendicando “la validità del crimine contro chi ha ucciso i loro famigliari”: il Creonte che sorveglia, perseguita e punisce senza riuscire a soccorrere, ma anche custode dell’imparzialità della Legge dello Stato. “Solo chi non conosce la situazione può pensare, troppo ottimisticamente, che le donne di Scampìa si identifichino in Antigone solo contro il Sistema camorristico. Le donne di Scampìa si identificano in Antigone contro tutti i loro nemici, che possono essere sia il Sistema che lo Stato… sono madri che scendono in piazza e mogli che piangono i mariti; madri che difendono i figli ma che alle volte, purtroppo, sono costrette anche a seppellirli; possono essere donne di camorra e contemporaneamente madri, alla ricerca di una voce che traduca in richieste d’aiuto i loro gesti”. Antigone è, dunque, una testimone: la testimone dello scontro, scrive la Gaudino, “tra la coscienza privata e l’interesse pubblico” in un conflitto irrisolvibile “perché entrambi hanno ragione”.
E tuttavia, pur ormai lontani dagli anni in cui compiva il suo esperimento (parliamo del periodo dopo il 1934, quello delle Riflessioni, in Italia raccolte in un libro Adelphi a cura di Giancarlo Gaeta), più di un’eco delle riflessioni della Weil rimane leggibile tra le pagine dedicate dalla Gaudino a Scampìa. Perché, pur riconfermando la fiducia nella rivoluzione, la Weil non ritiene ormai più possibile conciliare quell’ideale, per lei antiautoritario, con il consolidamento di un’élite di rivoluzionari di professione ben presto, a scapito della classe operaia, trasformatasi in una casta burocratica (tanto quanto le tecnoburocrazie occidentali). È possibile che presa del potere e liberazione possano coincidere? E, per contro, è davvero possibile rinunciare all’azione organizzata? E, se in tutti e due i casi la risposta fosse negativa, quale sarebbe allora la via d’uscita? La risposta di Simone Weil, pur provvisoria, è la sua discesa all’esperienza di fabbrica, tra le operaie, la rivendicazione di una centralità negata, schiacciata da un sistema sociale oppressivo impermeabile a ogni teoria sull’ineluttabilità della sua eliminazione per via dell’operare storico delle forze dello sviluppo. Vale invece avere coscienza che ogni progresso nasce, invece, dall’azione responsabile di individui e gruppi che incidono realmente in una realtà sociale chiaramente definita. Saremmo così, allora, non al recupero di un generico e moraleggiante riformismo, ma a una vera e propria “resistenza attiva” tra le smagliature del potere e dell’oppressione sistemica.
Premio “Carlo Levi” ad Aliano. Tra calanchi e letteratura
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», lunedì 1 dicembre 2014.
___________
Ero ad Aliano, a seguire la riuscita cerimonia di consegna del “XVII Premio letterario Carlo Levi” e, confesso, anche per godermi ancora una volta il paesaggio così assoluto dei calanchi che già mi aveva entusiasmato quest’estate, in occasione del festival di paesologia. Mi è parso di leggere alcune difficoltà durante lo svolgimento del premio che, a questo punto, avrebbe bisogno di poter spiccare un ben più deciso salto di prestigio e autorevolezza. Nulla di irrisolvibile, ovviamente, anzi. Però vorrei ragionarci ora, a bocce ferme.
Intanto la mattina, i vincitori del premio e i loro libri, sono stati presentati dagli ormai mitici Don Pierino Dilenge e Raffaele Nigro alle scolaresche di alcune medie superiori del circondario.
A parte qualche breve lazzo di alcuni studenti nella parte superiore della sala, è accaduto che solo una studentessa abbia posto una domanda a Laura Pariani e solo una docente si sia avventurata a chiedere una curiosità all’ottimo Ettore Catalano. Il resto della truppa è rimasto sprofondato in un diuturno silenzio. Solo colpa della solita scarsa attenzione studentesca – e ce ne laviamo le mani?
Bene ha fatto Nigro, allora, a richiamare un maggiore sforzo organizzativo del Premio in sinergia con le scuole del territorio, perché occorre che la concentrazione e il coinvolgimento a una cerimonia di tal genere sia sollecitata da una lettura e da una riflessione (anche sul contesto) degli studenti, per almeno qualcuna delle opere, che preceda l’incontro. E, del resto, sarebbe più proficuo cercare di rendere istituzionale l’appuntamento con le scuole medie superiori anche attraverso la proposta, ogni anno, di una data più certa e stabile della manifestazione. Così come gioverebbe osare una formula meno “classica” e più interattiva di incontro tra giovani e scrittori che non sia solo quella delle valutazioni e degli spunti provenienti dagli scrittori il giorno della premiazione.
Non lo so, ma presumo che questa sia una questione (sempre dolorosa, e non solo per il “Carlo Levi”) di fondi – l’acquisto dei libri da diffondere nelle aule, il noleggio degli autobus con cui trasferire le scolaresche, il budget comunale ecc. – o, in altri termini, “una croce”, di cui non si può far ulteriormente carico chi si sbatte, e parecchio, per assicurare ogni anno la piena riuscita della manifestazione. E il discorso, mi pare, valga anche per la scuola, sempre alla canna del gas per quanto riguarda budget, fondi, possibilità, così come per i tempi di preparazione specifica da parte di insegnanti e studenti.
Un altro punto. Il pomeriggio, nonostante la formula del premio fosse stata invertita nell’ordine degli interventi, privilegiando, come giusto, prima l’escussione degli scrittori e delle loro fatiche, i politici hanno fatto la loro passerella serale al Premio. Non mi pare uno scandalo, se a loro si debba pure l’accesso ad alcuni fondi o la formulazione di proposte valide. Però mi ha sconcertato non poco che tre uomini di politica– mentre il pubblico sciamava via inesorabile – abbiano complessivamente parlato un tempo superiore a quello che i quattro scrittori e i due conduttori hanno utilizzato per confrontarsi in una sera a loro dedicata. Un tempo tra l’altro, m’è parso, parzialmente sprecato a parlare di cultura con un’idea, a un certo punto, francamente generica, rimbalzando tra tematiche e suggestioni le più disparate. Alla fine anche il pubblico, ormai poco lucido, non so quanto sia riuscito a far propri discorsi che, ad averli resi più sobri e più centrati sulle esigenze del Premio e sulla cultura del libro – quella cui Levi tra gli altri, ha completamente dedicato genio, esistenza e dolori – avrebbero reso certo un miglior servizio alla serata e agli intervenuti. Perché, a ben guardare, in mezzo al fumo un po’ d’arrosto c’era.
Comunque sia, il problema pressante mi pare essere derivante dalla scarsità oggettiva dei fondi per il Premio a seguito della crisi economica (che, però, non mi pare affluissero abbondanti alla cultura nemmeno ai tempi in cui le vacche erano grasse) e di una questione, quella culturale, anche per il governo Renzi inesorabilmente e “tremontianamente” non prioritaria in agenda. Occasione che spinge i politici di ogni risma a trincerarsi dietro un generico “potremo, vedremo, faremo” confidando in un uditorio ormai ipnotizzato da vent’anni e passa di berlusconismo a stare perennemente con le mezze maniche estive invece che con il vecchio maglione di lana di nonno Enrico Berlinguer.
Un altro problema verte, invece, su come meglio veicolare i libri premiati – se nelle scuole magari in accordo con gli editori attraverso particolari sconti, solo per fare un esempio banale.
Sono tra quelli che, pur auspicando più provvidenze di legge (e meno scellerate) a sostegno dell’editoria, vanno da anni ripetendo la formula – diciamo così – “concordataria” riassumibile nella formula: “libera istituzione in libera editoria”. Perché se una Regione si costituisce essa stessa come editrice allo stesso tempo facendosi sostenitrice economica della locale editoria, va da sé che la scelta abbisogni di una concertazione massimamente chiara per non creare inevitabili conflitti tra le parti o, peggio, esiziali “infiltrazioni”. Sarebbe cioè preferibile un sostegno “a valle” e mirato al sostegno dell’acquisto, diffusione e lettura del libro, tra cui, spiccherebbe un appoggio più deciso alle librerie (o di ciò che ne resta) sul territorio.
Mi pare Lacorazza abbia accennato (e occorrerebbe rifletterci meglio) a un punto importante: cosa può fare la politica perché gli intellettuali lucani possano frequentarsi e – se fuori – ritornare più spesso in Lucania attirati da momenti di più frequente elaborazione e proposta culturale? A mio avviso, lo dico convinto a Lacorazza, poco servono nuove riviste così come nuovi cenacoli dell’autoreferenzialità. Servono, invece, momenti di confronto aperti tra vari attori della cultura (pittori e poeti, fotografi e critici o saggisti ecc.) e di questi con la gente lucana. Come si può fare, allora, se non con incentivi a circoli e librerie meritevoli, se non con un adeguato sostegno alla lettura scolastica e giovanile?
E perché le scuole? La Basilicata è tra le ultime regioni in tutte le classifiche nazionali per la lettura dei libri, anche grazie alla forbice negativa tra istruzione e reddito medio regionale. Dunque gli investimenti – che chi di dovere dovrebbe fare – possono lasciare una traccia duratura quasi solo nella fascia di lettori oggi potenziale: i preadolescenti e gli adolescenti (chi ha la mia età ormai se non legge già ora, difficile sviluppi il tarlo). E devono essere investimenti non solo dedicati all’acquisto del libro in quanto tale, ma alla sua lettura. I salotti buoni delle famiglie lucane sono già piene di enciclopedie e altre opere acquistate nei ’70 e quasi mai sfogliate; e, allora? siamo punto e a capo. Altre idee possono essere le visite alle fiere, l’uso mirato di internet, piccoli corsi sull’editoria e sulla lettura, premi per i più piccoli, incontro con scrittori ed editori, incontri con giornalisti ed edicolanti per meglio capire la lavorazione di certe filiere, con i restauratori di opere antiche ecc ecc.
Insomma, non si tratta solo di acquistare un libro, ma di giungere alla consapevolezza che il libro è uno strumento teorico-tecnico per imparare o un modo per accedere a una qualche notizia del mondo, a un’esperienza di vita che possa renderci meno provinciali. È questo che fa, oggi, anche il premio Levi che, come ha detto il sindaco di Matera Adduce, potrebbe entrare in una fase propulsiva virtuosa se la sua città riuscirà a proporsi come Capitale culturale d’Europa capacedi scambio intellettuale proficuo con l’intero territorio su cui poggia.
Fin qui, luci e ombre della politica. Ma la crisi italiana è crisi non solo politica, e mostra i limiti e l’inadeguatezza di un’intera classe manageriale e dirigente. E dunque anche imprenditoriale, bancaria, del management regionale. Una classe dirigente incapace di pensare a uno spazio pubblico che non sia né contrapposizione né commistione tra stato e privato, bensì terreno neutro – sia pur non neutrale nell’impegno – di collaborazione, scambio, crescita tra parti.
Sono stato recentemente al “Festivaletteratura” a Mantova: nella brochure di invito tante sigle di banche e investitori piccoli e grandi che si sono impegnati, anche senza un ritorno economico immediato, nella riuscita organizzativa dell’evento. Certo territori ricchi, ma noi parliamo di una piccola eccellenza realizzata in una terra di bellezza sconvolta e sconvolgente, che porta il nome di uno scrittore tra i più grandi del Novecento! Un premio di caratura e di ulteriore potenzialità nazionale e internazionale che ha già dimostrato, con le sue diciassette stagioni, di stare più che bene in piedi.
E dunque, lo dico qui con un termine toscano, che qualcuno “si frughi”. Ma ci sta che le compagnie di autobus per il trasporto delle scuole (faccio solo un esempio) o le banche, pur intenzionate, abbiano trovato nelle tasche ricci di castagno. Eppure, se il territorio non si promuove, non si sostiene anche nella sua crescita culturale, mi chiedo, quale possibile o ulteriore sviluppo può avere?
La Notte Europea dei Ricercatori è Made in Lucania
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», domenica 12 ottobre 2014.
_____________
Lucani che si confermano. Vale a dire Francesco Larocca, lagonegrese, oggi docente di scienze dell’Istituto Salesiano Villa Sora a Frascati (Roma) e vicepreside di quel Liceo Scientifico; soprattutto instancabile mediatore culturale: una figura, quest’ultima, di cui oggi in Italia c’è disperato bisogno. Iniziò, nel febbraio 2012, con l’acquisto di quattro telescopi, attorno al quale aggregò il gruppo di astrofili “Segui la Stella”. Un’associazione che oggi alterna anche incontri con personalità del mondo scientifico e sessioni d’osservazione dello spazio.
Così, anche quest’anno, l’istituto è stata autorevole sede della “Notte dei Ricercatori” e partner di “Frascati Scienza”, un’organizzazione costituita da tremila scienziati, otto istituti e ben tre università. A cominciare dal 25 settembre, per finire il 27, offrendo un programma davvero ricchissimo, mossosi tra sessioni di osservazioni dello spazio tenute da Gianluca Masi, del locale osservatorio “La Torretta”, mostre fotografiche su “Il lavoro dell’uomo e la natura” (foto e allestimento realizzati dai fratelli Angelo e Francesco Larocca), percorsi didattici, sbandieratori teatrali di Borgo Spante e, più in evidenza, conferenze. Queste ultime a partire da quella di Roberto Somma (dirigente di Thales Alenia Space Italia) sull’osservazione della Terra dallo spazio come strumento a supporto della sostenibilità del Pianeta; per continuare con quella accattivante del biologo marino Luciano Bernardo, che ha parlato dell’importanza dell’osservazione diretta nella sua disciplina, a partire dai tesori lasciati a riva dalle onde; fino a quella sui “Nuclei fondanti dell’apprendimento significativo”, lectio dello psicoterapeuta dell’Università di Tor Vergata Filippo Pergola.
A chiudere, il 27 settembre, le giornate – ormai lo si sarà compreso, virate sui temi dell’ecologia come scienza e sulla correlata sostenibilità planetaria – Salvatore Curcuruto, dirigente dell’ISPRA, sulle nuove tecnologie di illuminazione urbana LED e il loro impatto ambientale.
Tuttavia, anche quest’anno, mattatore dell’incontro, il 26 settembre, è stato senza dubbio Davide Giacalone (opinionista per RTL e di “Libero”) che, in anteprima sull’uscita in libreria a ottobre, ha presentato la sua ultima fatica “Senza paura. Per non perdere il bello di un mondo migliore” stampata per i tipi della Rubbettino (pagg. 296, 15.00 €). Tanto in anticipo, grazie alla tempestività di Larocca, da essere presentato allo stesso autore prima che l’editore riuscisse a fargliene avere copia.
Il libro, nato un po’ per caso a partire da considerazioni empiriche sulle conseguenze psicologiche della crisi economica ancora in atto sugli italiani, parte dalla ragionevole constatazione che “Scansati i tempi paurosi” del passato “ne abbiamo creati di impauriti” di cui la radice è “l’aspettativa che le cose possano andare peggio di come sono andate e di come vanno”, soprattutto per i figli. Una paura tale da cogliere, perché osservatore necessariamente coinvolto, anche il nostro autore sia pure, però, in un senso totalmente positivo se essa “salva la vita” facendoti “avvertire il pericolo, mentre la perde e rovina se induce a un tremore paralizzante” o trasformandosi in rabbia sociale. Di fronte a ciò, secondo Giacalone, bisognerebbe fermarsi a ragionare per essere più consapevoli.
Tuttavia, mentre la conferenza di presentazione a Villa Sora ha girato intorno a tematiche parecchio spinose, pure dal punto di vista del diritto, ma più circoscritte (ogm, eterologa ecc.) e in difesa della scienza dal pregiudizio e dall’accusa di nutrire appetiti faustiani sul nostro mondo, in realtà le pagine del libro aprono a problematiche ben più ampie, dall’economia e dalle politiche fiscali fino alla famiglia e al “declino del maschio”, dal problema immigrazione ai fondamentalismi (ben presenti anche in occidente) alla sovranità europea. Per esortarci ad aver la fibra di andare, seguendo una via pragmatica di ritorno alla realtà e di consapevolezza delle difficoltà, oltre i vuoti ottimismi o i facili, persino interessati, pessimismi. Certi che di fronte agli sconquassi della crisi che andiamo attraversando: “non ci aspetta il cilicio, per redimerci dal peccato, non è auspicabile alcuna stagione penitenziale. Ma neanche ci aspetta un’interminabile ‘happy hour’, nell’incoscienza dell’inutilità. E fortunatamente, perché la pausa, senza il precedente e successivo impegno produttivo, finisce con il somigliare orrendamente al vuoto”. Insomma, commentando Croce, scegliendo uomini sì onesti e integri, ma pure preferendoli “per capacità e forza realizzativa, altrimenti la vita collettiva si corrompe nella stagnazione e degenera nel declino. Che, se anche onesto, è ben gramo destino”.
“Messo a tacere”: Quel Mundtot tra musica e impegno civile. Intervista a Marco Lenzi
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», domenica 24 agosto 2014.
_____________
In Calabria, si sa, la ruggine non la fa l’acqua, ma le uova. E così, nel febbraio di un ormai lontano 1991, a un gruppo di giovani viene l’idea di lanciarne alcune su un circolino. È carnevale e la burla, pur sopra le righe, potrebbe finire là. Ma siamo nel reggino, nel comune di San Luca, e qua le cose tutti sanno come iniziano, ma nessuno può dire come vanno a finire. Un uovo colpisce la macchina sbagliata e nasce un litigio con tanto di spedizioni punitive. Durante una di queste ultime, un giovane aggredito si “spagna” e spara, uccidendo due persone e ferendone altrettante. E, di lì a poco, finisce per fare la stessa fine.
La Calabria, si sa, è un paradiso dove i diavoli sono di casa. E ci sono le ’ndrine, tra le quali il litigio deflagra: quella dei Pelle-Vottari e quella dei Nirta-Strangio. Dunque 1991, 1993, e poi 2005, 2006, 2007. Gennaio, agosto, persino a Natale: non c’è mese, non c’è giorno, non c’è luogo (San Luca, Casignana, Bovalino) che non possa essere quello buono. I conti si saldano. Affiliati, parenti, amici. Paga a chi tocca. Se non fosse che quello della ’ndrangheta è un mondo capovolto e sempre finisce che, al momento del saldo, il debito, invece di chiudersi, s’allarga.
La Calabria, si sa, è terra che alla storia bada poco, e però ha memoria radicale delle offese. Si chiama “faida”. Un termine, “fēhida”, che ha viaggiato nel tempo e nello spazio prima di avvelenare questa terra meridiana. Una radice alto tedesca, “fēh”, “nemico”, che già nella pronuncia ha l’urgenza di colpire: un’empia violenza che il diritto germanico cercò subito di mitigare. Tuttavia, le ’ndrine son caparbie, hanno saputo rendere la pratica alla sua antica, nuda ferocia. Riportandola ai suoi antichi inventori quando ormai non la conoscono più e ne sono indifesi.
Il “regalo” arriva a ferragosto a Duisburg, grosso centro nella Renania settentrionale-Vestfalia, all’uscita, pare, da una cena di compleanno consumata al ristorante “Da Bruno”. Fa sei morti con nessun risparmio di proiettili. La Germania si risveglia incredula di fronte a fenomeno che gli par nuovo, ma che i locali inquirenti già conoscono pur non concedendone spiegazioni.
Di tutto questo si accorge Jürgen Alberts, scrittore di gialli che, per i suoi libri, si è già occupato di crimine organizzato e di triadi cinesi. E come tutti, più di tutti, rimane scosso dalla strage. È allora che si convince a indagare meglio, incuriosito da un paio di articoli pubblicati in Italia che riportano le confessioni di Giorgio Basile sui riti di affiliazione alle mafie. E si tuffa in una ricerca che lo cambia.
Scrive Alberts: “Quando progettai di scrivere il mio libretto per ‘Mundtot’ – ‘Messo a tacere’ – dovevo trovare inizialmente una forma per una semplice ‘pièce’ teatrale – che si configurò come un processo giudiziario nel quale il testimone ‘canta’ e solleva il velo che copre il crimine organizzato”. Alberts legge “Gomorra”, si chiede come le mafie riescano a far soldi con i rifiuti (nel testo sono citati anche seicento barili di rifiuti tossici che la mafia avrebbe “smaltito” in Basilicata), quale sia il legame con la società civile, la loro capacità di resistenza alle intrusioni esterne. E, con un linguaggio semplice e diretto, “perché la gravità dei suoi contenuti è tale da non consentire al pubblico di venir distratto da esperimenti formali”, rivela alla Germania quanto pure la società tedesca possa essere permeabile alle mafie. E a noi come i tedeschi ci guardano.
Capita che a musicare il libretto sia chiamato un livornese, Marco Lenzi, che resta colpito dal testo, che nulla concede alla retorica e al compiacimento lirico nel racconto dialogato in dodici arie chiuse o “canti”. Pur nel sarcasmo cui spinge la denuncia morale. Musica che mai soffoca il testo, molto ben adattandosi, tra l’altro, alla cultura teatrale e al cabaret espressionista tedeschi, e impregnata di colonne sonore, di rock e di psichedelico o di moduli espressivi musicali ripresi dalla folk song, dal Lied (“Canzone tedesca”), dal rap, alternando canto, “Sprechgesang” (“canto parlato”) e voce recitante.
In Germania, la rappresentazione di “Mundtot” riscuote buona eco. Arnsberg, Bremen. E tuttavia accade che, in Italia, il testo non sia stato ancora rappresentato. Perché? Mistero. Che proviamo a dipanare proprio con Marco Lenzi, classe 1967, musicologo che ha al suo attivo diversi saggi e la prima monografia italiana su Morton Feldman. Le sue composizioni sono stati eseguite in Europa e Stati Uniti.
Inizio subito con la domanda che ti aspetti: chi ti ha contattato per questo lavoro e perché?
Dunque il lavoro ha avuto una lunga gestazione, conclusasi solo nel 2012. La prima telefonata la ricevetti, invece, nell’estate del 2008 da un carissimo amico livornese emigrato e che ha girato mezzo mondo prima di stabilirsi in Germania: Alessandro Amoretti, pianista compositore, collaboratore di enti lirici. Alessandro mi chiese se fossi stato disposto a musicare un libretto operistico, “Mundtot”, firmato da Jürgen Alberts, figura poliedrica di scrittore. Avrei dovuto scrivere l’opera per il 2010, anno dedicato alla cultura europea nella Ruhr; ma subito un rap (che poi è diventato la quarta aria dell’opera) perché potesse essere rappresentato a un festival del crimine a Unna (i “Krimifestival” sono là molto sentiti e coinvolgono artisti di varia estrazione). Dopo questa rappresentazione iniziai a scrivere mano a mano le altre musiche del libretto nelle sue successive versioni, anche perché i tempi erano, nel frattempo, slittati. E così la prima dell’opera fu rappresentata nel 2012.
Ti sei fatta un’idea di come guardino i tedeschi al fenomeno mafioso in relazione all’Italia a seguito della strage di Duisburg? Perché nell’opera non c’è solo uno sguardo fosco, ma anche punti e personaggi positivi: il PM, la “Baronessa coraggiosa”, la memoria di Fortugno…
Sì, è vero, è crollato un po’ questo castello folkloristico della mafia e del crimine organizzato italiano come nota locale, forse risibile, di colore. Dopo i fatti di Duisburg lo sconcerto è stato grande, così come il clamore suscitato. Non era più una questione di pizzo e questioni tra famiglie italiane. Sulla strada, davanti a tutti, c’erano morti ammazzati in tutta la loro tragicità. È venuta meno pure una certa idea di Germania, scopertasi più fragile, meno pronta ad affrontare certi episodi: la prima vibrata reazione alla strage fu quella degli italo-tedeschi.
A questo punto viene data la prima ad Arnsberg con ottima affluenza di pubblico.
La sala era piena. Curiosamente la rappresentazione è stata data in un tribunale, anche a scapito della capienza, problema cui si è sopperito dando ben due spettacoli in un giorno. Ma tutto questo ha restituito alla fine un effetto verità molto forte, rilevato tra l’altro dalla stampa, nonostante lì fossero state utilizzate solo basi musicali. A Brema, invece, l’opera è stata data in un teatro di prosa. Era chiaro che per quest’opera servissero cantanti attori e non cantanti lirici. Furono scelti quelli bravissimi, della Compagnia shakespeariana di Brema, con protagonista un italo-tedesco di Colonia Luca Zamperoni, che ha collaborato anche con Bob Wilson. Comunque sia, con pochi personaggi di un processo che recitano queste dodici arie chiuse, la forma è diventata più una musica di scena che un’opera. La sfida futura sarà quella di dare alla musica più peso, cioè con i dodici momenti messi maggiormente in evidenza e con il cantato a essere interrotto poche volte dal parlato.
Che riscontri hai avuto in Italia dopo la rappresentazione dell’opera?
Beh, l’opera è piaciuta molto, tanto da riscuotere il plauso di un Bob Wilson. Intanto un bravo regista livornese che è Emanuele Gamba pure l’ha ascoltata e si è dato molto da fare per diffonderla, ultimamente inviandola al Direttore artistico del Comunale di Bologna Nicola Sani, che però non ci ha ancora dato risposta. Sempre grazie ad Emanuele siamo andati vicino alla rappresentazione teatrale con attori del genere di Claudio Santamaria e Beppe Fiorello. Un altro amico l’ha fatta girare in Trentino. Però in Italia, a queste premesse entusiastiche, nulla è seguito. Pur ponendo mente al fatto che i budget per la rappresentazione sono davvero risibili e il testo è ispirato a tematiche forti. Forse ha giocato, tra le altre cose, la mia inesperienza (questa è stata la mia prima opera) o il mio scarso peso “politico” nel sistema dei teatri.
E nella tua città, a Livorno?
A Livorno la situazione è stata paradossale, perché il “Goldoni” sembrava davvero interessato alla cosa, potendo così “sdoganare” l’opera in Italia. La cosa buffa è stata che, all’entusiasmo iniziale, sono seguite richieste di riduzioni progressive dell’organico e continui aggiustamenti di budget. Mi resi disponibile a riorchestrare l’opera per cinque tastiere, dunque per cifre irrisorie, ma nonostante ciò mi fu proposto prima di spostare tutto alla “Goldonetta” e, infine, addirittura mi fu proposto di rappresentare “Mundtot” in quella che mi venne indicata come la “sala specchi” che era, in realtà, la sala prove del teatro, poco più di uno spogliatoio seminterrato.
La motivazione?
Perché avrebbe accentuato il carattere di modernità, indipendenza e eccezionalità dell’opera rispetto a quelle più “classiche” in calendario. Un delirio, per un unico atto di un’ora.
E a Sud, dove i tentativi per una rappresentazione di “Mundtot” potrebbero trovare alla stessa maniera entusiasmi o qualche complicazione in più?
Sarei molto contento se il Sud potesse dare una risposta diversa, positiva a quella che mi è stata data fin qui (dove qualcuno pensa che, in fondo, una certa parte dell’Italia dalla ’ndrangheta possa essere, forse, immune). Sono disposto a realizzare l’opera traducendo il libretto e adattandolo meglio al gusto italiano.
Per me, quella di Mundtot, è stata un’esperienza formativa, perché da compositore non mi ero mai misurato con i fatti della criminalità organizzata e, su un altro piano, con la forma canzone. L’opera mi ha consentito di allontanarmi dai registri sperimentali marcati che mi erano soliti; qua invece ho usato di tutto. Forse il modello inconscio più forte è stato quello dei Pink Floyd, il finale di “The Wall”, insomma, tirando fuori dei temi culturali che mi erano cari, ma che non erano mai entrati nella mia musica. È stato un lavoro che ha messo alla prova il mio modo di comporre, per la prima volta confrontatosi con temi così forti e concreti.
Recensione a: Francesca Bonafini, Casa di carne (Avagliano, 2014)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata» domenica 20 luglio 2014.
_____________
Come ha già evidenziato Nicola Vacca in un suo recente intervento, è importante chiedersi anche qui, quanto, prima di costruire la sua Casa di carne (Avagliano, 156 pp., 14.00 €), Francesca Bonafini abbia frequentato, attardandovisi, le Camere separate di Tondelli. Un debito forse ancora troppo forte sebbene, peraltro, tranquillamente riconosciuto dall’autrice fin dall’esergo, giù fino alla struttura dei capitoli ordinati per “attraversamenti” in luogo dei tondelliani “movimenti”. Pure con quella lucida attenzione per lo stile e per il ritmo della scrittura, e poi con il piacere tutto particolare di narrare e dipanare l’intima e misteriosa relazione tra vita e morte, che furono anche dello scrittore dell’emiliana Correggio.
Dunque Angela, la voce narrante del romanzo, vende la vecchia casa di campagna allo spirare della nonna, ma ancor di più dell’amore con cui l’ha tirata su dopo la perdita dei suoi genitori –morti anche loro, ma mai ben conosciuti – per sradicarsi a Trieste, sul suo molo, ad aspettare un segno dal mare. Un mare, l’Adriatico, che si rivela alla fine inadeguato, spingendo la protagonista a un lungo, inaspettato percorso che le farà attraversare tutta la Francia fino ad acque d’altura più adeguate al suo destino.
Angela è un’inquieta: “sono abituata a cambiare casa, cambiare città, cambiare per poi ritrovarmi a piedi in strade sconosciute e imparare a camminarci. Alla fine, scoprire che non ho capito niente e che ancora mi confondo”. E quindi, più che i confini, alla giovane trentenne piacciono i crocevia, lo spostamento sempre un passo più in là che è la frontiera, che è ciò che allo spazio si abbandona – ma che pure si porta con sé – e ciò che si guadagna. Ne è più di un sintomo stilistico l’uso dell’anacoluto, della continua rottura sintattica della frase; fratture, sfasamenti che però, adottati e ripetuti, mostrano quanto sappiano farsi anche regola in una scrittura godibile come la musica inesauribile dei murales di Haring. E del resto sillessi significa, in fondo, prendere insieme, unire: raccogliere tutto il passato e il presente e gli opposti lungo un percorso.
E tuttavia Angela è solo apparentemente una nomade, perché cerca sempre di rinnovare la sua radice di provenienza, cioè il prendersi cura totalmente e gratuitamente dell’altro, amando: “perché cadere innamorati, io dico, non c’è altro di meglio che possa capitare, cadere innamorati è una faccenda che smuove le stelle e i pianeti e produce soluzioni alternative alla devastazione, e rinnovamenti, e bonifiche medicamentose”. Amare, per Angela, è desiderare: “luci che sono lontane, volerle tirare giù, farle vicine, portarle a terra, toccarle con le mani, lasciare che si incarnino. Così non saranno più remote incorruttibili, ma fragili e mortali”. Può essere, allora, solo il conquistato oggetto d’amore la definitiva casa di carne che segna l’arresto di ogni erranza, la caduta di ogni confine. Come un vestito, abbandonato il quale si può procedere solo nudi e disarmati in una passione totale.
Si rivela così, nella scrittura della Bonafini, qualcosa che ci pare tipico dell’etica protestante. Certo non nel senso del dovere kantiano, ma in quello di intima, umana “gratitudine” in risposta a una “grazia” di derivazione divina. Non Legge, ma Dono. Perché c’è, nella sua protagonista, un’ascesi weberianamente intramondana, un monachesimo inteso nella sua totalità di aspetti amorosi: “se capita il miracolo del trac, allora dentro l’amore ci metto tutte le energie ma proprio tutte, così qualcuno potrebbe pensare che dopo son stanca e mi stufo o mi stuferò, ma io dico che a essere innamorati le energie fioccano come la manna da ogni dove…”. E questo amore senza maschere, senza infingimenti – leale anche nel caso di sopravvenuto disamore – non può che elevare la protagonista a essere il personaggio normativo che l’altro rivela nella sua incompiutezza a ogni attraversamento, a ogni crocevia.
Succede a Trieste con Miriam, l’irrequieta studentessa di tedesco che le traduce i versi d’amore che Rilke scrisse nella vicina Duino, e si innamora di Angela pur stando con Davide. Un amore che Angela accetta e consuma pienamente, ma che rivela di Miriam una bisessualità in fondo convenzionale sul versante etero: il paravento socialmente rassicurante dischiuso di fronte a un padre violento e a un fratello omofobo. Non resta, così, che la paura; e Miriam preferisce, almeno fino a quando non riuscirà a svelare a se stessa la propria natura, il ritorno da Davide.
Ad Angela non rimane che partire, lasciandosi alle spalle i versi di Rilke (che, sia detto qui per inciso, coraggiosamente firmò per l’abolizione del Paragrafo 175 del Codice penale tedesco che prevedeva pene detentive per gli omosessuali), ma anche la Trieste che fu dell’iniziazione amorosa dell’Ernesto di Saba e delle terrificanti repressioni omofobe ancora oggi conservate nella memoria di San Sabba. Un motivo in più che fa, della protagonista di Casa di carne, non una nomade, ma una rabdomante capace di percepire e lasciarsi trasportare, nel suo percorso, dalla potenza sorgiva delle letterature, specialmente di ispirazione LGBT, capaci di scorrere, come un fiume carsico, sotto la superficie di luoghi e città, costruendone il genius loci. Letterature e parole che, per la protagonista di Bonafini, sono il segno della forza del molteplice e del differente.
Eccola allora con Alessio, sul continente, in terra francese. Alessio l’amico spiccio, il musicista con cui campa alla giornata accompagnandolo nei bistrot parigini. Alessio che non vuole più amare, che diffida di ogni donna, perché una l’ha tradito e, in qualche maniera, per sempre inaridito. Eccola attardarsi a Étretat, dove dipinsero Bodin, Courbet, Monet e dove scrissero Flaubert, Maupassant e Maurice Leblanc. Fino a essere attratta, come un oscuro presentimento, da quella lingua di terra che è il Finistère (finis terrae) bretone, che aggetta, come un altro lungo molo nelle acque di piombo dell’Oceano. Mare, marinai, presagi di morte che pure furono la carne di un romanzo quale Querelle de Brest, di un giovane Jean Genet, e poi dell’omonima pellicola che chiuse la carriera del regista Fassbinder nel 1982.
È qui che Angela incontra Tiago, il marinaio, la definitiva casa di carne da abitare in un mondo nuovo come Rio de Janeiro. Un amore etero, quest’ultimo, anche se l’amante color cioccolata tanto somiglia a quell’insaziabile Bom-crioulo dello scandaloso scrittore Adolfo Ferreira Caminha, brasiliano. Un amore finalmente totale, disturbato solo dall’apparire del germano tossico di Tiago, Mateus, che porterà la storia di Angela al suo epilogo di morte, davanti a un mare che guarda al Portogallo come un ponte interrotto. Un personaggio – il misterioso, cinico, ferito Mateus – che è l’ombra scura di Angela. E forse anche della stessa Bonafini, se la sua forza è capace di condensare, in questo suo romanzo, anche alcuni temi o frequentazioni di sue precedenti prove, Mangiacuore su tutti.
Insomma, alla fine dell’amore non restano che fumo e vanità che spirano da una bocca marcia, senza labbra e senza denti. E nulla può restare, andare o ritornare se, dove la casa di carne ha poggiato e bruciato troppo presto il suo tempo, è un lembo estremo di terra improvvisamente scivolata nel gran mare della morte. Una fine che però salva l’amore – e il lettore – da ogni dubbio di sua finale consunzione, se le sue spoglie possono tornare alle stelle sulla groppa immortale delle letterature.
Ezio Taddei, lo scrittore dei poveri confinato a Bernalda. Oltre 60 anni dopo, il ricordo dell’uomo che cammina.
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 2 febbraio 2014.
_____________
“Nessuno è profeta in Patria”. Vangelo. Destino tanto vero da esser toccato a Livorno, per lunga pezza, perfino allo scrittore Ezio Taddei, nato nel 1895 da famiglia agiata, precoce militante anarchico poi comunista, diseredato dal padre, per anni vittima della repressione fascista, confinato a Bernalda nella seconda metà degli anni ’30, poi profugo a New York dove non tardò a entrare in rotta di collisione con la mafia locale, scrittore dalla vita avventurosa e temeraria più di un Rocambole.
A risarcire in parte la dannazione della memoria toccata allo “scrittore dei poveri” ha provveduto, così, il circolo Arci “Al verde” del comune materano di Bernalda, con la presentazione del libro “L’uomo che cammina” edito, appena lo scorso anno, per i tipi della labronica Erasmo, a cura del prof. Giancarlo Bertoncini. A parlarne il 31 gennaio, una data importante per il comune lucano, è stato Angelo Tataranno, insegnante, militante PCI, assessore alla cultura e sindaco bernaldese fino al 1994, quando passò a occuparsi della Provincia di Matera in qualità di suo presidente. Tataranno già fondatore nel ’78 del Coordinamento Teatrale di Basilicata (CTB), prima associazione tra comuni per la promozione del teatro nella nostra regione; e poi animatore culturale e ricercatore di storia locale.
“Ezio Taddei ha lasciato a Bernalda, nei due anni di confino scontati dal ’36 al ’38, tracce indelebili della sua presenza” ci racconta, appassionato, Angelo. “Nonostante lo stretto controllo cui era sottoposto, riuscì ad integrarsi nella comunità locale stabilendo molte relazioni di amicizia. Cominciò col frequentare intensamente la bottega Vincenzo Dibiase, barbiere, collocata nella via principale del centro storico, che costituiva, in quell’epoca, un vero e proprio ‘circolo culturale’ frequentato da socialisti e qualche anarchico. Non a caso in quella bottega c’era sempre tanta gente, non sempre per servirsi del barbiere, ma per chiacchierare, per scambiarsi informazioni su tutto quello che accadeva in paese, e, spesso, per parlare, con molta circospezione, di politica. Del resto è noto come Bernalda rappresentasse tradizionalmente uno dei punti di più ostinata resistenza al fascismo delle origini, tanto da essere fatta oggetto, proprio il 31 gennaio del 1923, di una vera e propria spedizione punitiva che costò tre morti e una quarantina di feriti. Per quanto, in seguito, si tentasse di minimizzare quella brutta vicenda, nella popolazione più attenta e politicamente attiva se ne trassero analisi relative al fascismo. Nel 1948, l’amministrazione socialcomunista intitolò una piazza ai ‘Martiri del 31 Gennaio’ e, nel 1974, fu dedicata una lapide ai caduti di quella spedizione punitiva organizzata a Potenza dall’allora segretario del fascio, l’avvocato Sansanelli”.
“In quella stessa bottega Taddei ebbe modo di conoscere gli studenti dell’epoca, che frequentavano le scuole superiori a Matera, ottenendo da loro libri e giornali da leggere, e ricambiando con lezioni di greco, latino e matematica. Aver saputo successivamente, dalla sua biografia, che Ezio aveva frequentato, poco e male, solo fino alle elementari fu, dunque, per noi bernaldesi, una sorpresa straordinaria”. Evidentemente, come ha ben scritto Massimo Novelli, in carcere ci si poteva ancora istruire: attingere dagli altri compagni una più viva coscienza politica e, da chi più sapeva, imparare a leggere e scrivere, servendosi di un abbecedario clandestinamente scritto nelle celle, per terra, con torsoli di cavolo imbevuti d’acqua. Prontamente cancellabile, in caso d’ispezione. Domenico Javarone ha del resto rivelato il metodo scarno, ma di tutta efficacia, usato da Taddei con gli studenti bernaldesi: “Il tema è come una persona” gli spiegava “ha la testa, il tronco e le gambe; la testa piccola è l’introduzione, il tronco più grande è lo svolgimento, e le gambe, pure piccole, la chiusura”. Esortava, Taddei: “È così che devi scrivere, seguendo le cose una per volta…”. Faceva leggere Tolstoj e Dostoevskij. Dal canto suo, il livornese leggeva proprio di tutto. Aggiunge, ironico, Tataranno: “una volta, mentre si trovava in piazza Plebiscito, nei pressi del Municipio, e stava leggendo un giornale, un troppo esuberante milite fascista gli si avvicinò, gli strappò il giornale dalle mani e lo schiaffeggiò pubblicamente. Ezio Taddei non reagì. Aspettò che il fascista avesse finito per poi, con calma, chiedergli se sapesse leggere, perché quella volta stava sfogliando “Il Popolo d’Italia”.
Fu pure a Bernalda che Taddei finì per invaghirsi “di una bella ragazza, originaria di Ginosa. La relazione, ovviamente, fu furtiva e nascosta, non solo perché queste erano i costumi del tempo, ma soprattutto perché egli era un ‘forestiero’ e per di più confinato politico. La giovane ricambiò il suo affetto fino a quando suo padre, venuto a sapere della ‘tresca’, proibì in modo categorico alla figlia di continuare a frequentare ‘quell’individuo’! Ezio soffrì molto per questa vicenda, al punto da tentare il suicidio tagliandosi le vene. Fortunatamente l’amico Vincenzo, non avendolo visto a bottega quel pomeriggio, pensò di andare a casa sua, forzando l’ingresso per entrare. Lo trovò, riverso per terra, in una pozza di sangue, e lo soccorse come poté, in gran segreto”.
“In seguito” conclude Tataranno “tornò nel 1949” a Bernalda e a Pisticci, come ricorda lo stesso Taddei nel libro “La fabbrica parla” e come anche confermato da un filmato, oggi disponibile su You Tube (“Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato”, Regia di Carlo Lizzani), che lo ritrae in visita con altri dirigenti politici e sindacali a Matera. “A Bernalda fu accolto con festose manifestazioni di affetto da tutti quegli amici e compagni che aveva conosciuto durante il confino e che, in gran parte, erano diventati i locali amministratori del dopoguerra. Tanto che, nel 1976, l’Amministrazione Comunale gli intitolò una strada che sta ancora lì, a ricordarne il generoso impegno per la nostra gente”. Oggi Angelo Tataranno è al lavoro per ricostruire le vicende di Taddei a Bernalda. Come dire, un altro monumento.
Detto ciò, non ci si può nascondere che, però, recentemente, anche a Livorno, più di qualcosa è stato fatto per recuperare il ritardo della memoria. A partire dal convegno tenutosi lo scorso anno al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e promosso da Comune, Provincia e Istoreco (Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, diretto da Katia Sonetti). Tuttavia, nonostante l’intervento, in quella sede, di importanti studiosi quali David Bidussa e il già citato Bertoncini, e nonostante la successiva pubblicazione di un’ulteriore raccolta di racconti intitolata C’è posta per voi, mr. Brown! (Books & Company, Livorno 2013) qualcosa è parso essersi parzialmente inceppato. L’impressione è che i duri attacchi a Taddei sferrati da un filologo dell’esperienza di Luciano Canfora, accusato di essere, in realtà, al servizio dell’Ovra, abbiano un po’ gelato gli ambienti labronici.
Si potrà tornare sull’argomento, ma per quanto riguarda Bernalda, rimangono forti le parole di Tataranno: “Qui in Basilicata giudichiamo le persone col metro della memoria di persone ancora vive, e per quello che abbiamo visto e vissuto direttamente. Per noi Taddei ha fatto molto, al di là di ogni suo limite personale. E su questo noi siamo chiamati, come comunità, a giudicarlo”. Il che – come ha recentemente ribadito David Bidussa (Fondazione Feltrinelli) in una sua polemica con Paolo Mieli sulla ricostruzione delle vicende del PCI di Ruggero Grieco e su Taddei – fa strame di un certo modo di vedere la storia da un ristretto buco della serratura oltre il quale paranoicamente resterebbero a muoversi esclusivamente i falsi, le spie, i doppiogiochisti.
Quelli che seguono le stelle. Francesco Larocca e i suoi telescopi.
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 24 Ottobre 2013.
_____________
“Lucani nel mondo”, si diceva una volta. Ma anche “in Italia” – o, più in piccolo, nel Lazio – si danno parecchio da fare. Ad esempio Francesco Larocca, oggi a Frascati (Roma) docente di scienze dell’Istituto Salesiano Villa Sora, del quale riveste anche il ruolo di Vicepreside del Liceo Scientifico, ma lagonegrese DOC. Che, nel febbraio 2012, acquisendo ben quattro telescopi, ha avuto l’idea di fondare, con i suoi studenti liceali, il Gruppo Astrofili “Segui la Stella”. Così l’istituto – sollecitato da una didattica per scoperta, dove l’apprendimento sui testi poggia sullo studio diretto sul campo – si è fatto poi carico della ristrutturazione di una torretta con ampia terrazza annessa (già proprietà dei duchi di Sora) che, negli anni Venti del Novecento, era stato edificato appositamente per effettuare osservazioni astronomiche. Ma non basta, perché l’associazione organizza anche incontri con personalità del mondo scientifico quali Gianluca Masi, (astrofisico e curatore scientifico del Planetario di Roma”) o Roberto Somma (legato a Thales Alenia Space Italia), solo per citarne un paio. Ciliegina sulla torta, quest’anno la struttura è stata prestigiosa sede della “Notte dei Ricercatori” progettata da “Frascati Scienza”, un’organizzazione costituita da tremila scienziati, otto istituti e ben tre università.
L’osservatorio è oggi dotato di cinque telescopi specifici, sia per l’osservazione planetaria che per il cielo profondo, e uno esclusivo per il Sole (che rende possibile vedere le granulazioni, le protuberanze, le macchie e i brillamenti della nostra stella) ed è aperto anche alle famiglie degli studenti. Ogni sessione di osservazione è spesso preceduta da conferenze, alcune interessantissime, quali, dal 2012 a oggi, “Missioni spaziali per l’esplorazione di Marte”, “Il Calendario Gregoriano. La riforma moderna del tempo”, “Lo studio della Geografia Astronomica nella Scuola. Come le nuove tecnologie possono rivoluzionare la didattica” e “Il rischio di impatto di asteroidi con la Terra”.
E così, sempre sotto l’egida e l’instancabile attività di Francesco Larocca, il 18 ottobre l’istituto è stato ancora una volta sede di un doppio appuntamento: la presentazione del libro di Davide Giacalone “Rimettiamo in moto l’Italia” (Rubbettino, 2013), e l’incontro con il già citato astrofisico Gianluca Masi, che ha parlato del quadro di Van Gogh “La notte stellata sul Rodano”.
Davide Giacalone è giornalista e opinionista, ma principalmente si occupa di internazionalizzazione delle imprese. Non a caso, il libro nasce dal bisogno di porre finalmente un argine all’autodenigrazione cui di solito si abbandonano gli italiani. In realtà l’Italia è un Paese dal corpo solido e di straordinaria inventiva, ma che gli italiani spesso dimenticano. Il problema è che non essere capaci di risolvere i nostri mali – soprattutto quello di pensare di poter ormai vivere a spese della collettività senza più il gusto della competizione – ci rende incapaci di riconoscere le nostre forze. Così la nostra vita collettiva dà il peggio, soprattutto in politica, con un deficit impressionante di classe dirigente, portando purtroppo il sistema nervoso nazionale vicino al tilt. E tuttavia, la crisi è solo un pezzo della realtà che abbiamo di fronte. Bisogna, invece, avere il coraggio di ritrovarsi; ritrovare quella capacità di navigare in mare aperto che richiede la nuova sfida che la concorrenza globale pone oggi.
Il legame della presentazione vangoghiana con le argomentazioni di Giacalone è stata offerta proprio dalla presenza di Stefano Masi, perché il suo studio, già apparso nel 2007 come un brillante risultato dell’eclettica e versatile creatività italiana, fu particolarmente apprezzato proprio dal Van Gogh National Museum di Amsterdam, in Olanda. Con buona pace anche delle odierne convinzioni su certa limitante divisione dei saperi umanistici e scientifici.
Uno studio, quello su la “La notte stellata sul Rodano”, che ripercorre uno dei temi più in voga in questo primo scorcio di secolo, in ambito artistico e letterario: il rapporto dell’autore con la realtà. Dunque, Van Gogh, allora in Provenza, riproduttore emotivo o dal vero – meglio: dal vivo – del cielo? E con quale consapevolezza astronomica? Ebbene la rappresentazione artistica del Grande Carro sulla tela ha permesso a Masi, in realtà, di stabilire data e orario del gesto pittorico (le 23.15 del 25 settembre). E ciò a differenza di tanta pittura “realistica” più attenta alla riproduzione luminosa del firmamento che alla sua precisa resa spaziale. Il fatto si rivela, così, capace di svelare l’eccezionale passo stilistico dell’artista olandese, perché il Gran Carro, dal luogo dove è dipinto (Arles, verso Sud-Ovest) non può essere nel campo visivo. Dunque, di qui, nuovamente, l’irrompere della potenza desiderante e stravolgente il dato realistico con un paesaggio cui è sovrapposto un cielo altro (come con occhi bifronti già modernissimi e furiosi e ribelli a invertire l’orizzonte, scompaginandone le geometrie), e tuttavia ritenuto l’unico degno di essere rappresentato da Van Gogh come cielo.
Recensione a: Antonio Moresco, La lucina (Mondadori, 2013)
Questa recensione è stata pubblicata su «FuoriAsse», n. 8 luglio 2013.
_____________
Sulla piccola luna di Antonio Moresco
Nel 1749, il naturalista e cosmologo Buffon, congetturò – in Théorie de la Terre – che una cometa, colpendo il Sole, ne avesse staccata una massa fluida dalla quale si sarebbe originata, con gli altri pianeti, anche la Terra. Sinceramente, non ci pare che Antonio Moresco abbia voluto ispirarsi all’opera del pre-evoluzionista francese. Ciò nondimeno, la piccola stella urlante generatasi dalle pagine ultime de Gli incendiati, schizzando per galassie estreme, deve aver staccato, all’improvviso, un frammento dalla massa in formazione di un’opera più grande – incandescente e già viva – e, tuttavia, per noi ancora increata, se la sua luce tuttora non ci giunge dalle profondità relative dello spazio.
Nell’attesa, osservando questa «piccola luna» appena raffredatasi – dall’esile trama, ma dall’importante «natura intima e segreta» – che è La lucina (Mondadori, 2013, 168 pp.), subito ci colpisce una sorta di naufragio temporale dove i relitti del passato e del presente giacciono incagliati nelle stesse secche. Un «posto fuori dal mondo», crepuscolare, sonnambolico, che investe, innanzitutto, il «borgo abbandonato» dove ha voluto appartarsi la voce narrante del racconto. Un posto dove anche i luoghi si confondono, parendo ora uno dei tanti paesi abbandonati di rabbia lungo i crinali dell’Appennino italiano (di cui possono aver parlato, ad esempio, un’Antonella Tarpino o, ancor prima, un Vito Teti), ora una di quelle emergenze archeologiche precolombiane casualmente ritrovate, capaci di presentarsi senza tempo all’esploratore, quasi del tutto avvolte dalla foresta, eppure sempre con l’impressione affascinante di un recente abbandono. Non a caso nel borgo i fichi sfondano le finestre delle case, il filo spinato al limite dei campi appare appena interrato, le piante commestibili serpeggiano sul suolo ormai diseducate. Lungo un sentiero c’è anche un cimitero con lucine ancora funzionanti. Una natura, insomma, su cui la mano dell’uomo deve essersi a lungo esercitata, anche se è come fosse stata da poco recisa.
Il resto, appena fuori, è selva: lotta verticale di alti fusti, sottobosco, liane, rovi. Una natura che si fa, che si «inventa», che adatta passo per passo la propria risposta allo stimolo esterno, che sopravvive non per l’intelligenza, ma per la maggior forza riproduttiva. Nugoli di insetti si accaniscono sull’uomo, devono essere scacciati dalla sua mano, oppure vengono inghiottiti dalle rondini, eleganti esecutrici. Le vespe scavano, sensualmente feroci, la carne dei frutti più turgidi e zuccherini. I mammiferi, a seconda della loro natura, appaiono difensivamente o aggressivamente territoriali. Solo in un caso un cane vaga, sbandato fantasma, per un sentiero, seguendo e impaurendo il protagonista; ma forse, in realtà, unicamente comunicandogli una penosa, muta sovrapposizione di percorsi.
Un mondo, insomma, che non cessa di tormentare la voce del romanzo, di esercitarne un’angosciata tensione morale: «Perché tutta questa misera e disperata ferocia che sfigura ogni cosa?». E, poco più avanti: «Dove posso andare per non vedere più questo scempio, questa irreparabile e cieca torsione che hanno chiamato vita?». Ma nessuno replica. Oppure sola capace di rispondere è l’incommensurabilità stessa tra le interrogazioni poste al senso della natura e i riscontri ricevuti, tanto imperscrutabili quanto mai consolatori. Di qui tutti i ragionati accostamenti dello scritto di Moresco alla leopardiana «Natura matrigna», base di umana infelicità. Anche se in questo caso, ci pare, non possa soccorrere nessuna difesa approntata da «analisi, ragione e sperienza», se non sapere che «quel che è distrutto patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare, è distrutto medesimamente» (Dialogo della Natura e di un Islandese, 1824).
E tuttavia lo scrittore mantovano, ci pare, abbia ancora al suo arco un elemento di maggior modernità. Che è la compresenza, la sconcertante compenetrazione di morto e di vivo: «Ma come si fa a vivere così?» domanda il protagonista a un castagno dal fusto ancora scatenato di vitalità, ma dalla cima nuda e pietrificata: «Agli uomini non è possibile: o sono vivi o sono morti. Così almeno pare…». E viene il dubbio che persino le stagioni, solo due nel racconto, non siano che le declinazioni di uno stesso tempo comatoso.
Sennonché, a ogni quotidiano calar del buio, la vista del protagonista è attratta da una lucina, sul ciglio dello «strapiombo vegetale» che lo separa dal crinale opposto. L’uomo cerca di capirne la natura per approssimazioni (residuo luminoso come per le lucine del cimitero? Ufo che segnalano l’intervento di mondi alternativi?…). E tuttavia, sia pure in un clima di angoscianti fenomeni e presenze (terremoti – che riportano la narrazione alle pagine de Gli incendiati –, uomini a cavallo che attraversano i boschi, grandinate che lapidano la carnosità di certi gigli come un peccato), l’uomo parte a cercare la fonte di quel bagliore notturno in un percorso in cui ogni residuo di sentiero sparisce e ogni facile avanzamento è impedito. Abita la casa un bambino, senza nome e senza genitori, con cui l’uomo stabilisce lentamente un’amicizia. Ben presto quest’ultimo scopre che il bimbo è morto suicida (il che è sempre, nelle pagine di Moresco, dato acquisito senza particolari sconvolgimenti, i morti comportandosi come i vivi) e che è soprannominato dagli amici di scuola «Stucco» (forse un dolente richiamo all’Ernő Nemecsek e alla Via Pál di Ferenc Molnár).
Così, come per Gli incendiati, si ripresenta, ancora una volta, lo spazio permeabile di convivenza tra vivi e morti, qui rappresentato dalla scuola serale che il bambino frequenta, abbuiata da pesanti tende tirate da un bidello. Così come pure torna il tema dell’uso sadico del potere, pure se più sfumato, rappresentato dalle brutalità di un maestro incapace di ogni empatia con gli scolari. E riappare un’esigenza di liberazione finale che è una dichiarazione di definitiva inappartenenza a un mondo.
Ma La lucina è probabilmente, in più, la presa di coscienza che se il colore della neve è quello della coscienza della morte, lo è anche di un’espiazione finita, di un peso di dolore e infelicità che può finalmente affondare silenzioso, forse rischiarato per un’ultima volta da «quel sogno breve e crudele che è stato chiamato amore».
Del resto, aveva già scritto Filippo la Porta (Meno letteratura, per favore!, 2010) a proposito di Lo sbrego: «a ben vedere la letteratura, la grande letteratura, è fatta soprattutto di dialogo con i morti. Non sarà che questi “morti” sono ben più vivi della maggior parte dei nostri contemporanei, costretti a vivere in spazi desertificati, impegnati disperatamente a simulare l’esistenza e a convincersi di avere un’anima?».
Recensione a: Andrea Di Consoli, La collera (Rizzoli, 2012)
Questa recensione è stata pubblicata, in forma ridotta, su «l’immaginazione», n. 274 marzo-aprile 2013.
_____________
Diciamolo subito: Pasquale Benassìa, il collerico protagonista dell’ultimo romanzo di Andrea Di Consoli, è l’autentica impossibilità di avere, del Sud, un’idea dialettica. Uno spazio meridiano, cioè, in cui gli opposti riescano, in qualche modo, per breve o lungo gioco di composizioni successive, a trovare una sintesi, un equilibrio superiore, il raggiungimento di una vetta che alla fine non frani disfacendo tutto. Tanto da piegare il tempo narrativo in una circolarità che è prima dei Lumi e prima di Cristo, e forse pure fuori da ogni possibile paganesimo, se alla fine non soccorre nessuna naturale palingenesi a riscattare un qualsiasi futuro, sia pure individuale. La collera –lo sottolinea Andrea Caterini in un’intervista all’autore– altro non può essere, così, che la definitiva presa di coscienza dell’«impossibilità d’essere liberi dal bisogno, e quindi terrorizzati dalla propria incapacità a riconciliare la vita ai sogni che la animano»; facendoci pensare che i panni di Benassìa siano pure sostenuti da un’amarezza che è dell’autore, anche se Di Consoli davvero difficilmente ci pare romanziere da poter perdersi in qualche modo su strade che sono proprie dell’autofiction. Anzi.
Ma intanto l’eroe di Di Consoli: che è un personaggio duale e caotico di visceralità e ardori, corporeità e spiritualità senza cautele, tanto da decretarne un’irriducibile quanto rivelatrice inappartenenza al mondo. Fin dall’infanzia, dove il giovane Pasquale Benassìa rintraccia i segni e i sogni, misteriosi (e perfidi) del suo destino, e il demone taurino e istintivo della sconfitta, delle macerie, della deiezione dalla storia, delle ragioni del torto (nasce lo stesso giorno della morte di Hitler). Cui miscelare, come instabile nitroglicerina, la gioia «santa», lo stato di grazia di certe visioni miracolistiche che paiono uscite da pagine antropologiche sul mondo contadino e pastorale (l’episodio della “resurrezione” delle pecore del padre). Pulsioni, passioni, aspirazioni ben presto messe alla prova dei «tornanti» cruciali e, per certi versi fondativi, della storia meridionale e italiana che sono gli anni Settanta.
E il fascismo personale che Benassìa crea e proclama, come parte della stessa collera che lo agisce, pare proprio originarsi e scontrarsi con le terrose radici del protagonista: trovando, in questo impasto e urto, la sua furiosa e sulfurea forza polemica. Pasquale è figlio di miserabili contadini calabresi, ben presto irredimibile tabagista catarroso e sovrappeso, ma pure autodidatta talentuoso dalle letture compulsive e disordinate, fantasticatore e visionario, umorale, atipico filosofo dalle singolari teorie eliocentriche ed entropiche (ché nel generoso dispendio fisico di sé e della propria energia intellettuale pare ricordare i tratti biografici di un Avicenna). Così, il fascismo sui generis di Benassìa non si costruisce su nessuna militanza, su nessuna disciplina di partito, su nessuna ora fatale della storia, ma rimane un umore sdegnosamente solitario. Anche quando il giovane calabrese emigra a Torino, operaio alla Fiat, negli anni centrali della contestazione e delle rivendicazioni operaie; di fronte alle quali resta, non a caso, sì contrario, ma piuttosto eccentrico.
Invece c’è, negli occhi del giovane Pasquale, qualcosa di impervio e inquieto: una presunzione di ascesa (forse anche un po’ guascona), la fantasia turbinosa di una guerra dello spirito che si ribella a ogni compassione, a ogni idealizzazione del mondo contadino, a ogni sguardo basso, piantato nel male della terra: «ché lui a Torino non era andato per evolversi da contadino a operaio… ma da contadino a pensatore, a filosofo, a sacerdote della verità». C’è in Benassìa una spinta che è stata anche, per qualche tratto, generazionale, ma nel contempo declinata e deviata individualmente in una fantasticazione irriducibilmente superoministica: «quello che davvero voleva era vivere nella forza, in un pensiero maestoso e inimitabile, e poi innamorarsi di una donna altera e intelligente, e poi studiare e poi farla finita con la commedia triste del socialismo delle lotte operaie e contadine e, infine, ergersi a pontefice della propria leggenda personale». Così, attraverso scombinate letture, il suo mondo trascolora in una sorta di confuso e romantico medioevo interiore: «Pasquale si rifugiava, nel tempo libero, nella lettura di riviste e di libri: soprattutto di storia e, tra questi, di storie monarchiche, manifestando sin da ragazzo una strana attrazione per le monarchie di ogni epoca, più volte trascorrendo del suo tempo adolescenziale a immaginare –in un guazzabuglio senza capo né coda– re, regine, cavalieri, templari e cortigiane». Col risultato, insomma, di un fascismo che subito depone le sue armi più immediatamente storico-politiche, per rivelare, nelle sue origini, un retrogusto letterario e filosofico: nel senso di certe concezioni nietzschiane o certe posizioni stilnoviste per cui la nobiltà può essere una virtù morale individuale blasonata di orgogliosa superiorità, più che indicare una condizione sociale di nascita privilegiata. E con esiti che possono sembrare persino donchisciotteschi, e tuttavia pure sempre cogliendo la verità che, spesso, l’«eterno fascismo degli italiani» altro non sia stato che un personale ritaglio, la declinazione di un’idea collettiva (storica, sociale, politica) dai contorni per nulla rigorosi.
Si genera nello scontro con le radici anche la collera. Che, se per dirla con Bodei, «nasce in genere da un’offesa che si ritiene di aver immeritatamente ricevuto, da una bruciante ferita inferta colpevolmente da altri al nostro amor proprio o alla nostra autostima», l’ira dell’aristocratico Benassìa non può che, all’inizio, rivoltarsi apparentemente in una sorta spirituale di odio di classe rovesciato, contro l’ingiustizia materiale rappresentata dalle origini. Pur sapendo che la collera risentimento non è –sia chiaro– e nemmeno odio: sentimenti notoriamente bisognosi di calcolo, dissimulazione, lunghi tempi di gestazione. L’ira, la collera, sono invece palesi, scoperti, senza remore o rispetti di sorta. Sono fatte di resistenza polemica e immediata, ma pure segnalano sempre la debolezza della breve durata, la fragilità di chi ne è agito, l’amarezza dell’anima e del corpo, le sue ulcere, le sue ipertensioni, le sue lacerazioni. La collera è, paradossalmente, profondamente contadina; è una jacquerie individuale che, in quanto tale, pare sollecitare una contro-risposta parimenti risentita del mondo, tanto che di Benassìa pure è stato detto con acume finisca per diventare un punitore di se stesso: perché noi meridionali «ci proviamo a essere civili, ci proviamo a riconoscere lo stato, ci proviamo ad affidarci al lavoro, ma poi perdiamo la testa e iniziamo a ragionare con la pancia, con l’odio, con il cazzo duro, con il fuoco in mano».
Tuttavia c’è qualcosa di più nella storia, qualcosa che travalica la sconfitta delle aspirazioni di partenza di Benassìa per colpire al cuore il suo protagonismo. Un risultato che a mo’ di zavorra, anche con risultati sottilmente paranoici nel lettore, pare in agguato fin dalle prime pagine del libro, subdolo e pronto a ingoiare nuovamente Pasquale nello sfondo meridiano da cui faticosamente cerca di affrancarla. Un peso, insomma, che prende le forme del suo coetaneo Germano Altomare (barista coinvolto in un losco giro gestito da siciliani) che, paradossalmente lo spinge a partire dal suo Paese dei Mori verso Torino. Pasquale Benassìa, dopo un viaggio attraverso l’Italia a bordo di una vecchia 500, approda, così, alla Fiat, dove si impiega logorandosi di lavoro come meccanico, tuttavia, come prevedibile, sprezzando i suoi colleghi meridionali (o di sinistra) e ingraziandosi il caporeparto Marini (piemontese e di destra). Inizia in questo modo quella che gli pare la scalata verso la vetta definitiva delle sue aspirazioni pur già comprendendo, sempre tra i fumi della collera, che anche il Nord, «stordito e istupidito dalla fame di soldi», non potrà essere che un’altra illusione. Sono affermazioni che preludono all’incontro con la siciliana Simona, capace di affogare Pasquale – nonostante i sensi di colpa per la sua fidanzata, Magda Beccaria (un’insegnante torinese) – in un gorgo di sensualità consumato in una camera d’albergo a ore. Un amore la cui meccanica confonde delle sue opacità i sensi e la mente sbigottita di Pasquale, rivelandone pure l’angosciosa incapacità di accedere al mistero della donna. Così come oscura e inconoscibile rimane la ragione della persecuzione da parte del gruppo di siciliani al rifiuto dell’incauto Pasquale, attirato nel bar dal solito Altomare, di fare, per loro, una non meglio esplicitata consegna. Fatto, tra l’altro, non si sa se e quanto legato alla «faccenda» di Simona, che nel frattempo s’è dissolta nel nulla.
Vicende che lasciano irrompere con forza nel libro –come ha notato Aurelio Picca– il romanzesco, col rocambolesco ritorno al Sud, sotto scorta, di Pasquale. Un rientro che ha la stessa repentinità di un’ancora gettata di colpo in fondo al mare e che lascia Benassìa in balia dell’assurdo. Faccende che lo avvincono nelle spire delle paure e di una vita allarmata, all’inizio appena lenita dal ritorno in famiglia o grazie al sostegno (tra l’altro collericamente tradito) dell’amico Anile o dell’incontro con la carne accogliente di Teresa. Terrori tuttavia definitivamente estinti solo dall’obolo umiliante (e che a Torino s’era voluto evitare) pagato ai taumaturghi moderni del familismo politico, dello scambio di favori, di quella mafia per ironia della sorte così affezionata a certa destra. Pure con la beffa di essere coinvolti, da protagonisti, in importanti fatti di cronaca, tuttavia tanto agghiaccianti da non poterne fare neppure menzione se non al rischio della galera o della vita.
Faccende e derive che non possono che consumare definitivamente ogni collera, se per dipendere da nessuno –dice Di Consoli– alla fine si finisce per dipendere da ognuno. E consumano anche Pasquale, che si spegne già quasi dimenticato da tutti, la sua nera anima di filosofo trasmigrata in un cane randagio che lavora rabbioso coi denti un osso di bue gettato per strada. Perché, per Andrea Di Consoli, ci pare, a differenza di altri intellettuali meridionali, la verità del Sud (quel Sud con il quale pure mai si riesce a farla definitivamente finita) non è mai fuori portata o abilmente nascosta, ma più semplicemente buttata via o dimenticata, non servendo a nessuno.
Recensione a: Lilli Gruber, Eredità (Rizzoli, 2012)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» domenica 11 novembre 2012.
_____________
La prima mail a darmi l’allerta via Facebook è quella sibillina di Vincenzo Pagano, fratello di tutta un’infanzia: “L’hai letto l’ultimo della Gruber?”, mi scrive dal paese. “No, non l’ho letto. Perché?”, gli faccio di rimando, e magari sarò risultato un po’ secco, ma in fondo francamente demotivato dagli ultimi due o tre sonori “pacchi” (più o meno romanzeschi) rimediati dall’ultimo giornalista di grido. Però, insomma, è successo che nel suo ultimo lavoro, ”Eredità” (Rizzoli, 360 pagg., € 18.50), Lilli Gruber ha parlato di Castelluccio e dunque la lettura del libro mi s’impone. Ma mentre cerco di capire cosa c’entri il paese dove sono nato, e come, con la notissima giornalista Dietlinde Gruber, detta Lilli, mi raggiunge un post dell’amico Sproviero che mi indica il dibattito in rete che intanto s’è avviato, e alla cui fonte trovo, infine, Giuseppe Pitillo, vale a dire uno che la memoria del nostro paese prova attivamente a tenerla in vita e – scopro con piacere – con un ruolo anche nella redazione delle pagine di “Eredità” più interessanti ai nostri fini. E alla fine va così, che vado in libreria quasi fisicamente sospinto dalla curiosità di una comunità dalla quale dovrei essere geograficamente e spiritualmente, ormai, piuttosto distaccato. Invece.
Invece quel richiamo che, a un certo punto, deve aver riconosciuto forte anche la cosmopolita Gruber – mi dico – se, al culmine di una riuscita carriera, si sente di scrivere un libro che ripristina i legami, anche intellettuali, con la sua Heimat (malamente traducibile con “patria”), esaurite le lunghe insofferenze giovanili per le tradizioni della sua terra e per certa “retorica patriottica che in Sudtirolo”, dove è nata nel 1957, è spesso sfociata “in aperto nazionalismo”. E dunque, se “Eredità” non può dirsi propriamente un libro di storia, ma un saggio dedicato alla memoria e al “recupero di un’eredità familiare e culturale” che appartiene all’autrice, però con la storia – la storia tormentata di una terra di confine (un tema, questo, di grande modernità) – fa i conti. Soprattutto con il “passato che non passa” di un Novecento che pare a volte davvero essersi consumato con l’ansia veloce di una sigaretta: per ogni vivace bagliore, fumo e cenere. Un passato da cui si enuclea la verità presente di un Sudtirolo complesso e stratificato (radici germaniche, apporti italiani, infine globalizzazione) cercato dall’autrice tra le pieghe vive della sua esperienza, attraverso un giudizio che direi appassionato quanto distaccato, attento alla storia e al quotidiano.
Mi pare, allora, che l’età dell’autrice non sia oggi necessariamente quella dei sopralluoghi nostalgici, ma quella che ci chiarisce un Sudtirolo alla prova degli anni cruciali del Secolo breve. Un trentennio segnato, nel libro, da due figure femminili dalla forte personalità: ribelli (ognuna a suo modo), caparbie e fortemente legate alle loro identità e terra. Sono la bisnonna di Lilli, Rosa Tienfenthaler e la prozia Helene Rizzolli, detta Hella. Figure entrambe, direi, della crisi. La prima, proprietaria terriera, le radici ottocentesche legate alle lealtà patriarcali dell’impero austro-ungarico liquidatosi, prima, nel trauma irrimediabile della sconfitta con l’annessione all’Italia del Sudtirolo; colpito, poi, quest’ultimo, dalla becera italianizzazione imposta dal fascismo. La seconda, legata a un futuro che guarda al passato, alle nuove speranze di ricongiungimento alla patria dei sudtirolesi, ma polarizzate questa volta dal liberticida Reich nazista: illusioni presto impantanatesi tra le pieghe di uno sciagurato patto tra regimi totalitari. Figure, dunque, entrambe, della crisi – dicevo – così come di una percezione del confine e dell’identità come casa, ma pure nostalgia, resistenza e attrito di fronte agli inevitabili rovesci della storia. Direi pure alternative a personalità più defilate nel racconto – Berta Rizzolli, ad esempio, o gli stessi genitori di Lilli – che denotano, invece, una più spiccata attitudine a vivere l’identità del confine, pur senza svendite, come permeabilità positiva, contaminazione, anche sfida, conoscenza della differenza, opportunità. In un Sudtirolo, oggi, comunque molto cambiato.
Ma riprendiamo le fila: dunque, Castelluccio Inferiore. Ma cosa c’entra? C’entra, perché proprio la repressione e la pesante offesa alla memoria di un territorio perpetrate dai fascisti (alle quali, in seguito, si salderanno le ristrettezze economiche imposte dalla crisi del ’29) finiscono per creare delle decise reazioni che spingono molti sudtirolesi tra le braccia del pangermanesimo hitleriano. Certo con imbarazzi, pericolose contraddizioni e qualche diffidenza tra i due alleati che, alla fine partoriranno la scellerata soluzione delle “Opzioni”. Ma pure con una mal riposta forza di illusione sulle reali intenzioni di riannessione naziste (giocheranno qui anche le false speranze suscitate del referendum per il ritorno della Saar al Reich), che scrive davvero una brutta pagina sulle compromissioni del Sudtirolo con il nazionalsocialismo, su cui la Gruber – va detto – non fa sconti di sorta. Nemmeno nei riguardi della sua prozia Hella che è, dal canto suo, arrestata l’8 gennaio 1938 come attivo agente anti-italiano e anti-fascista e incarcerata insieme a detenuti “comuni”, in questo caso prostitute – pratica (con alterni risultati) adottata, tra l’altro, da tutti i regimi totalitari, dalla Spagna franchista all’URSS stalinista, per umiliare e fiaccare la resistenza dei “politici”. Giunge, infine, la decisione del regime di comminare cinque anni di confino alla giovane attivista nazionalsocialista. Una condanna esemplare, che possa servire da esempio agli altri militanti sparsi per la Bassa Atesina, dove Hella opera politicamente.
Così, sulle tracce di Helene, confinata in Lucania dal 19 maggio al 18 novembre del 1938, la Gruber giunge a Castelluccio nell’agosto di quest’anno. Scrive l’autrice appena in paese: “Ho immediatamente la sensazione che quasi nulla sia cambiato da quando, settantaquattro anni fa, Hella si è ritrovata qui, al confino, mille chilometri a sud della sua casa di Pinzon”. Il che, se per un verso mi pare un’affermazione di accorata suggestione sul filo della propria riallacciata memoria, per il resto mi lascia perplesso, se dà l’impressione di scivolare verso certo “levismo” o fascinosa cartolina dell’immoto paesino-presepe, in contrasto o in accordo (ma non è questa la sede) con quell’invalidante scostamento della forbice modernizzante – buche nelle strade e odiosi viaggi in treno inclusi – che la Gruber individua tra dato oggettivo e personale fastidio, che è poi il complesso gioco tra termini assoluti e relativi del cambiamento del Sud rispetto ad altre italie.
Ma Hella? La Gruber ne ricostruisce i mesi della permanenza grazie alle lettere indirizzate alla famiglia conservatesi dal confino e grazie all’aiuto ottenuto sia dal citato Giuseppe Pitillo che dall’ingegnere (con il vizio della storia locale) Biagio Aiello. La Rizzolli è posta in pensione al numero 294 di via Roma, e rubricata, con tipico contorsionismo linguistico, come “casalinga”. “Perla” di imbarazzo ideologico cui ben fanno seguito altri errori e svarioni a carico dell’inefficiente macchina burocratica fascista, senza contare le molestie notturne dei tutori della legge che si assicurano, così, il rispetto del coprifuoco da parte della confinata. Pure, al di là di tutto questo, complessivamente il rapporto di Hella con Castelluccio rimane, pur registrando continui miglioramenti, piuttosto contrastato. Certo, gioca un “vero e proprio shock culturale” patito al suo arrivo, che Hella condivide con altri confinati, non solo sudtirolesi, di cui si sono potute ricostruire le vicende. Con in più le ipocrisie di qualche locale delatore; il contrasto con la nuova padrona di casa; la necessaria incomprensione di certi costumi per oggettiva mancanza di informazioni storico-culturali. E tuttavia si percepiscono nella Rizzolli anche connaturate rigidità di giudizio che la spingono ad alcune affermazioni francamente ingenerose, quasi fossero generate da una più complessiva inadattabilità all’ambiente o da una provocatoria interpretazione a tesi. Rigidità però sempre sorprendentemente compresenti, nel giovane “spirito ribelle” e temerario, alla capacità di cogliere con grande intelligenza e capacità descrittiva caratteri e ambienti che ci restituiscono pagine gustosissime e ironiche che sono come istantanee ancora vive del nostro “come eravamo”. Il resto lo fa il tempo, la progressiva comprensione che il fascismo regime – che nel Sudtirolo mostra monolitico la sua faccia più oltraggiosa e aggressiva – a queste latitudini è un totalitarismo sì fanatico e violento, ma pure inadeguato e disorganizzato, tanto che due sorelle di Hella, Berta ed Elsa, per farle visita e portarle i saluti della madre, Rosa, riescono ad attraversare tutta la Penisola senza suscitare alcun sospetto. Del resto Hella non è per nulla una donna fredda e lentamente, pure sollecitata dalla naturale socievolezza dei Castelluccesi, a sua volta inizia a coinvolgersi con quegli italiani alla fine abbastanza diversi, per indole, da quelli che vanno conculcando così ferocemente la libertà nella sua terra. Possono nascere, così, anche belle amicizie di cui la più forte resta quella con “Rita Lauria, di dieci anni più grande, sposata col signor Conte”, con cui trascorre molta parte delle giornate (rimpinzandosi di fichi, magari, o seguendo la spremitura dell’uva coi piedi) e che, prendendosi cura di Hella, riesce così a mitigarne molte comprensibili ritrosie, permettendole di mostrare i lati più solari del carattere. Certo suscitando (nemmeno i Castelluccesi sono perfetti) qualche gelosia, ma anche il riguardo da parte del podestà Ernesto Catalano. E le pronte attenzioni di qualche locale giovanotto (e non solo!). Ma sembra un attimo, perché la vulcanica, coraggiosa e geniale Berta riesce rocambolescamente a far revocare il confino alla sorella addirittura da Galeazzo Ciano. Risparmiando, così, più di quattro anni di ulteriore pena a Hella che, interrotta quell’esperienza e tornata a casa, resterà ancora del tempo in contatto con la signora Rita.
Ora, chiuso il libro, si potrebbe persino desiderare che Hella, forse, avrebbe potuto rimanere di più: conoscerci meglio, farci conoscere meglio (curiosi di natura come siamo) il suo mondo. Sicuramente, molti, a differenza di lei, giunti in cattività costruirono qui la loro libertà. Ma amiamo troppo la nostra terra per non comprendere che altre migliori, se non la sua, non avrebbero potuto esistere. Del resto, mi pare difficile anche pensare a Hella Rizzolli se non come a una di quelle persone massimamente libere solo se massimamente avvinte alla loro radice. Pensiamo sempre la libertà possa dirsi nomade; spesso invece ci sorprende, se porta con sé il nome di una mistica Heimat.
Recensione a: Daniela D’Angelo, Catalogo dei giorni felici (Salvatore Sciascia Editore, 2012)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 30 settembre 2012.
_____________
Si susseguono con un passo piano e tuttavia intenso i versi d’esordio che Daniela D’Angelo consegna alle pagine della raccolta “Catalogo dei giorni felici” (Salvatore Sciascia, 56 pp., 6.00 €). Passo di chi abbia prima amato senza cercare ripari – senza “più nulla da stringere, / nemmeno un talismano” –, appena dopo decantando l’esperienza nella precisione elegante del verso, in una parola che è già di maturità, di sopravvenuta intelligenza delle contraddizioni che sono la natura necessariamente fugace della felicità: una “coda scintillante” di volpe intravista su un sentiero nel bosco.
E dunque “catalogo” (ma anche sforzo di individuarsi in un punto topografico certo nella difficile geografia del vissuto) e non “elenco” dei giorni felici; che è certo raccogliere ed enumerare esperienza, ma pure ragionarla, sempre col rischio, cioè, che lo sguardo con cui si coglie un sentimento o un desiderio sia quello del pomeriggio, con una luce ancora accesa, e tuttavia bifronte, già punta dal sospetto malinconico della disillusione, che fruga noiosa “a vuoto dentro il piatto” promettente del mattino, la testa già alle trappole e alle buche (anche della quotidianità) in cui ci si è, a volte, malamente cacciati. Tanto da farci temere che quella felicità e quell’amore, pure senz’altro vissuti, siano stati invece lo scorrere illusorio di una pellicola mai impressa, o sbiadita: “Cominciare le letture da finire / finire col guardare vecchi film / tenere un catalogo dei giorni / in cui succede poco, / quasi nulla. / È il catalogo dei giorni più felici / a tenerti compagnia lungo la sera. / L’album delle foto che non hai / per ricordarti la vita che non c’era”.
E nondimeno, bifronte, la luce resta però ben prima anche delle nostalgie della sera, delle paure della notte, dei rigori dell’inverno, che può diffondersi, così, con una raggiunta serenità interiore nuovamente capace – si è detto – di conciliarne le incoerenze e gli accidenti, magari più persuasa di una navigazione “alla greca”, vigile alla costa e attenta al prossimo scoglio: “Giro il foulard azzurro / tre volte intorno al collo, ti do le spalle / e sorrido calma. // C’è un passo sulla soglia / che manca il precipizio, / c’è un modo per andarsene / che promette già un ritorno”.
Daniela D’Angelo è nata a Trapani, ma dal 2001 vive e lavora a Roma come editor e ufficio stampa di una casa editrice. Salvatore Sciascia (www.sciasciaeditore.it), invece, ci conferma ancora una volta quanto, per la poesia, le dimensioni editoriali siano sempre più inversamente proporzionali al coraggio di pubblicare. Purtroppo.
Livorno
Questo articolo è stato pubblicato sul «Corriere Nazionale» il 1° febbraio 2012.
_____________
Città d’autore – 20
Le facce di Livorno: il tuo punto di vista la fa plebea o nobile
“Ehi, amico, come va?” abborda sorridente il ragazzone di colore sul lungomare di Livorno, calze di spugna, fazzolettini, un po’ di occhiali in mano. “Dé, s’agguanta!” scivola via il cliente, una mano in tasca, l’altra fuori, in un gesto aperto e netto, a un tempo sincero ed elusivo. “S’agguanta”. Che in livornese sta per “si tiene”, “si prova a non cadere”. Io stesso rimango folgorato dalla scena. Col dubbio se il tipo abbia tirato dritto indifferente agli articoli proposti oppure per non dire che in tasca, spicci, niente.
Livorno va così, oggi non la leggi con la solita chiarezza. E tu spulci una statistica e sembra voli, e poi ne leggi un’altra e ti ritrovi giù di almeno dieci posti. Livorno su, Livorno giù. Livorno che gira la testa, un poco da ricovero, da ottavo padiglione, quello dove, una volta, agli “Spedali Riuniti”, ci tenevano i matti.
Livorno mostra i lati secondo come la guardi. Livorno dei servizi, bene, pare, e pure l’inflazione. Salute, forse ottima, ma su un muro, dell’Asl numero 6, si leggeva: “se la conosci la eviti” e già pareva chiaro che qualcuno, scrivendone, ne volesse lasciare l’esperienza. Una certezza, invece, la Livorno del lavoro. Però nera. Diciamolo, che c’è da interpretare? Trentasei abitanti su cento senza occupazione, o giù di lì. Poco consola che il dato è provinciale. Penso a una generazione buttata via, o che andrà via da sola, negata nel diritto a restare dov’è nata, se vuole, e metterci del suo. Certo come altre, nel resto del Paese. Ma che cambia? È una crisi diversa questa. Non è personale, non ombelicale, non riguarda il numero complessivo – che so? – dei divorzi, dello stress, di un disagio non meglio precisato.
E forse si vorrebbe glissare, far finta di non vedere. Aspettare. Aspettare magari che giunga un colpo di Libeccio, il vento teso che qui ti soffia vigoroso in faccia il mare, ma poi netta il cielo dalle nubi e le strade dai fumi e dalle angosce di ogni santo giorno. Le crisi a volte son così: qualcosa le porta, qualcosa le trascina. Però a dicembre anche il vento ha soffiato a burrasca, impetuoso, cattivo. Ha frustato di onde le terrazze e le rotonde, schiaffeggiato di sassi Viale Italia, la strada che segue la costa e scorre il mare. Scatenato, paziente, ha scartocciato facciate, cartavetrato persiane, piegato segnali, danneggiato le auto, accasciato gli scooter, i mezzi per i quali i livornesi nutrono una venerazione tutta loro.
Come il lupo della favola, il Libeccio ha rovesciato i tetti più deboli, fischiato nelle commessure più lasche. Si è introdotto tra i dubbi, tra le indecisioni di questa città allargandoli, fiaccando l’albero di un’identità politica già stanca, lavorando senza sosta nelle crepe tra l’anima tradizionalmente industriale e commerciale e quella delle velleità turistiche, di porta aperta sulla Toscana. Fino a colpire il cuore pulsante che è il porto, con i suoi lavoratori e il suo vasto entroterra, capace di potenzialità infinite, e però mai del tutto bene espresse, se si pensa a cosa fanno certe volte i genovesi in quella loro buffa città fatta di spalti e di scalette che non ci scommetteresti sopra un soldo.
Un vento che ha soffiato cattivo, ricordavo. Anche sulle navi. Quelle più incaute, quelle che fregandosene della prudenza da tenersi intorno all’area protetta attorno alle secche della Meloria, si sono perse, nel mare a burrasca, duecento fusti di rifiuti tossici. Ora da bonificare per bene e in fretta, per non ridurre un bel pezzo di costa labronica a un posto invivibile per uomini e pesci. Guardo il mare, tornato tranquillo, le navi illuminate al largo, di notte, e penso a una nemesi. Cos’altro può essere se il cargo dei veleni si chiama “Venezia”? Qui è il nome del quartiere figlio delle maestranze venete e di Livorno è il nucleo storico, l’ombelico che diede vita, nel Sei- Settecento, alla città. Un gioco di canali, ponti, magazzini, piccole imbarcazioni e attività tra la Fortezza Vecchia e quella Nuova.
Del resto, oggi, come se non bastasse, i nervi cittadini sono scossi anche per l’incredibile incidente accaduto giorni or sono, a pochi metri dall’isola del Giglio. Che poi è Grosseto – e potrebbe interessare meno – ma che è tale da sollecitare invece i ricordi delle fiamme, ora più rugginosi e lividi, del “Moby Prince” nei pressi della costa. Era il 10 aprile 1991, ma è restata una ferita mai rimarginata. Una storia dove, peraltro, a differenza della “Costa Concordia”, tutti i passeggeri si consumarono in un istante. Un fiammifero fregato, bruciato insieme alle responsabilità del disastro. “S’agguanta”, però, si diceva, e qualche volta davvero si dimentica. O ci si prova. Perché Livorno guarda al mare, ma spesso abbassa gli occhi sulla costa. Il che parrebbe uguale, ma non tanto. A volte prendo la piccola funivia, il giocattolo che porta al santuario di Montenero, nel bisogno che mi prende ogni tanto di cogliere la città dall’alto, tutt’intera. Da qui, osservando Livorno alle spalle, l’impressione che la città si ammassi, che corra, anzi, a schiacciarsi sulla costa. Ogni singola casa, frenetica, corre. E tutte assieme, come i Lemming. Tutte di là, a precipizio. Un volo d’auto alla Gassman nella celebre pellicola “Il sorpasso”. Del resto, per quanto spazi, l’occhio del livornese, ben presto s’incaglia in quel volto di donna che è l’isola Gorgona. Oggi un carcere, come una volta Capraia. E, ancora, nel profilo della vicina Elba, o in uno scorcio seghettato che pare salito dal nulla dell’inverno, che è il “dito” che fa la Corsica indicando la Liguria e poi la Francia, ma più malvolentieri.
I labronici sono legati a questa linea di costa, al mistero della sua pietra rosso o giallo ocra, di tela macchiaiola. Un bisogno forte come un approdo se d’estate, la piccola flotta di barche, barchette, gommoni, gozzi e fuori-bordo che la domenica, dopo una muscolare sgassata che alza più acqua di quanta non ne solchi, è raro che si apra al mare largo, preferendo in gruppo ancorare attorno all’antica torre della Meloria. Una piccola Livorno fuori porto.
La costa è sole e aria, soprattutto in inverni miti come questo. Un sole che intenerisce la stizza dell’inverno. Un’aria ottimista, “eterno fior di mare” se anche Carlo Coccioli ne coglieva, insieme alla città, il nesso più profondo: “Oh Livorno Livorno, miracolo di vita, e di saggezza amara. Dipenderà dall’aria, ma, se non l’assassinano, è raro che qui la gente muoia. E chi vive è troppo vivo per non sfiorare, dimenandosi, le soglie della ridente pazzia”. Ma era il ’71. E oggi son tempi più prosaici persino della penna maledetta di Curzio Malaparte. Così, sdraiati sulla spiaggia, si prova a celiare, ma non più di tanto, usando le parole del comico Migone. “Meglio disoccupati a Livorno, che ingegneri a Milano”. E via esorcizzando, ché ormai in gran parte la città s’appoggia alle pensioni, sperando reggano un istante in più della crisi anche quelle.
Insomma, arrostire sulla spiaggia come granchi. Ingrediente importante di quel kit dell’edonismo casereccio, di quell’arte di apparire che a volte ai labronici prende un poco la mano, eccessiva: certe signore tirate, col tacco dodici anche per il mercato rionale; certi maschietti palestrati e stra- vestiti (altrimenti, giuste eccezioni che confermano la regola, inguaribilmente sciatti). E supertatuati dappertutto, manco fossero pirati da Caienna (Livorno è pazza del tattoo). Fino al contrappasso, e al contraccolpo estetico. Eccolo allora, il ”trottatoio” serale sul lungomare, sulla terrazza Mascagni o la Rotonda dell’Ardenza, dove fa fresco e si arieggia tra baracchine e giostre, tra tamerici e lecci. E i turisti, invece, appena scaricati dai traghetti, si aggirano accaldati per Via Grande, i negozi tutti chiusi che è una pena, con la faccia un po’ perplessa, ché gli pare che qualcosa d’importante della vita stia sfuggendo, mentre appena più in là, negli storici bagni cittadini, l’immancabile rito d’elezione della miss si consuma. Come in certi film di Virzì, ma struggenti un poco meno. O forse sì, a guardar meglio, ché apparire un po’ chiassosi, a scordare aiuta.
Lo dico. Livorno non è tutta così. C’è una città diversa, più impegnata, meno esibita. C’è una città che ci dà sotto sodo, che sa stare al pezzo, che sa tenere il punto. E l’associazionismo, un volontariato ancora forti; più in generale un’empatia per l’altro e i suoi bisogni del tutto alternativa ai pisani ghiacci, ai sussieghi fiorentini, al secessionismo contradaiolo dei senesi. Anche se certe volte è come la città insistesse a imporsi prima stereotipa, compiaciuta dei difetti suoi. Invece che fiera, forte, capace, come è la Livorno che meno ti aspetti, che ti sorprende, ma più ha bisogno di essere cercata per mostrarsi. Potenzialità lasciate spesso appese, scoordinate o messe in fuga, eppure dalle quali ripartire se è vero che per scienza, pittura, musica, fotografia, prosa, poesia ha un Novecento di certo molto più moderno, ricco e vivace di tante più blasonate città, anche toscane. Ma “Moneta cattiva scaccia moneta buona”, è l’andante di certi economisti. O almeno, la moneta cattiva, ci prova. E dunque le baracchine sul lungomare casiniste, le vinerie, anzi, i wine- bar (noblesse oblige), della Venezia e della “ribotta” a oltranza, le discussioni etiliche fino alle quattro del mattino. Gli insulti, le minacce da gorilla o qualche breve zuffa o forte bercio. Sarà la primavera, l’estate, il testosterone? Chissà. Ma “vivi-e-lascia-vivere”, poi ti esortano, “è la Movida!”. E a dirti questa cosa provinciale è poi il solito che sulle Ramblas (quelle vere) non ci ha mai messo naso.
“S’agguanta”. Ma allora ci sarà la crisi, o no? no e sì, mi dico, se guardo a certo tenore di vita troppo alto, un po’ sospetto, di una città troppo innamorata del facile guadagno (e della spesa). E sì, poi no, se guardo a tutto il resto, a chi lavora per sé, o per il prossimo. Sulla terrazza giro le spalle al mare. Guardo i bei palazzi d’epoca, le nuove costruzioni spesso stonate col contesto. Rido (e non dovrei) riflettendo che Livorno è stata una delle città più colpite della seconda guerra mondiale. Ma è che ogni volta mi viene in mente la battuta di un amico un po’ pungente, per cui è vero sì – mi dice – ma hanno continuato a bombardarla pure dopo. Torno serio, ricordo le tonnellate di rovine viste in decine di foto d’epoca. Il porto sfatto, la città un buco nel terreno. La fame di case da tirar su in fretta, l’esigenza di costruire quartieri nuovi. Mi chiedo come avranno fatto a ritirarsi su. Però la notte ormai alle spalle, il sole in fronte.
E pure questa crisi di Livorno, penso, più va avanti, più pare un incruento dopoguerra, le case tutte in piedi, ma nient’altro, più o meno. Che solo quattro anni fa era diverso, o quanto meno si tirava a campare. Ma poi che passerà. Che i valori economici importano, che i soldi mordono il sonno e molestano i pensieri, ma lasciano alle volte un buco, un varco, alla città. Guardo un gruppo di ragazzi. Forse amici che si incontrano, si abbracciano e poi ridono. Però non mi consolo. Mi è difficile capire a che punto sia la notte. E oggi proprio non riesco a collocare il sole.
Lettera al Quotidiano della Basilicata
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 10 Ottobre 2011.
_____________
Nuova classe di amministratori per i piccoli comuni lucani
Di recente si sono susseguiti una serie di interventi sull’adeguatezza della politica e della classe dirigente lucana chiamata a innalzare i propri standard di intervento o a chiudere con certo disdoro un ciclo politico, rimettendo in tal maniera ai soliti noti il saldo salato dei costi di una crisi epocale. Dico classe dirigente in senso lato, considerato il clima di ulteriore sfiducia ingenerata nel cittadino lucano da avvenimenti sul genere dello scandalo Fenice, già divenuto il classico ginepraio fatto di omertà, scarichi di responsabilità e incompetenze di cui ogni giorno leggiamo.
Certo, in questo clima, è difficile prevedere se un certo mondo politico riuscirà ad autorigenerarsi (in mancanza d’altro all’orizzonte), come si attende Di Consoli, oppure, come auspica D’Agostino, saprà spiegare, con l’aiuto di un manipolo di impavidi, la tormentina necessaria per navigare il mare tempestoso della crisi (e desistendo, dunque, dalla distribuzione di incarichi a marinai più adatti a noiose e autoreferenziali bonacce portuali).
Però non vorrei, restando in metafora, che tenendo sotto controllo la cattiva circolazione arteriosa del malato, lo si perdesse per non aver badato a quella venosa, magari nel frattempo altrettanto bloccata. Una circolazione, quest’ultima, costruita sugli stretti rapporti tra società, amministrazione e politica in quella che è la Basilicata diffusa e dispersa dei medi e piccoli comuni.
Comuni che ci hanno dato prove di virtù civilmente battagliere, come fu per Scansano nel 2003 e per Rapolla e Melfi fino all’anno successivo. Ma pure contraddizioni socialmente scioccanti, come certi risultati comunali dell’ultimo referendum su nucleare e acqua pubblica o certe acquiescenze rispetto ai guasti ecologici portati dalle trivellazioni. Luci accese, luci spente. È dalla fine delle Guerre Sannitiche che il lucano non sa ancora decidersi per le furie guerriere o per la (troppa) pazienza contadina. E a volte, un mese prima del confronto elettorale, il basilisco si agita come una bambola spiritata, per poi (come se avesse un tasto nascosto) abbandonarsi al sonno fino alla successiva tornata.
Insomma, non si può che auspicare, per usare le parole di D’Agostino, che la tormentina abbiano il coraggio di aprirla anche i lucani. Recuperando, cioè, uno spirito modernamente battagliero di una società altrimenti latitante e l’apertura a un nuovo atteggiamento di vigile attenzione alla dimensione politica. Magari smettendo di pensare che in una situazione nazionale e internazionale come questa ci si possa limitare a lasciare la nave in balìa del mare, vale a dire tirando la quotidiana carretta, tentando di sopravvivere nel proprio piccolo. Invece la politica e l’amministrazione vanno ben scosse. Il voto è necessario, ma non sufficiente.
Ed è la società lucana che deve dire a se stessa, finalmente con verità, se abbia lasciato crescere una classe dirigente locale spesso inadeguata e incompetente purché foraggiasse inconfessati appetiti individualistici e calcoli familistici. Oppure se non sia altrimenti capace di esprimere dal suo interno una qualsiasi nuova dirigenza. E dunque se, nel primo caso, voglia darsi ancora una speranza rispetto alle onde che arrivano ormai a squassare il ponte o, nel secondo caso, alzare le spalle e ascoltare ancora per un poco i musicisti sul Titanic. Io credo che, dopo i dovuti mea culpa, l’asticella la si possa alzare. Penso che la società lucana possa pretendere da sé un po’ meglio, partorendo una classe politica finalmente diversa, che non sia l’area di parcheggio per trombati o incapaci di risolvere la vita altrimenti. È una cosa difficile, richiede del tempo, ma per fortuna non siamo in una sfera di immutabilità antropologica, ma in quella della stortura storica. Dunque emendabile.
E amministrare un comune non è per nulla facile, è noto. Ma vale ancora la pena di mantenere la barra su rapporti socio-politici che sono, nel migliore dei casi, la soddisfazione di un famulo, l’elargizione di una pensione, un pezzo di acquedotto, un lavoro di rifacimento? Altrimenti discariche a cielo aperto, buchi di bilancio paurosi, malversazioni di ogni tipo, giunte nate per continuare a coprire i dissesti di quelle precedenti.
Che questo genere di inadeguatezze, poi, fossero strutturali alla maggioranza della classe politica locale (salvo eccezioni) lo si è paradossalmente capito proprio con quei comuni che, invece, hanno potuto beneficiare di insperati maggiori introiti o possibilità di sviluppo e dove le risorse si sono sovente rivelate superiori alla quantità e alla qualità delle idee.
Va ovviamente compreso perché è stato così. E mi pare che si sia abbandonata troppo decisamente la vecchia, sana abitudine del meridionalismo classico di guardare e giudicare il contesto con strumenti socio-politici, piuttosto che esclusivamente economicistici.
Un’impostazione, quest’ultima che, riducendosi a considerare il Mezzogiorno una variabile dipendente da movimenti e decisioni economiche di natura esclusivamente esterna, contò di conseguenza su un intervento straordinario (fino al ’92) nel tentativo di innescare un qualche ciclo virtuoso di crescita. Invece, oltre agli innegabili risultati – e sapendo che anche ora dagli attuali frangenti la Lucania non può uscirsene da sola – si favorirono pure formidabili anticorpi proprio allo sviluppo infrastrutturale locale, rinforzando il pervertimento e la pervasività della politica nella società e foraggiando un ceto culturalmente povero, specializzato, più che a ben amministrare, ad accompagnare, controllare e gestire il flusso di danaro dal centro alla periferia (ovviamente con flussi diventati gocce). Come scriveva Trigilia: “qui più che altrove i politici hanno goduto di tanto consenso ma di poca legittimazione; hanno avuto cioè un consenso basato sulla capacità di soddisfare continuamente domande particolaristiche più che un consenso fondato su identità allargate e valori condivisi”. Insomma, “non avendo un consenso di tipo ideologico alle spalle, la classe politica locale” a ogni livello “ha usato tali risorse per interventi particolaristici e clientelari”. Tutto ciò con pesanti ricadute sulle comunità locali, rafforzandone, in un quadro di arretratezza economico-culturale, una storica tendenza alla questua, alla richiesta più o meno risolutiva della propria condizione individualistica o familiare (prova ne sia che, sia pure in un quadro di sviluppo debole e con una scarsa fornitura di servizi, il reddito medio e i consumi aumentarono). Ovviamente nell’incapacità comune di società e politica di andare oltre lo stimolo pavloviano, di immaginare mondi più progressivi e vivibili qualitativamente, magari affrontando per tempo i problemi con criterio, interessandosene con coraggio, abbandonando i vincoli costrittivi di comunità ma pure trasformandoli in valori e solidarietà condivisi.
E ora che i nodi inerenti un possibile decentramento amministrativo non si sono sciolti, ma anzi avvitati su se stessi non sostenendo adeguatamente uno sviluppo di forze endogene che promuovano scelte economiche positive? Ora che una crisi internazionale di proporzioni bibliche sottrae fondi e impone tagli dal centro rendendo la casta politica sempre più nervosa, sempre più tentata di rinchiudersi dentro le torri dell’autoreferenzialità e del privilegio? Ora che siamo di fronte a una costrizione della spesa senza rilanci produttivi e dei consumi?
Chi non si sentirebbe i piedi slittare nel vuoto? Tutto vero. Pure si abdicherebbe alla politica se, non si capisse che questa anomala condizione porta con sé anche inaspettate opportunità. E cioè che venga innanzitutto fuori una società locale capace di imporre alla politica uno scatto, ma anche capace di controllarne i passi.
Questo coraggio, oggi, è possibile. Basti guardare, ad esempio, a quegli spezzoni di società civile quali associazioni e movimenti che si sono impegnati a fondo nell’ultima tornata referendaria, molto di più di tanti esponenti e militanti dei tradizionali partiti politici. E, chi era a Grassano giorni fa, mi pare abbia ben registrato, con Di Consoli, l’esigenza profonda di “più società, meno politica”. Il che equivale a dire meno palazzo. Ci sarebbe bisogno, infatti, di una nuova classe di amministratori. Onesti non basta (l’onestà è solo il palleggio). Invece capaci di visioni disinteressate, capaci capire soprattutto i bisogni inespressi di una società, capaci di capire dove portare con passione una terra, di progettarla con rigore in uno sguardo che incateni il quotidiano al disegno complessivo. E poi ci sarebbe bisogno di una società capace di guardare al di là del proprio naso, che non si riduca a sopravvivere individualisticamente, che usi gli strumenti di democrazia per sospendere il voto dato, alla meglio, al meno peggio. Capace di smettere quel grigio ridurre e ridursi alla delega quotidiana in bianco (figlia storica, questa sì, di lunga pratica con poteri anche localmente deresponsabilizzanti).
La visionarietà non è, intendiamoci, fare i ponti di Messina (in Lucania ne abbiamo intere collezioni), ma è certo smettere di pensare che la sommatoria di piccoli passi amministrativi disarticolati possa essere in sé positiva. Sapere dove si va, insomma, oggi dovrebbe essere più importante. Il progetto complessivo (che subordina a sé il programma) è l’unico che possa dire dove chirurgicamente tagliare, dove poter promuovere, dove poter attingere eventuali nuove risorse. Si tratta di avere idee su uno sviluppo finalmente radicato e complessivo. Consultandosi. Cioè uscendo fuori dalle angustie del paesello, mettendo in rete, quella reale dei rapporti socio-politici, gli sforzi (non ci vuole mica Tremonti per leggere, in maniera costrittiva, quella che è la possibilità dei comuni di concertare collettivamente lo sviluppo invece dei tagli smettendola, magari, di azzannarsi anche per un mattone sul confine).
Utopie, si dirà. Ma, in alternativa, l’appiattimento su questo esistente? L’utopia è, l’ho già detto altrove, un carattere normativo della realtà. Una terra verso cui navigare, senza mai approdare o naufragare. Una terra, tuttavia, il cui mare chiede di essere costantemente solcato. Altrimenti, la terra che invece abbiamo sotto i piedi, quella per cui badare concretamente al giorno per giorno, potrebbe definitivamente affondare.
Recensione a: Giacomo Sartori, Cielo nero (Gaffi 2011)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 9 ottobre 2011.
_____________
Si ritaglia come la ribalta di un vecchio teatro d’avanguardia Cielo nero (Gaffi editore 2011, 224 pp., 16,00 euro), ultimo romanzo di Giacomo Sartori: una sedia, un letto, una padellina di alluminio per il thè, una tazza. Poi, solo poi, una stufa da tenere costantemente accesa, a sottolineare un gelo inestinguibile, il grigio dell’ambiente. Il luogo è il carcere veronese degli Scalzi, il tempo l’autunno del ’43: la guerra finita che continua. Nelle celle un pugno di protagonisti della storia del Fascismo in disgrazia. Il più importante è Galeazzo Ciano, prigioniero dopo aver votato contro Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo il 25 aprile e accusato di alto tradimento.
A perdere, come vorrebbe Giulio Ferroni, anche lo stile. Scabro eppure intenso, drammatico senza che mai si incontrino, lungo le trentadue scene che compongono il libro – fasi salienti tra il 20 ottobre del 1943 e l’11 gennaio del ’44 –, momenti di caduta o di bassa tensione. Un’asciuttezza, tra l’altro, che non può ingannare, se la narrazione poi si scopre ricca di una stratificata complessità, pur nella forzata, claustrale fissità del tempo, che la guerra scarnifica in quel buco nero della sopravvivenza che può essere il presente. E che tuttavia follemente, scompostamente, tenta di ribellarsi a se stesso, nella ricerca di un respiro in più, di un futuro sotto un cielo nero. Sempre suscettibile di accartocciarsi per un nonnulla o per un nonnulla animarsi di risorgenti speranze che immancabilmente rivelano, anche queste e sempre con maggiore durezza e violenza, il lastrico delle illusioni su cui scoprono di dibattersi.
Il romanzo di Giacomo Sartori non può ascriversi, dunque, al genere storico classicamente inteso, fatto com’è di scene e atti spesso non collegati da un filo narrativo diacronicamente rintracciabile, ma che va appunto per quadri. E la verità e la rigorosa documentazione storiche, utilizzate per tratteggiare il contesto e le figure di Ciano e di Edda Mussolini, poi si lasciano contaminare dall’invenzione letteraria, non nella ricostruzione di figure, ma nello sviluppo di personaggi che deve servirsi, come ha dichiarato lo stesso autore, di “intuizione e sensibilità” perché possano prender vita.
Pure, per certi versi, in Sartori lo sguardo profondo dello storico resta. Lo rivela Felicitas Beetz, la giovane spia inviata a carpire, nella sua cella, i segreti dei diari di Ciano da servizi segreti nazisti animati da chissà quali recondite brame di conoscenza, di controllo o diplomatiche. Infine illusioni anche quelle. Ma che ci danno la possibilità di guardare, con l’occhio dei tedeschi, Ciano e i gerarchi italiani. Rivelando al tempo stesso, come sempre in questi casi, molto dei giudicati, ma anche dei giudicanti. In un’osservazione relativa (in una verità relativa) che è tipica dello storiografo, ma anche sempre coinvolta e partecipata del personaggio se è vero che, sotto lo sguardo prima sprezzante di Felicitas, è già in atto la fascinazione, l’innamoramento per l’italiano.
Strana talpa questo personaggio femminile di Sartori che, attraverso il coinvolgimento sentimentale, sollecita la propria memoria, quelle di Ciano e di Edda, rintracciando così la sua e l’altrui dimensione psicologica e sbucando poi in quella collettiva, storica e politica. Una lettura di storie nella Storia o, meglio, la costruzione di una poetica “dell’individuale dentro il collettivo”, come brillantemente l’ha definita Roberto Antolini sul quotidiano “L’Adige”.
Ed ecco dunque Felicitas innamorata di Ciano, innamorata di un uomo “egoista, incostante, infedele, molto vanitoso, sprezzante, dispotico, vendicativo, a volte implacabilmente crudele”. Eccola a contatto con l’irresponsabilità fatta potere e il potere ridotto a esercizio familistico, assente di principi, dimentico del Paese, dimentico delle decisioni – anche gravi – prese il giorno prima, che si rappresenta problemi più grandi di quel che sono, sminuendo invece quelli che non sarebbero assolutamente da sottovalutare. Eccola alle prese con una sorta di codice genetico dell’italica politica, di un carattere nazionale degli italiani di cui tanti storici hanno voluto rintracciare la genesi proprio in un 8 settembre 1943, che è quel vorticoso dissolversi della presunta coscienza nazionale italiana. Caratteri che non evitano, tra l’altro, di muovere anche al ridicolo se il tentato suicidio di Ciano naufraga nella farsa, se il suo sussulto di dignità contro il regime risulta non solo ormai tardivo, ma basato sul calcolo sbagliato di rifugiarsi – come scrisse Indro Montanelli in una delle sue ultime “Stanze” pubblicate sul “Corsera” – proprio presso il suocero e Hitler, contando “sul familismo italiano, il quale ammette che in famiglia ci si tradisca, ma esclude che ci si ammazzi”.
E tuttavia Felicitas è innamorata anche di un uomo che, sorprendentemente, le cambia la prospettiva con cui guardare alla vita proprio nella sua fragilità, nella sua premura, nella sua imperfezione, nell’odore di morte che ormai promana. Anche nel risvolto della medaglia del suo tardivo fare retromarcia di fronte alle scelte del regime. Scelte che lui stesso ha contribuito a prendere, ma poi realizzando che ci si possa essere ingannati rispetto a un ventennio e alla firma di un Patto.
In Galeazzo, Felicitas Beetz ritrova e protegge, a rischio della sua stessa vita, il risorgere della propria tormentata coscienza affettiva e sentimentale, rivalutando infine quei rapporti familiari e interpersonali che l’ideologia ariana ha distorto con i suoi deliri e i suoi rituali di purezza germanica. La figura di Galeazzo si confonde, così, con il riemergere di un doloroso rimosso. Una pena angosciante, quella della Beetz, sepolta sotto il continuo esercizio di autocontrollo impostole alla Lega delle giovani tedesche e conclusosi con l’attiva partecipazione alla costruzione del Leviatano nazista: un primo padre artista (quasi profetico nei suoi disegni bui e scuri), oppositore del regime, morto suicida; l’evanescenza della figura materna; un patrigno dispotico che ne abusa e che viene alla fine scacciato dalla figura di Kurt, il biondo Kurt, che però non esita ad assegnare Dieter, il proprio fratello, al programma di eliminazione per handicappati, prima di morire ligio al richiamo del regime nazista in guerra.
Felicitas ama Ciano anche nella consapevolezza – nell’eventualità di una sua fuga o salvezza – che la dimenticherà come una delle sue tante amanti per correre subito da sua moglie Edda e dai suoi figli, senza il sostegno dei quali nulla sarebbe. Edda che ruggisce, che spera di salvare suo marito contro il volere del padre, ormai non si sa se più schiavo dei tedeschi o del suo stesso psicodramma. E che in questo ruggire s’illude che i diari di Galeazzo possano qualcosa, rappresentandosi una realtà che è completamente solo nella sua testa.
Mai come con il fascismo e il nazismo la realtà di tutti è stata permeata di delirio, di allucinazione, di disumanità. E a questo punto ci pare che la lezione di Sartori sia quella dell’inanità dell’individuo contro i frangenti troppo più grandi che alle volte la storia solleva. E tuttavia, se la storia ruota quasi del tutto intorno alla figura maschile di Ciano, pure ci sembra che la ribalta sia tutta dei disperati personaggi femminili di questa storia, capaci di incarnare un amore passibile, all’occorrenza, anche di definitivo sacrificio. Uniche capaci di accendere un cerino per non maledire del tutto l’oscurità calata sulla speranza di un mondo in guerra, uniche capaci di lasciare ancora un seme sul terreno indurito dal ghiaccio.
E tuttavia Galeazzo Ciano sarà fucilato l’11 gennaio 1944.
Giacomo Sartori, agronomo, vive tra Trento e Parigi. Ha pubblicato racconti e romanzi, tra i quali “Tritolo” e “Anatomia della battaglia”, tutti tradotti in francese. È redattore del blog letterario e culturale Nazione indiana.
Recensione a: Roberta Lepri, Il volto oscuro della perfezione (Avagliano 2011)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Blog di Stilos» l’8 luglio 2011.
_____________
Arte e letteratura con delitto
Sorprendente scrittrice Roberta Lepri, sempre pronta ad affrontare temi attuali e complessi, evitando con piglio sicuro i luoghi comuni e le opinioni preconfezionate di cui solitamente e irrimediabilmente si ritrovano incrostati. Era già successo con il suo La ballata della Mama Nera (Avagliano, 2010), breve romanzo dedicato ai Rom; accade ora con la raccolta di racconti Il volto oscuro della perfezione (Avagliano 2011, pp. 204, 14.90 euro) ispirata a quindici capolavori dell’arte, da Leonardo fino al conclusivo Urlo di Edvard Munch, passando da Michelangiolo a Raffaello, da Giorgione a Tiziano, da Caravaggio a Renoir, da Modigliani a Picasso.
E dunque nessuna apologia degli artisti giocata sul binomio genio-follia con tutto il corollario di depressioni, melanconie, esaltazioni della mente. Nessuna infatuazione elitaristica e romantica per l’arte. Ma una prospettiva ugualmente moderna e affascinante, se l’opera d’arte è una porta sul tempo, una corda tesa e vibrante che unisce il passato al presente e alle volte direttamente ci ammalia con gli occhi coinvolgenti del piccolo della Madonna Litta oppure ci attira e coinvolge con lo sguardo suadente di una modiglianesca Jeanne Hébuterne.
Documentandosi rigorosamente, la scrittrice grossetana interagisce creativamente con le opere che la ispirano. Spalancando le finestre su un mondo fatto di botteghe, lavoranti e committenti, aprendo porte su vicoli stretti e lerci, contadi spopolati e brulli, ricche corti nobiliari, conventi, cantine e musei. Persino entrando nei meccanismi creativi e nelle concezioni filosofiche sottese, ma pure nel fisico provato, ammalato, nel disfacimento della carne. Fino alla piena comprensione degli usi sociali del tempo, fino – l’autrice laureata filologa sulle Rime del Buonarroti – alla misurata ed elegante mimesi linguistica nel dialogo e in certi toni della scrittura sempre ben adattati al secolo affrontato.
Di conseguenza, sulla scorta di quanto indicato dal critico Mauro Papa nella sua prefazione alla raccolta, è anche vero il passaggio inverso, e «poco importa se Michelangelo non avesse mai visto un morente in Maremma» per lasciarsi ispirare a scolpire la Pietà o se Raffaello non fosse stato avvelenato a seguito delle vicende che lo portarono a ritrarre La Fornarina. Perché Roberta Lepri impregna a sua volta il passato e quelle opere non solo della sua partecipazione emotiva, ma anche della sua creatività di scrittrice, dei suoi interessi, soprattutto dei suoi valori. In una parola della sua contemporaneità.
Ecco allora le vicende occorse attorno al dipinto della leonardesca Madonna Litta farsi di colpo moderne nel genere, assumendo tinte fosche e sinistre. E così molti altri episodi macchiarsi di delitti efferati, ma pure di più «prosaici» furti o truffe e, ancora, di suicidi e malesseri, tanto dell’anima quanto della carne, di invidie e irriducibili rancori. Così come una Tempesta del Giorgione può aprire uno squarcio temporale in grado di riscattare, facendone modello per una «natività» fuori dagli schemi, una prostituta albanese. E una ricerca assegnata a una studentessa trasformare quest’ultima in una sorta di detective che, indagando su due rappresentazioni della Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi, si ritrovi a punire con eleganza il piatto maschilismo di un poco chiarissimo professore universitario.
Sempre si rintraccia dunque nel bello artistico di Roberta Lepri una tensione etica, di cui l’autrice sceglie per sé fermamente il versante luminoso pur sapendo e accettando, per gli artisti di cui s’appassiona, l’andante goethiano per il quale «là dove è più forte la luce, l’ombra è più nera». Anche quando ciò dovesse comportare la punizione esemplare di un discepolo capace di mettere sulla tela la vertigine perfetta dell’imperfezione. Punizione di cui appunto resta il dubbio se comminata per l’atroce delitto di cui l’allievo s’è macchiato, o per lo schiaffo subìto dal maestro (Leonardo, in tal caso) colto in un momento di particolare scacco realizzativo delle sue creazioni.
Una tensione, un dialogo verticale e oppositivo mirabilmente esemplificato dalla figura stessa della Maddalena di Tiziano Vecellio, una bellezza «risultato di due inconciliabili opposti nel momento preciso del loro incontro»: povertà e ingegno, semplicità e complicatezza, «i porci e la vetta delle Dolomiti, tutto insieme», la sintesi della vita in punto di morte. Una morte capace di sgorgare da un amore così assoluto, da esaltare e nel contempo ingoiare tutto, come poi insegnerà la vita cannibale o il male di vivere di Modigliani. La morte che rimane, angoscioso rumore di fondo, come Urlo distorto, permanente, di tutta una vita.
Recensione a: Giuseppe Aloe, La logica del desiderio (Giulio Perrone Editore, 2011)
Questo articolo è stato pubblicato su «Scritture & Pensieri» il 19 giugno 2011.
_____________
Conquistato e travolto dal fascino di una donna tra desiderio e angoscia
L’ultimo romanzo di Giuseppe Aloe, La logica del desiderio (Giulio Perrone Editore, 2011, 212 pp.), è un’éducation sentimentale sensibile al tempo psicologico e più intimo della voce narrante. Una vita collocata a ridosso di confini geografici e dell’anima ugualmente indefiniti, e perciò continuamente sofferenti di spaesamenti linguistici, cognitivi, affettivi. Scelte confermate dall’uso coinvolto di una narrazione in prima persona, densa e materica, sia pure filtrata attraverso i toni di una memoria dei fatti già decantata.
Il lettore incontra dunque il giovane protagonista, romanziere e filosofo in erba, immerso in un tempo “senza spessore, né profondità”, autosufficiente: letture, scrittura, un rapporto con il padre vedovo mosso appena da naturali confronti generazionali. Pure, ben altro tempo lo aspetta quando l’incontro con la fascinosa Vespa (una donna o una pericolosa malattia dell’anima?), per la prima volta, pungerà la sua carne con il veleno del turbamento e di un desiderio urgente e ossessivo che finisce per corrugare di sé anche la narrazione. Una risacca di onde lunghe, di tempi distanti che ora ripassano incessanti e lenti, sfiorandosi e frangendosi nella memoria. Che è una breve stagione d’estasi subito seguita da un mortificante, mai definitivo abbandono da parte dell’irrequieta amica, dalla presenza disturbante e burrascosa del marito e di altri amanti, dalla morte del padre dopo una penosa malattia che lo spegnerà lentamente. E dunque paura e angoscia e un fardello di morte che è, blochianamente inteso (in uno dei passaggi più alti del romanzo), “salasso della speranza”, sfinimento del desiderio e liberazione di un dolore senza limiti.
Un destino che per vie diverse travolgerà momentaneamente la donna e consumerà la luce del suo giovane amante, almeno fino all’apparizione della purezza e dell’amore di Agneta. Il ritorno a un tempo più lineare, ma pur sempre inquieto di una Vespa sottotraccia, minacciosa della sua ombra che non manca, ancora una volta, di allucinare e quasi di uccidere, questa volta fisicamente, il protagonista in un incidente. Perlomeno fino al riemergere, sotto un cielo nevoso, ovattato, eppure paradossalmente cristallino, della speranza di Agneta. Una nuova nascita o la guarigione da una penosa e logorante malattia se il desiderio – lo si capisce sulla propria pelle – ha per unica logica quella della sua spasmodica, informe illogicità.
Recensione a: Pierre-Joseph Proudon, Contro l’Unità d’Italia: articoli scelti (Miraggi, 2010)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 29 Maggio 2011.
_____________
L’Italia federalista di Proudhon
‘Contro l’Unità d’Italia’, scritti del filosofo nel volume curato da Biagini e Carteny
Guardando alle manifestazioni relative ai centocinquanta anni dell’Unità italiana, una cosa è sicura: che in merito, più di aver bisogno di celebrazioni, avremmo avuto bisogno di profonde e prolungate riflessioni. Tuttavia, si sa, ogni commemorazione finisce per risentire del clima e – direi – dello stato di salute intellettuale del momento che, già da un po’ di anni a questa parte, non sta certo giovandosi di tersa aria d’altura. E così abbiamo seguito commemorazioni spesso storicamente piatte e culturalmente asfittiche, ma soprattutto orientate dalle ansie e dalle paure politiche del momento, con il protagonismo della Lega Nord a inibire o distorcere ogni serio dibattito storico su quante lacerazioni la Penisola abbia vissuto al momento della sua unificazione attorno al corpo del vecchio stato sabaudo. E dunque peana a Mazzini, Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele più di uno spot tv. Ma poco, ben poco, su brigantaggio e questione meridionale, sui movimenti autonomisti isolani, o ancora sui contrapposti modelli amministrativi “prefettizio” e “regionalista”. Poco o nulla, insomma, su uno dei delicati passaggi di quel fare gli italiani che è passato attraverso le spinte e le richieste dal basso per la decentralizzazione. Un certo modo di insistere sull’Unità e sui suoi personaggi più popolari che, lungi dal dimostrare la forza di un concetto, rivela semmai con quanta poca convinzione oggi ci si accinga a sostenere un’idea piuttosto bistrattata.
Stante così le cose, non si può che plaudire, allora, al coraggio della casa editrice Miraggi di Torino per aver dato alle stampe – curato da Antonello Biagini e Andrea Carteny (rispettivamente presidente e segretario del Comitato di Roma dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) – alcuni articoli scelti del francese Pierre-Joseph Proudhon riuniti sotto il titolo “Contro l’Unità d’Italia” (128 pp., 16,00 euro).
I primi due interventi “Mazzini e l’unità italiana” e “Garibaldi e l’unità italiana”, entrambi scritti a Bruxelles rispettivamente il 13 luglio e il 7 settembre 1862, furono raccolti nello stesso anno nel volume “La fédération et l’unité en Italie” (pubblicato a Parigi dal libraio-editore E. Dentu). E tuttavia forse sarebbe stato meglio aggiungere anche il terzo pezzo che confluì nel libro, quel “La presse Belge et l’unité italienne” troppo frettolosamente liquidato come “legato maggiormente a argomentazioni di interesse belga” e del quale, almeno i capitoli centrali, dedicati alla “Question italienne” e alla “Question papale” potevano essere utilmente proposti al lettore. Così come si sarebbe potuta chiarire meglio la scelta di inserire nel volume della casa editrice torinese la lettera al redattore capo del “Messager de Paris” intitolata “Nuove osservazioni sull’unità italiana” e che, scritta il 10 dicembre 1864, costituisce con “Del principio federativo” del 1863 uno dei risultati più maturi della riflessione del rivoluzionario francese.
Ma l’interesse per il volumetto pubblicato dalla casa editrice torinese resta altrove. Innanzitutto nello spiegarci che, ben prima del ’48 e almeno fino al ’61, per la maggior parte dell’opinione pubblica italiana (dai nobili al clero, dall’alta borghesia fino ai ceti medi e piccolo borghesi) la soluzione per l’unificazione fosse eminentemente federalista (o confederalista) e non centralista, come poi ebbe però modo di realizzarsi. Avevano operato a lungo nella formazione di quella opzione dapprima il pensiero neoguelfo e liberale giobertiano e poi la pragmatica concezione delle “piccole patrie” di Cattaneo, non senza che si passasse attraverso pensatori quali Cesare Balbo, Durando, Montanelli, Ferrari ecc. Non a caso nell’agenda politica di quei tempi l’ordine del giorno era una nuova “lega italica” possibile alla luce delle unioni doganali già realizzatesi tra stato Pontificio, granducato di Toscana e regno Sabaudo. Tanto che lo stesso trattato di Plombières, sottoscritto da Cavour e da Napoleone III, aveva previsto l’unione dell’Italia costruita su quattro stati: un’Alta Italia sabauda, un’Italia centrale, il Lazio pontificio, il Regno delle Due Sicilie (un escamotage che avrebbe dovuto, tra l’altro, nei progetti dell’imperatore, facilitare la solita assegnazione familistico-nobiliare delle corone, così pure per indebolire la crescita di un altro possibile stato antagonista ai confini della Francia).
Lasciava propendere per un’unificazione su base federalista anche la struttura geografica e politica dell’Italia, con la presenza di una miriade di comuni e di città accesi della loro autonomia. Spiega Proudhon – peraltro ben ispirato sull’Italia dal fedele amico Ferrari – “chi dice impero in Italia dice protettorato… un potere che la protegge e non la comanda… Ma più gli italiani sentono il bisogno di questo protettorato, più ne diffidano, sapendo perfettamente che, in politica, colui che protegge è il padrone”. E più avanti, riguardando acutamente alla storia: “l’Italia è in perenne antitesi con l’unità; essa contrappone senza posa impero, monarchia e papato nell’interesse delle sue franchigie, e cerca… in questo eterno antagonismo, una sintesi impossibile. Più di ogni altra cosa, l’Italia tiene alle sue libertà regionali e municipali: essa è federalista e non lo nasconde”. Un tratto caratteriale positivo – salvare la propria autonomia giocando sulle frizioni tra papato e impero sempre coinvolgendoli ed eludendoli a un tempo – in seguito pervertitosi, proprio grazie alla burocratizzazione dello stato unitario, nei mille malfunzionanti localismi odierni.
Il federalismo di Proudhon era di matrice socialista, mutualista e tendente il più possibile a dividere i poteri dello stato. Per il francese l’unità su base nazionale, ponendo un problema politico accentratore, nascondeva in verità “che ciò che costituisce la patria è il diritto, assai più che gli accidenti del suolo e la varietà delle razze” invece agitati dai “finti democratici” per evitare di guardare ai gravi problemi sociali del loro tempo. “In tali condizioni”, scrivono Biagini e Carteny, dopo il crollo dell’anello debole costituito dal regno borbonico “la stabilizzazione non poteva non realizzarsi attraverso la ‘conquista regia’ e l’annessione al Regno di Sardegna: il Regno d’Italia… era giuridicamente un ampliamento del Regno di Sardegna”. Dunque senza alcuna spinta emancipatrice popolare dal basso (le masse diseredate, la stragrande maggioranza degli italiani, non avevano quasi contezza del concetto di “Italia”. È noto che, quando gli insegnanti piemontesi furono trasferiti in Sicilia per l’educazione all’Italia delle nuove generazioni, vennero scambiati per inglesi), l’unità si sarebbe rivelata presto un giochetto “bancocratico” e autoritario fatto dai borghesi per favorire i borghesi.
È dunque anche su questo ultimo punto che si consuma lo scontro con Mazzini, Garibaldi e la loro impazienza rivoluzionaria per la mancata annessione al giovane regno di Venezia e di Roma (e che porterà all’episodio di Aspromonte). Appare insomma chiaro, dopo il sussiegoso ritiro dell’appoggio di Mazzini a Vittorio Emanuele a causa di ciò, il tentativo del primo di non perdere la faccia dopo le patenti compromissioni con la corona sabauda (sorretta in guerra, per giunta, contrariamente al credo mazziniano, da armi straniere e, per giunta, filo-papali). Con un inasprimento rivoluzionario di facciata dimentico del pressante problema di organizzazione dei ventidue milioni di italiani già inglobati nel regno, così mortificando e subordinando di fatto la realizzazione rivoluzionaria della repubblica al disegno conservatore dell’unità sabauda.
Un’impazienza che avrebbe travolto anche Garibaldi sull’Aspromonte, un Garibaldi verso cui comunque Proudhon nutrì certamente più rispetto: “Un mese fa Garibaldi era la più grande e nobile personalità d’Italia; cosa resta di lui ora? Cosa resta del suo partito? Pallavicini ha dimostrato… che se Vittorio Emanuele lo voleva, ne era padrone. In tutta questa vicenda un solo uomo è rimasto in piedi, Mazzini, colui che ha preparato l’impresa, che non ha contribuito in nulla alla sua realizzazione e che ha ancora il coraggio di lamentarsi dell’inettitudine di Garibaldi. Povero Garibaldi!”.
_____________________
Tanto sfortunato quanto tenace
Senza libri né dizionario è l’unico allievo a seguire le lezioni scalzo
“È la prima volta che vedo il mirabile polemista. La testa di questo Franco-Conteo mi ha vivamente colpito. La fronte è magnifica, l’occhio cristallino e profondo, ma duro. L’insieme della fisionomia ha qualcosa di brutale e di astuto al tempo stesso. Egli ha prodotto su di me un’impressione imponente e sgradevole che non è stata attenuata dalla sua parola rapida, rauca e tagliente. Mi pare che ci voglia del tempo per abituarvisi e per nutrire simpatia per lui”. Questo il ritratto di Proudhon lasciatoci dalla penna del futuro comunardo Gustave Lefrançais. Un volto dai tratti sussiegosi e tenaci, forgiatisi nelle ristrettezze e nelle prostrazioni della Francia post- napoleonica; tratti tuttavia sempre accesi di un’intelligenza potente, penetrante, avida fino al limite dell’ingordigia.
Un volto della storia e del mito, quello di Pierre-Joseph: eletto deputato dopo i moti rivoluzionari del ’48 (ma ne è subito deluso); fondatore di una “banca del popolo” con denaro imprestato senza lucro, poi fallita; condannato più volte per gli attacchi a Luigi Napoleone di cui subito comprende, nonostante alcune ambiguità, le mire che lo porteranno a farsi proclamare imperatore di Francia; instancabile redattore di giornali politici; scrittore caustico, abilissimo polemista, autore, nel 1840, di una delle opere fondamentali del socialismo, quel “Che cos’è la proprietà?” opera scandalosa come quante altre mai nella sua tesi di fondo (“è un furto”), denunciata da un liberalismo vincente, ma incapace di ogni riforma sociale. Della classe sociale che lo incarna Proudhon, infatti, non s’illude: per la sua “medietà” la borghesia non ha uno spirito di governo, cerca nel sistema costituzionale solo maggiori garanzie conservatrici, ma all’occorrenza resta pronta ad aggrapparsi a un qualsiasi “salvatore per ristabilire l’ordine, ovvero l’ineguaglianza che le è necessaria”.
Insomma, Proudhon, chi era costui? Pierre-Joseph nasce nel 1809 in un quartiere popolare di Besançon, quinto figlio del vignaiolo e bottaio Claude-François, uomo di rigida onestà, che non manca di rovinarsi rifiutandosi di lucrare sul prezzo dei prodotti della sua birreria. La madre, Cathérine Simonin, è invece donna energica, di grande fierezza, figlia di un popolano sempre in rivolta contro le angherie dei signorotti locali. Il piccolo Proudhon è presto consegnato ai lavori rustici e al pascolo delle vacche a Doubs, venti chilometri lontano da casa, dalla nonna.
Mai stato fortunato Proudhon, anche a dispetto della sua erculea forza di volontà. Nel ’42, pur di poter conversare con il suo amico Bergmann, percorre a piedi 80 leghe (una lega di posta corrisponde a circa quattro dei nostri chilometri) solo per scoprire che dal giorno prima non è più nella città dove lo cerca. Ma le avversità lo sferzano ben prima. Già nel 1820 entra, grazie a un amico di famiglia, nel collegio della città natale, diventandone uno dei migliori allievi. Scrive di quegli anni: “Mancavo abitualmente dei libri più necessari; feci tutti i miei studi di latino senza un dizionario; dopo aver tradotto in latino tutto ciò che mi forniva la memoria lasciavo in bianco le parole che mi erano sconosciute e riempivo poi i vuoti alla porta del collegio” imprestandosi i libri. È l’unico allievo a seguire le lezioni scalzo, dopo aver lasciato i pesanti zoccoli di legno alla porta, perché fanno eccessivo rumore. Ma la fortuna – se possiamo chiamarla così – gira presto e nel 1827 deve abbandonare gli studi per le solite difficoltà economiche, impiegandosi come correttore e compositore di bozze. Più avanti gli muoiono un fratello nell’esercito (misteriosamente, ma forse a seguito della scoperta di una malversazione di un suo superiore) e la figlia prediletta Marcelle, di colera. Di quest’ultima sciagura scrive lapidario in una lettera del 1854: “È così che la sorte punisce le nostre vanità”.
Legge di tutto accanto agli estratti rimastigli delle opere regalategli dal collegio, che è stato costretto a vendere tra le lacrime della madre. Nulla pare piegarlo. Quasi medianicamente ispirato (“Non sono padrone della mia parola, il mio stile ha qualcosa di strano che disorienta i lettori, sono lo strumento di una forza oscura e tirannica che non posso né contenere né regolare”) trova modo di imparare l’ebraico semplicemente correggendo un testo con traduzione, studia la teologia, la linguistica, vive acutamente i fatti economici e politici del suo tempo, legge l’utopista Fourier. Ben presto si scopre ateo. E socialista.
Eppure, nel 1865, anno della sua morte, Proudhon pare aver perso ogni sua battaglia. Del suo progetto di prestito senza interessi agli operai s’è detto. Con Marx, che ne oscura la stella, non segue miglior fortuna. Dopo l’iniziale amicizia, tutto li divide: la dialettica (per Proudhon resta un sistema aperto, antinomico, senza “sintesi” finale), il concetto di proprietà (Proudhon, almeno in un primo momento, elimina la proprietà privata dei mezzi di produzione, ma non elimina la proprietà «di fatto», quella che chiama «possesso»), quello di plusvalore, la funzione storica dello stato (le implicazioni anarchiche del suo pensiero saranno sviluppate in seguito dal russo Bakunin). Li separano persino le reciproche ingenerosità. Non basta. Convinto federalista, Proudhon vede realizzarsi sotto i suoi occhi il sogno unitario-annessionista dell’Italia. Spesso, come per la questione belga, è ampiamente frainteso. Nel ’64 scrive con amarezza: “Ho la testa debole, il corpo colpito, il petto come una piaga, la bocca bavosa, il cuore pieno di amarezza. Non mi resta che l’affetto degli amici, senza il quale chiederei di morire”. Si spegne un anno dopo.
Ma – vendetta? ultima beffa della sorte? – tutta la fortuna di Proudhon è postuma. O quasi. Perché i suoi contemporanei già lo conoscono, per nulla a torto, come il “Grande presbite”. Predice con molto anticipo, s’è visto, la parabola di Luigi Napoleone. Nell’Unità italiana individua con precisione le debolezze costitutive che ne metteranno diverse volte in difficoltà il processo evolutivo. Nel 1840, circa ottanta anni prima della rivoluzione bolscevica, ha già denunciato il possibile carattere regressivo del comunismo. Scrive nel 1846 con lucidità impressionante: “Dopo aver soppresso tutte le volontà individuali, il comunismo le concentra tutte in una individualità suprema, che esprime il pensiero collettivo… Così, per il semplice sviluppo dell’idea, si è inevitabilmente portati a concludere che l’ideale del comunismo è l’assolutismo. E vanamente si potrebbe prendere come scusa che questo assolutismo sarà transitorio: se una cosa è necessaria un solo istante, essa lo diventa per sempre, la transizione è eterna”.
Pensieri che, fuori dagli ambienti libertari, iniziano a riprendere terreno, in Italia, a qualche anno dalla rivolta di Ungheria, grazie a Franco Ferrarotti. Nel 1978 è Bettino Craxi a servirsene per il suo “Nuovo corso” in un documento pubblicato su ”L’Espresso” con cui inizia la manovra di attacco al centralismo democratico del PCI. Seguirà, un anno dopo, una più articolata dissertazione di Luciano Pellicani nell’introduzione al proudhoniano “Del principio federativo”, non a caso edito a cura delle edizioni Avanti!
Ma già nei primi Ottanta, gli anni della “Milano da bere”, dei contenuti propositivi della svolta craxiana-libertaria rimane ben poco: non il coinvolgimento delle classi lavoratrici nei processi decisionali, non “la diffusione del potere”, non “la distribuzione ugualitaria della ricchezza e delle opportunità di vita”. E del resto, sulla “socializzazione dei valori della civiltà liberale”, su cui Craxi finirà per avvitarsi, Proudhon ha già posto la sua pietra tombale. Il francese fa accapponare la pelle più di una centuria di Nostradamus quando mette altrettanto in guardia da una civiltà e da “un’esistenza piena fino all’orlo di delizie, ma la cui aridità non lascerebbe più spazio ai sentimenti.
Lettera al Direttore Paride Leporace sulla lettura in Basilicata
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 29 Maggio 2011.
_____________
Caro Paride,
come ben sai lavoro in editoria da un po’ e, sia pure con un poco di ritardo e dopo qualche esitazione, non mi dispiace confrontarmi con l’indignato garbo della Signora Rosaria Scaraia sul “Quotidiano” di qualche giorno fa. Benché, sia bene inteso, l’argomento – la lettura dei libri in Basilicata, regione fanalino di coda in questo genere di maggiore o minor amena attività –, io lo affronti ormai solo con l’ottimismo della volontà, ché la ragione ha qui già da tempo buttato la spugna.
Dunque, riassumendo velocemente: per la Scaraia lascerebbe l’amaro in bocca scoprire che “i dati contenuti nel report pubblicato dall’Istat rivelano che l’anno scorso solo un lucano su tre” ha letto un libro “per il piacere di farlo (e non per ragioni di studio)”. E sconcertante “scoprire che, due famiglie su dieci, di libri in casa non ne hanno neppure uno”. Ed è la realtà, non discuto. Soprattutto a fronte del legame tra istruzione e reddito medio territoriale che la Scaraia individua come ragione di uno specifico ritardo locale sul tema.
Però a questo punto, io mi chiedo: è davvero una specificità quella lucana o in Lucania è solo più approfondito un abisso comune? E non dico di fronte ad altre regioni meridionali, ma pure rispetto a quelle con più alto reddito. Insomma il meccanismo istruzione/reddito si rivela davvero così meccanico? Ho i miei dubbi. Non lo affermo ovviamente perché la Lucania possa così trovare un’utile foglia di fico (non so quanto larga, del resto) alle sue “insopportabili” mancanze (che restano dunque mancanze da emendare), quanto perché il declino della cultura del libro in Italia è generale. Certo più marcato al Sud, ma comunque assai diffuso. Perché il problema non è solo nell’analisi quantitativa del dato, cioè il rapporto spesa/libro, ma va oltre, fin nel suo vero nocciolo malato, cioè il rapporto libro/lettura.
Signora Scaraia, se lo lasci dire da uno che vive le magnifiche sorti e progressive della civile e avanzata Toscana, che si fa le fiere letterarie e librarie a Roma, a Torino, a Pisa e altrove. La gente che gira interessata (intendo il lettore medio) poi è sempre la stessa. Una minoranza importante per la sopravvivenza del libro, ma spesso pure ombelicale, autoreferenziale, e di cui ho imparato anche a diffidare, perché spesso si incaponisce a leggere libri alla “Firmino” e ad autorassicurarsi che “leggere è bello” e che “il libro non finirà mai” in saecula saeculorum. Invece, faccia la prova: se regala a un compleanno un libro (non solo a un giovane e se non già bulimico lettore) il festeggiato la guarderà quasi sempre con stampato sulla faccia un mal dissimulato “ecchene n’antro!” dove per altro dovrà necessariamente intendere “lo sfigato di turno”. Figuriamoci sostituire o accompagnare con un bel volume la “busta” da consegnare a una felice coppia di nuziandi: apriti cielo! e giù familistica riprovazione fino alla settima generazione!
La verità è, invece, opposta, ché in Italia, mica solo a Potenza e Matera (anche se ci ingegniamo sempre a fare peggio), si è consumato ormai storicamente il distacco definitivo tra produzione di benessere e produzione di cultura. Ma ce lo vede “il modello vincente” Briatore a pubblicizzare la lettura?
E poi, anche se così fosse? Le case dei lucani, come del resto dei meridionali, sono piene di libri e enciclopedie vendute negli anni ´60-´70 dai commessi della Fabbri, della Laterza ecc., e comperati in un momento in cui oltre alle pentole e agli aspirapolvere c’era una minima capacità di spesa anche per un po’ di carta stampata. Certo, non c’era la volontà di leggere in chi s’era appena elevato economicamente al rango di piccolo-borghese inurbato, però forse c’era la speranza che i figli potessero farlo in vece loro prima o poi. Che calcolo sbagliato! Ché invece i figli se ne sono andati e per loro, per i genitori del “Boom”, non poteva che finire com’era iniziata, perché in Italia la Lettura è sempre stata scritta con la L maiuscola, come la Cultura con la C grande, ammettendo già con questo tra le righe che trattavasi di roba maneggiata dai galantuomini per fottere il prossimo oppure attività dal significato oscuro e di nessun interesse. E dunque, certo in non tutti i casi, considerato il modello così alto (LA CULTURA) doveva finire così: che i Libri potevano continuare a farsi le cose loro (arredo e status) nei soggiorni buoni e, di lì, a sviluppare muffe. E, del resto, i tardi lettori in erba iniziato poi lo “sboom”… ma sì, chi tiene tempo?
Non parliamo del contributo della scuola d’antan: un romanzo, una poesia? roba buona per riassumere o per mandarla a memoria a forza di girare attorno a un tavolo fino a sfinimento (ricordiamo ancora i “Riassumi!”, i “Tema!”, i “Ripeti!: La Vispa Teresa avea tra l’erbetta…”, degli scolastici sketch stralunati e non-sense di Cochi e Renato?). Come non disamorarsi e averci sulle balle Carducci, Manzoni e Omero e poi, per riproduzione di spiacevole sensazione introiettata, evitare la lettura autonoma di un Pagliarani, di un Pirandello, Svevo, Moravia, Patti?… Ma se io, per aver citato Pasolini, beccai uno dei miei più memorabili cinque in un compito scritto di italiano con professoressa che tra un sonno e una “Corona” di Rosario, vecchia com’era, ricordava pure con orripilata indignazione di aver fatto scuola con il sovversivo Riviello?
Certo non tutto è perduto, ad esempio, se si pensa all’aumentato numero di lettrici in Italia. Ma soprattutto se ci si darà da fare ancora e meglio. Però i coupon da spendere in libri, da soli, sono come l’alfabetizzazione informatica in Basilicata: non basta cioè comperare i computer a tutti, anche al contadino o al sessantenne, perché questo, in un momento, metta a frutto le potenzialità dell’ordigno. E le potenzialità sono oggi già di più se, proprio grazie al collegamento Internet, posso essere messo in grado di comprare quel libro che la totale mancanza di una rete di librerie sul territorio mi impedisce.
Parliamoci chiaro, Signora Scaraia, in realtà non le sarà sembrato, ma io sono con lei: io non leggo solo i dati Istat, ma pure quelli AIE (Associazione Italiana Editori) e le dico che, secondo me, la nostra generazione è quasi del tutto perduta alla lettura e, per certi versi, alla cultura. Pensi solo quanto sia arretrato il nostro italico e romantico “vissi d’arte” usato da tutti gli scrittori (migliaia) che inondano le case editrici di manoscritti (migliaia) senza nemmeno aver letto due libri in vita loro.
I forti investimenti che la Regione e le Province devono fare (ma ci vogliono dei bei “dindini” Signora, come si dice in Toscana) sono per la fascia di lettori oggi più diffusa e potenziale: i preadolescenti e gli adolescenti (e oggi son pure pochi e dunque che si investa e poche chiacchiere!). E devono essere investimenti tesi mica solo a favorire l’acquisto dei libri: ben altre idee creative ci vogliono, ben altre sfide per i nostri locali politici, ben altri circoli virtuosi tra istruzione scolastica sostenuta per l’obiettivo libro, lettura dei giornali, visite alle fiere, uso di internet, piccoli corsi su cos’è un libro e come si legge, premi per i più piccoli, incontro con gli scrittori, ecc. Si ha bisogno, insomma, di quello che si potrebbe denominare la “creazione di un sistema lettura” sollecitando tra i giovani un interesse che poi, la fascia generazionale investita, avanzando d’età, potrà lasciare come speranza alla generazione successiva (creando dunque anche qui un circolo virtuoso) prima che ogni interesse si spenga. Non a caso è assodato che ci siano più possibilità che scatti l’interesse per la lettura nel bambino che a casa vede leggere. Sottolineo: non il bambino che contempla libri-soprammobile e tendenzialmente intoccabili (“ché si sciupano!”), ma che vede leggere attivamente un quotidiano, un libro ecc. Infatti qui non si tratta solo di acquistare un libro, ma di giungere alla consapevolezza che il libro è o uno strumento tecnico per imparare (non solo a scuola) oppure un modo (parlo di romanzi e poesia) per accedere a una qualche notizia del mondo, a un’esperienza di vita, a una nuova e più fresca visione delle cose che possa rinnovarci, renderci più ricchi, più aperti, meno provinciali. E ciò vale per la carta o l’e-reader che dir si voglia.
Ho parlato poco prima di speranza che si possa recuperare una generazione alla lettura: perché un interesse non si sa mai se, perché e quando possa o meno scattare (è nota di Pennac, ad esempio, la non gloriosa carriera scolastica), ma questo non deve esimerci dall’attivarci per tentare ogni strada con l’obiettivo di favorire alla lettura, alla cultura, un contesto più propulsivo, altro, alternativo all’egemonia della società dello spettacolo in cui siamo immersi fino al collo.
Recensione a: Luigi Bernardi, Niente da capire (Perdisa Pop 2011)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 27 Marzo 2011.
_____________
Tredici storie senza mistero
La svolta critica di Luigi Bernardi
“All’inizio del 2010 capisco che il giallo e il noir, narrazioni che ho tanto amato, sono ormai una caricatura di loro stesse… Non è un’abiura. Ho lavorato tanto perché le scritture di genere ottenessero successo e stima, adesso che hanno conquistato le classifiche di vendita, scendo dal carro dei vincitori e inizio una nuova battaglia”. Questa la forte dichiarazione di Luigi Bernardi, padre del noir italiano e maestro di molti scrittori ascritti al genere giallo (e dintorni), resa a Stefania Nardini per il settimanale “Scritture & Pensieri”.
Titolo dell’intervista, eloquentissimo: “Il noir? una truffa”. Titolo del libro presentato dall’intervista, altrettanto eloquente: “Niente da capire” (Perdisa Pop, 2011, 144 pp.). Soprattutto perché dovrebbe trattarsi di un noir. In realtà perché è un libro di grande qualità al di là del genere. Genere che, anzi, Bernardi mira a depotenziare, oggi così legato al successo e agli incassi del largo consumo, eppure mai così estenuato, senza più sugo. Un genere fatto preda di trasmissioni televisive famelicamente alla ricerca di audience, tanto da “fictionalizzare” tragici fatti di cronaca, calati a bella posta in paranoici viluppi al limite dell’inverosimile o del ridicolo. Dove si aspetta che una dichiarazione o una ricostruzione possa aprire finalmente a chissà quali nuove verità, in realtà continuando ad aggiungere particolari inutili. Arrovellandosi su moventi e su “perché” inattingibili che regolarmente svergognano i deliri di onnipotenza della Scientifica (ideologicamente covati nelle fiction tv), l’ultima dichiarazione dello psico-criminologo alla moda o un’indagine male impostata fin dall’inizio.
Luigi Bernardi scrive, invece, “Tredici storie senza mistero” (questo il sottotitolo del libro) che sono tanto meno misteriose quanto più, in alcuni casi, somigliano a casi conosciutissimi di cronaca quali ad esempio quello di Erba (“Lei ringhia oltre la parete”) o di Perugia (“Hillary aveva sonno”) dove si sono spesi fiumi di analisi e futili chiacchiere. Storie costruite con uno stile “a perdere”, asciutto, essenziale eppure sempre con un’anima. Ché, con tutta evidenza, Bernardi ha frequentato cucine di scrittura somiglianti a quelle della sua infanzia a Ozzano dell’Emilia e poco quelle tutte acciai anaffettivi, dai cassetti labirintici ricolmi di lame dove si son svezzati tanti giallisti anglofoni di grido.
Anzi, Antonia Monanni, la protagonista dei racconti, pare molto somigliare alla scrittura del suo inventore: legge i quotidiani in rete, butta quasi tutti i regali che riceve e i libri che non le piacciono, appende alle pareti poche immagini dopo maniacale selezione, abitua “lo sguardo a cogliere solo poche cose per volta”, esercitando così “una sorta di libertà interiore”. Il che sembra porsi anche come una via d’uscita da certe pastoie della scrittura postmoderna, tanto ipertrofica e accumulatoria quanto labirintica, poco gerarchizzata nei suoi temi ed elementi, tra quel che davvero conta o meno nella comunicazione.
Storie dove gli ingredienti del noir e del giallo sono a bella posta disattesi: niente moventi, niente fase investigativa, niente mistero. Eppure quante volte nei gialli si sono ipotizzate carriere impegnative che portano a “scoprire segreti inconfessabili e chissà cos’altro”. “Invece no: assassini banali e pasticcioni, che si facevano scoprire in un paio di giorni. E poi: moventi assurdi, bislacchi, sempre che ammazzare qualcuno perché copula troppo rumorosamente e neanche pulisce bene il pavimento possa essere classificato come movente”. Perché il mistero è tutto lì: nelle persone che hanno disimparato a vivere, negli scontenti, nella follia che ci portiamo addosso senza saperlo, in un labirinto della mente che può essere descritto nei suoi effetti ma mai dall’interno, magari pure con presunti meccanismi d’orologio. Perché il delitto non sta nella perfezione narrativa, ma nascosto nelle pieghe imperfette della vita. Un attimo in cui una “scelta” o uno stato d’animo ci può salvare o perdere con la stessa probabilità. Follie che spesso a pagare sono innocenti “colpevoli per un attimo necessario” (come nel bel racconto, dal titolo eloquente, “Julija voleva il sale”) dove alla fine si capisce “che non c’è niente da capire, come sempre. Solo da preoccuparsi per un male che non fa più distinzioni”.
S’è accennato alla figura-collante dei racconti che è il magistrato inquirente Antonia Monanni (che, si auspica, non diventi il tormentone di una serie che smentirebbe, almeno parzialmente, il suo autore). Un personaggio spigoloso e fragile come il suo nome (quando virato al femminile), insolito e sempre in contro-sintonia con il senso comune del mondo circostante. Una solitudine personale sofferta, pure mai svenduta nella sua irriducibile autonomia e indipendenza. Un personaggio che odia i gialli. “E li odia perché danno l’impressione che siano i poliziotti o i carabinieri a risolvere indagini, risolvere i casi” e i magistrati “invece di coordinare le indagini, le subiscono al punto di rimanere in attesa fuori dalla porta mentre il commissario fa confessare l’assassino”.
Di più. In “Niente da capire” non c’è nessun “commissario di polizia al quale il destino pare non risparmiarne una: la moglie pazza, la figlia adolescente, i sottoposti idioti”. Anzi, pare che Antonia possa essere così perspicace e intelligente proprio nella sua “normalità”, proprio in virtù della sua precisa coscienza di cosa partecipi del fisiologico anziché del patologico. Che è comunque una mai bastante difesa, ché Monanni pare incontrare certe stesse situazioni dei suoi inquisiti, solo vivendole con un’inversa polarità. Non piacerà, ma il magistrato, in quanto appartenente all’umano genere, può sentire di somigliare in qualche modo all’omicida. In “Marta sente i fili” addirittura, rispetto all’assassina, pensa che ha “la sua stessa età, forse hanno letto gli stessi libri, amato lo stesso tipo di ragazzo, pensato gli stessi pensieri, nutrito le stesse speranze per il futuro”. Ma, proprio per ciò, è come se, attraverso l’altrui esperienza dell’errore, riesca ad evitare i tranelli del male, a non toccarlo, a non farsene coinvolgere. Oppure operando scelte ponderate e razionali, mai viscerali, mai moralistiche. Comunque sempre nella cristallina coscienza che, pensare qualcosa e darle immediato seguito, quasi mai sia cosa buona.
Antonia Monanni, sembra dirci Bernardi, è solo il lato al sole di un crinale morale molto sottile e ripido che continuamente ci minaccia, un confine tra luce e buio su cui tutti siamo seduti con uguale pericolo.
Recensione a: Franco Buffoni, Laico alfabeto in salsa gay piccante. L’ordine del creato e le creature disordinate (Transeuropa 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 27 Febbraio 2011.
_____________
L’ordine del creato e le creature disordinate secondo Buffoni
Risalgono più o meno al giugno 2009 le lettere di un gruppo di omosessuali al “Quotidiano della Basilicata” per protestare sul silenzio dei politici lucani sul problema dei diritti della locale comunità LGBT (lesbo-gay-bi-trans): tema non si sa quanto localmente eluso per l’imbarazzo piccolo-borghese che sempre suscita nelle famiglie buone di eletti ed elettori o – peggio, direi – perché stimato, anche a sinistra, “poco remunerativo in termini di voti”. E netta resta l’impressione che la situazione in Italia, oltre che da miserie di tal fatta, sia in realtà complicata e confusa dalla coesistenza di fenomeni di genesi diversa che vanno dall’omofobia interiorizzata (l’omofobia diffusa tra gli stessi omosessuali) alla giornaliera violenza contro i gay e i loro luoghi di riunione, fino ai deleteri danni di una tradizione e di una cultura cattoliche che, già a partire dalle pagine del “Catechismo della Chiesa cattolica”, “presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni” o atti “intrinsecamente disordinati”, “contrari alla legge naturale” in quanto precludenti “all’atto sessuale il dono della vita” (preclusione – c’è bisogno di ricordarlo al lettore? – pure accuratamente praticata dalla quasi totalità degli eterosessuali grazie al supporto di tutta una serie di utilissimi ritrovati tecnologici. Per non dire delle circa 1500 specie di naturalissimi animali con accertati comportamenti di tipo omosessuale: balene, foche e invertebrati inclusi).
Un quadro di arretratezza civile e culturale (anche rispetto ad altri stati cattolici quali la Spagna) che richiede un impegno suppletivo, necessario per chiarire questioni – come ho scritto altrove – che investono con forza i rapporti tra collettività omosessuale ed eterosessuale, ma anche il dibattito interno alle singole comunità di riferimento. Uno sforzo che può essere positivamente sostenuto, tra l’altro, svecchiando la discussione attraverso la lettura di uno dei frutti più lucidi e avanzati di questa riflessione, il “Laico alfabeto in salsa gay piccante” (Transeuropa edizioni, 2010, 245 pp.) di Franco Buffoni. Laico perché pensato per cittadini intesi nel senso più compiuto del termine, cioè “superate le fasi” succubi “della plebe, del popolo, del pubblico e del gregge”. Dunque implicando, da un lato, sui temi affrontati, una piccante polemica lanciata contro l’ordine gerarchico (e conseguentemente sociale) di quel creato che si vorrebbe immutabile per definizione o per divina volontà, ma che le “creature disordinate”, invece e con buona dose di fastidio, non fanno che mettere continuamente in discussione. Dall’altro, un attacco all’uso ormai francamente antistorico di una teoria del diritto naturale – superata già alla fine dell’Ottocento dal diritto positivo prima e dal novecentesco costruttivismo relativistico poi – ancora utilizzata con patetica ostinazione dall’attuale governo per opporsi alle direttive dedicate dell’Unione europea in materia di unioni omoaffettive (e non solo).
E tuttavia il lavoro di Franco Buffoni non convince soltanto per lo sviluppo delle sue tesi sull’omosessualità. Ma anche perché queste ultime si strutturano, sulla base di un alfabeto, come un vocabolario: in questo caso composto di sole cinquantasei fondamentali parole (più cinque ampi inserti saggistici), ma bastanti. Voci che continuamente si richiamano e rimandano nella lettura (affrontando temi di diritto, psicologici, letterari, biologici, filosofici, storici ecc.), sempre componendo un discorso chiaro, coerente, di grande rigore. E dunque utile sia per iniziare a parlare dei temi affrontati, quanto per meglio articolarli in maniera finalmente moderna e avanzata.
Un impegno intellettuale, insomma, che finalmente giunge a un gruppo essenziale di elementi irriducibili – i più irrinunciabili e radicali della questione – nel contempo svelando l’intero senso, anche stilistico – direi –, di un percorso che Buffoni aveva iniziato già con l’autobiografico e letterario “Reperto ’74 e altri racconti” (Zona, 2008) e continuato con la narrazione saggistica del romanzo “Zamel” (Marcos Y Marcos, 2009). Una metamorfosi che in “Laico alfabeto”, decantandosi definitivamente nella forma – mi si passi l’ossimoro – del pacato pamphlet, si oggettivizza definitivamente, rimanendo ancorata a una riflessione che sempre predilige una prospettiva scientifica che è conoscitiva, descrittiva nonché di notevole profondità storica. Un approccio possibile, quello di Buffoni, attraverso la maturata coscienza “che non è alla domanda su che cosa sia l’omosessualità” o perché “si ‘diventi’ omosessuali che bisogna rispondere” – considerato pure che è dal 17 maggio 1973 che l’Associazione americana di psichiatria ha derubricato l’omosessualità come “malattia”, liquidandone di conseguenza una qualsiasi possibile ricerca delle sue cause – ma come si sia oggi omosessuali e come si potrà esserlo domani, soprattutto in Italia.
Una fase che, lasciatasi alle spalle le brutali repressioni omofobiche che la storia ha conosciuto, può oggi avviarsi al definitivo riconoscimento dell’omosessualità come identità. Un’identità che con forza chiede, non senza un’approfondita elaborazione culturale, di acquisire diritti in un compiuto stato di diritto (che, l’Italia, diciamocelo francamente, a volte sembra proprio non essere). Una ridefinizione complessiva e moderna dei termini del dibattito che in Buffoni non manca di intrecciare la riflessione sull’omosessualità a quelle della laicità e della diffusione della cultura scientifica (cioè del metodo scientifico della prova e della verifica; dell’educazione al dubbio), uniche in grado di affrontare positivamente “la questione della finitudine senza ricorrere a metafisiche illusorie di sopravvivenza post mortem, con il loro portato di fanatismo, intolleranza, coazione a credere, persecuzioni ai non credenti”.
Franco Buffoni (Gallarate 1948), vive a Roma. Esordisce come poeta nel 1978 su Paragone presentato da Giovanni Raboni. Ha pubblicato un cospicuo numero di raccolte di poesia tra le quali “Guerra” (Mondadori, 2005), “Noi e loro” (Donzelli, 2008) e “Roma” (Guanda, 2009). Nel 1989 ha fondato e tuttora dirige per Marcos y Marcos il semestrale di teoria e pratica della traduzione letteraria “Testo a fronte”. Per Mondadori ha tradotto “Poeti romantici inglesi” (2005) e curato opere di Byron, Coleridge, Wilde, Kipling. Premio Nazionale per la Traduzione della Presidenza della Repubblica (1993) e Premio per la Cultura della Presidenza del Consiglio (1998), dal 1994 collabora con il Servizio di Promozione del Libro e della Lettura presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È stato rappresentante del governo italiano a Bruxelles in qualità di “esperto designato” sia nel progetto Arianne sia nel progetto Cultura 2000. È autore, tra l’altro, di “Più luce, padre. Dialogo su Dio, la guerra e l’omosessualità” (Sossella, 2006). È giornalista pubblicista, redattore del blog letterario Nazioneindiana.com e professore ordinario di Critica letteraria e Letterature comparate.
Recensione a: Paolo Zardi, Antropometria (Neo., 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Scritture & Pensieri» il 24 Febbraio 2011.
_____________
Antropometria, il vivere contemporaneo di Paolo Zardi
Resta in gran parte nello stile la forza che anima la raccolta di racconti “Antropometria” del patavino Paolo Zardi, trentenne ingegnere con il vizio della scrittura. Uno stile fatto di un ritmo preciso e intenso, sostenuto da dialoghi (seri o ironici) sempre molto convincenti, anche nel tono. Uno stile riconoscibile che è già il tratto di uno scrittore maturo, che si stenta a riconoscere invece per l’esordiente che è.
L’antropometria – lo si dice anche nel libro – è la misurazione essenzialmente quantitativa dell’uomo e delle sue componenti, ma pure, per Zardi, “di esistenze, di relazioni di micro mondi dentro cui ogni suo racconto si muove per coglierne le fratture, i cambiamenti, le trasformazioni inattese”. E in realtà i suoi racconti sono come meccanismi molto ben congegnati all’interno dei quali deflagrano improvvisi (ecco il termine più giusto) i fatti e le svolte della vita. Mai rassicuranti. I protagonisti delle storie possono somigliare, così – e non sempre in senso lato – a quegli strani manichini usati per i “crash test” mentre di loro si misurano gli urti e le ferite sul corpo e nell’anima. Colpi che sono destinati a trasmettersi dritti allo stomaco del lettore, disperanti, come nel racconto d’apertura “Sei minuti” oppure in “Futuro anteriore” o “Ai tempi del nulla”.
Proprio perciò, nella scrittura di Paolo Zardi, si annida un potenziale pericolo. Perché, in realtà, l’antropometria vale ben poco qualora non serva a costruire un’antropologia. Così come i colpi inferti, e certe atmosfere poco rassicuranti, qualora restino fini al meccanismo narrativo, incapaci di uscire da una reiterazione alla quale il lettore stesso in breve potrebbe assuefarsi. Però non parleremmo di Zardi se altre vie d’uscita non fossero già ben praticabili nella sua scrittura. È per questo che della raccolta si preferiscono le pagine, ad esempio, di “La lotta” o “L’urlo”. Racconti che, disposti i dati grezzi di un tema, sono capaci di alzare lo sguardo oltre il compiacimento tecnico verso una lucida visione (che piaccia o no, non è questo il punto) del nostro vivere contemporaneo. In una lezione che possa incidersi nella mente e nella carne del lettore come dopo un incidente d’auto al quale si è miracolosamente scampati.
Gli elettori raramente scelgono i migliori (come diceva Salvemini)
Questa lettera al direttore è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 6 gennaio 2011.
_____________
Caro Paride,
ho letto con interesse l’intervento di Andrea Di Consoli e alcuni successivi, soprattutto quello di Pino Suriano. Insomma, al di là dei singoli casi sollevati, Di Consoli, come l’innocente e (sospetto io) libertario bambino della fiaba di Andersen, grida: “il re è nudo!” o, meglio, “il satrapo è nudo!”. Grida, e fa bene, ché i panni vestiti dai “nuovi” imperatori (nuovi, intendo dire, rispetto alle vecchie gerontocrazie politiche che in Basilicata hanno preceduto) son purtroppo i vecchi e, ora, pure parecchio più sdruciti per servire a una sfilata in stile “vintage” apprezzabile dai contemporanei.
Però, poi, io che sono un tantino più vecchio e forse pure un po’ più pessimista, mi terrorizzo. E mi terrorizzo perché so mica io l’appello ai lucani di Di Consoli a chi potrei indirizzarlo… Sennonché, “Le novità virtuose nascono sempre dal basso”, integra e indica Suriano, ed è verissimo. Ma invece di racquietarmi, mi ritorna alla mente una famosa frase di Salvemini in cui, duro, diceva: “L’esperienza ha dimostrato che gli elettori raramente scelgono i migliori”. Però poi, va beh, mi dico, magari avranno smesso pure “di scegliere normalmente i mediocri” o i peggiori. Che forse coincide un po’ con la tua posizione, Paride.
Tuttavia penso e ripenso, e in tutto questo ripensare qualcosa non mi torna. Perché i giovani di cui parlano i Di Consoli e i Suriano (quelli che votano i migliori tra loro) c’erano anche quando io me ne stavo in Basilicata, e quelli non vanno dunque contati, prima di tutto perché son sempre stati tanti, ma mai abbastanza, e dunque non hanno contato, e poi perché hanno sempre votato contro la vecchia Dc e ora continuano (ché molti politici, Emilio Fede può piantare sulla nostra regione tutte le bandierine rosse di stizza che vuole, ma in gran parte son democristiani di ritorno).
E allora? Allora mi prende alla gola un retropensiero, forse qualcosa di paranoico, ma che alla fine mica riesco a scacciare: e se la restante parte dei lucani, mi interrogo, la stragrande rimasta, votasse quelli che sono come loro? Magari però qualcuno mi dirà: ma mica ora è come prima quando i maggiorenti democristiani avevano a disposizione di volta in volta le chiavi dei forzieri dell’erario, del terremoto ecc., per cui qualche favore (per favore io intendo quelli più odiosi, i più prevaricanti, sia beninteso) fatto al famulo più vicino poteva passare in cavalleria che tanto “tutti”, nel marasma e bailamme dei favori di favori, ci “uscivano qualcosa” pure loro. Qualcuno mi ha anzi replicato: “e qui ora non ce n’è più per nessuno e davanti a queste cose vedrai i lucani come si incazzano!”.
Però, poi, pure che me ne sono andato lontano da un po’, poi lo so. Poi lo so che nel segreto dell’urna il lucano imbufalito, quando prende in mano la matita di stato, mannaggia!, proprio mannaggia, e cavolo!, gli viene in mente che proprio perché è crisi maledetta, proprio perché il figlio a trent’anni ancora gli rompe le scatole e non se ne toglie, proprio perché la figlia (e come si fa con la figlia) ecc., al lucano imbufalito gli viene il dubbio che mica lo sa se di risorse proprio non ce ne sono più. E magari qualche cosa da qualche parte – nel forziere ravanato e derubato – può essere rimasto. E chi lo sa? E non c’è il petrolio, il comprensorio industriale? E non ci sono i parchi nazionali, le tipicità, le eccellenze? E chi lo sa se tutta questa modernità qualche posto non ti dico lo produce, ma almeno lo conserva?
E, dunque, nel legittimo dubbio, come fosse una bambola col tasto dietro, il lucano imbufalito, come si dice in Toscana, si “spenge”.
Epperò, non per questo, non per questa sempiterna “maggioranza speranzosa” (che non giustifico, ma di cui però capisco i dolorosi bisogni che è inutile cercar di risolvere così), una classe politica deve comunque pensare di poter dare il peggio di sé. Se non proprio in quanto a favoritismi (nessuno ha ancora condannato nessuno, è stato ben detto), almeno in quanto a capacità teorico-culturale e politico-amministrativa. Che è la cosa più importante, a ben guardare.
Un caro abbraccio e buon anno.
_____________
La lettera aperta ai lucani di Andrea Di Consoli
Cari lucani,
in seguito alla notizia data dal quotidiano milanese “Il Giornale” – che rivelava che il Presidente della Giunta regionale Vito De Filippo e il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Folino sono indagati per turbativa d’asta presso la Procura di Potenza – io mi sarei aspettato che i diretti interessati ci fornissero immediatamente qualche elemento in più di riflessione, qualche approfondimento ulteriore, anche perché la notizia è di quelle che, ancora una volta, pongono perentoriamente il tema umiliante e problematico – non solo lucano – del connubio nefasto tra politica sanitaria e consenso elettorale (la malattia reale e la malattia del potere si abbracciano proprio lì: negli ospedali).
Invece il Presidente De Filippo, a poche ore dalla pubblicazione dell’articolo, dirama un comunicato stampa in cui definisce la notizia de “Il Giornale” come “trita e ritrita”. Eppure, francamente, questa notizia non si era mai letta sui giornali – né locali, né nazionali – e quindi davvero non si capisce in base a quale criterio la si possa definire impunemente “trita e ritrita”. Può una strategia di comunicazione prevedere la dichiarazione di un falso? Perché sì: dire che la notizia de “Il Giornale” sia trita e ritrita” è una bugia a tutti gli effetti, e i cittadini lucani perbene non pagano le tasse per sentirsi dire delle bugie da parte di chi governa – a spese nostre, su nostra delega – la Regione Basilicata.
Altra cosa, s’intende, è rimarcare senza mezzi termini – come voglio fare anch’io – che si tratta solo di un’indagine, e che un’indagine non significa né rinvio a giudizio, né condanna definitiva. Questo deve essere chiaro, ché si è colpevoli solo alla fine del terzo grado del processo, benché in passato, proprio in Basilicata, alcune persone siano state personalmente demolite con appena qualche anatema di piazza e qualche articolo (chiamiamolo pure così) di giornale. Mai nessun cambiamento politico dovrebbe passare attraverso le azioni della magistratura, anche perché in un Paese sano la magistratura rispetta regole rigide e non assume mai ruoli politici diretti o indiretti, come pure in Italia troppe volte è capitato e, ancora, capita.
E Vincenzo Folino? Continua la politica della loquacità reboante a tavola e della lingua di legno in pubblico, avviata all’indomani del suo insediamento alla Presidenza del Consiglio regionale. Una delusione totale, francamente.
Mi chiedo anche se sia giusto che la più vista televisione lucana (più vista perché, di fatto, l’unica), ovvero il Tgr regionale, il cui caporedattore è Oreste Lo Pomo, dia la smentita di De Filippo e non la notizia che ha originato la sua smentita. Non voglio fare e non farò mai lezioni di giornalismo a nessuno (anche perché non sono mai voluto diventare neanche pubblicista, e quindi non faccio parte, per scelta, di nessun Ordine), ma è normale dare la smentita di una notizia che non si è mai data? Non dico che c’è malafede, in Lo Pomo, che pure conosco come persona seria da molti anni. Dico che c’è quieto vivere, fiacca, stanchezza, spleen impiegatizio, che, a certe ore della vita pubblica, sono più pericolosi della stessa malafede.
Eppure, nonostante questo, qualcosa si sta muovendo, in Basilicata, come un lontano bubbolio di tuono, di tempesta che si avvicina. Un certo clima putiniano e oligarchico viene guardato con sempre maggiore diffidenza, più spesso con rabbia, soprattutto dai giovani, dai tanti non appartenenti agli apparati chiusi del Partito-Regione, colmi di galoppini tristi e impauriti di via Verrastro.
Le ultime cronache sulle nomine dei dirigenti alla Regione, sulle assunzioni all’Arpab (la prima classificata al recente concorso indetto dall’Agenzia lucana per l’Ambiente è la sorella di un nominato dirigente alla Regione, ex portavoce di Vito De Filippo), i casi di Vito Di Lascio (vincitore di concorso regionale nonostante sia assessore provinciale in carica) e di Marcello Pittella (la moglie è stata assunta all’Asl 3), per tacere di altri casi, stanno accendendo lentamente una miccia sulla quale pure, grazie al clientelismo di almeno tre decenni, si è gettata non poca acqua. Ed è proprio questa sensazione di strapotere, a indignare; questa guasconeria strapaesana e un po’ megalomane che porta il Presidente della Regione a dire che una notizia inedita è “trita e ritrita”; questa convinzione – di una decina di persone: i geniali Luongo, gli ineffabili e pirotecnici Viti, e poi i Lacorazza, i troppi Pittella, i taciturni Antezza – nel poter pensare “qui comandiamo noi”.
Lo confesso: non mi aspetto una battaglia di opposizione dal Pdl, il felice perdente. Mi chiedo solo che con che faccia i signori Viceconte, Latronico, Taddei e Pagliuca possano ancora continuare a presentarsi alle elezioni proponendosi quale alternativa all’attuale oligarchia putiniana. Una svolta è necessaria. Sono però felice che recentemente a Roma, in una conversazione informale alla Camera dei Deputati, almeno tre parlamentari meridionali del Pdl mi abbiano detto che presto il Pdl di Basilicata sarà commissariato, e che si stia studiando una strategia per far intervenire nella questione finanche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ci sono momenti in cui per uscire dal pantano occorre una mano esterna, una sorta di sbarco in Normandia di liberatori.
Mi chiedo pure cosa voglia dire il segretario regionale del Pd che in ogni circostanza ripete che “bisogna andare avanti con la modernizzazione della Basilicata”. Come si fa a essere così ineffettuali e astratti a trent’anni? Cioè, come si fa a parlare di modernità in una situazione di fatto oligarchica, ai limiti della satrapia? Ci sono ore in cui la diplomazia diventa stucchevole. Siccome non parlo a nome di nessun popolo, non ho paura di dire che vorrei che i trentenni lucani non gli somigliassero neanche un po’, mai. E mi chiedo, tra le tante cose: è “moderno” un partito in cui ci sono figure levantine come quella di Maria Antezza, che ha fatto eleggere alla Regione il cognato e la sorella Nunzia al Comune di Matera? Si dirà: i voti si contano, non si pesano. Benissimo. Almeno però si eviti di usare belle parole per siffatti contesti familistici. Le parole, si sa, sono importanti, anche se, purtroppo, sono gratuite.
So, o immagino, che il direttore Paride Leporace non condividerà alcune di queste mie riflessioni. Il fatto che le pubblichi è però segno che non tutte le bocche sono tappate. Questo mi dà fiducia che, presto, le cose possano cambiare in meglio. Ma è necessario che gli uomini liberi e forti che amano la Basilicata la liberino per sempre dalla tirannia della politica politicante. Questa terra merita amore e umiltà, non disonore, non paranoia, non arroganza, non familismo partitico, non megalomania velleitaria, non ignoranza, anche se abbiamo un assessore regionale alla cultura di primo piano e di entusiasmante carisma intellettuale.
Piccola postilla. Recentemente il Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo mi ha detto a muso duro che il 60% dei lucani ha votato lui, e che se il centrosinistra ha vinto, ha vinto grazie a lui, perché “io ho un rapporto speciale con i miei elettori”. Sono rimasto a bocca aperta, allibito.
Cari lucani, non voglio aizzare l’antipolitica, che detesto massimamente. Ma, mi chiedo: chi critica questa oligarchia lucana fa solo antipolitica? Basta a salvarsi la coscienza il dire che si fa del basso populismo? Per fugare ogni dubbio demagogico, dirò chiaramente che molti di voi lucani sono complici di questo sistema. Molti di voi non fanno altro che elemosinare aiuti e interventi del politicante di turno, anche quando qualcosa vi spetta di diritto, anche quando il politicante di turno sapete benissimo che non può aiutarvi, e che millanta poteri che non ha, o che utilizza solo per i propri camerieri fidati. E’ un’abitudine umiliante che detesto, e che vi toglie dignità. Purtroppo la brutta situazione attuale non la si ribalta né con gli esclusi rancorosi, né con chi cambia carro non appena si profili all’orizzonte un nuovo vincitore. Diciamo che sto ancora cercando di capire se questa classe dirigente rispecchi davvero il suo popolo. Se è così, il cammino verso la libertà e la democrazia è ancora lungo. Ma non mi scoraggio, né lo farò mai, ché il maledetto amore che provo per la mia terra me lo impedisce.
Andrea Di Consoli
Recensione a: Franco Arminio, Cartoline dai morti (Nottetempo 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 19 Dicembre 2010.
_____________
Tanti saluti dall’aldilà
“Nessuno mi aveva spiegato niente. Ho dovuto fare tutto da solo: rimanere fermo e muto, raffreddarmi, iniziare a decompormi”. Dei 128 aforismi che compongono la raccolta Cartoline dai morti (Nottetempo, 2010) è forse questo che coglie il senso più profondo dell’ultimo lavoro del paesologo Franco Arminio, l’esperienza di chi più volte ha attraversato l’angoscia sintomatologica della morte.
Aforismi, cartoline – si badi bene –, non lettere. Per dirla con Domenico Scarpa: nessun “sospiro patetico” inciso su una lapide a ricordo imperituro di una vita, ché i morti di Arminio “non chiedono niente, non vogliono insegnarci niente”. Nessuna finzione romantica, insomma, nessun romanzo in forma di poesia, nessuna Spoon River possibile. Solo scabri, essenziali corti narrativi.
Franco Arminio ha scritto le sue cartoline oggettivando i suoi attacchi di panico. Panico con il tempo fattosi più scarico rispetto al passato (quando non era chiaro “se stai morendo davvero o sei a un altro capitolo della tua penosa ipocondria”). Attacchi che possono lasciar scrivere “della morte appena trascorsa” sia pure nella paura “che dilata i sensi” e “li fa grezzi” e che, dunque, non lascia il tempo “di raffinare, di romanzare”.
I morti, poi, si sa, “non ti pensano, non ti mandano nessuna cartolina”. Ma quelli di Arminio, come vivi, parlano ancora e pensano e nutrono ansie o i meschini pensieri di ogni giorno (“Adesso ho una curiosità un po’ scema. Vorrei sapere se poi mio cugino Maurizio è riuscito a vendere la sua Golf di seconda mano per la quale voleva sei milioni”). Soprattutto non parlano del perché della morte, evitano il banale e inutile tentativo di carpirne il segreto, filosofico o escatologico che sia. Ci dicono semmai laconicamente come si sono inceppati i loro corpi, in che circostanze consumate quelle vite. Del resto, “come si fa a credere in dio quando uno muore mentre sta parlando di una ringhiera?”.
Arminio, insomma, non ci porta nessuna presunta verità da un aldilà, condita di luci, visioni, ectoplasmi. Non svolge nessuna funzione rivelatrice del dopo. Attraversa, invece, – lui, i suoi personaggi – il malessere, l’angoscia, la malattia, la solitudine della morte, la dimenticanza di chi resta, il dolore nel vivo della carne. E poi, con maestria, stende la sua scrittura, rapprende come gesso il bianco dilagato della pagina, del morto crea un calco capace di tenerne assieme plasticamente forme e tempo. Arminio non guarda alla morte, Arminio guarda la vita dalla morte, da dove meglio se ne può rivelare il senso ridotto al suo osso, una rivelazione spoglia, a volte cruda altre volte ironica: “Sono sempre stato un tipo sfortunato. Il giorno del mio funerale si parlava del funerale della figlia del farmacista, morta il giorno prima”. La morte non cambia niente, indugia ancora – asciutta – su noi vivi.
Arminio adotta una strana forma di tanatosi, quella strategia che a volte gli animali impiegano per scampare ai predatori. Strana perché i suoi esercizi mimetici della morte non sono gesti scaramantici, non sono simulazioni nella speranza la morte passi avanti possibilmente, come nella grande lezione antropologica di Elias Canetti, a ghermire qualcun altro. Arminio adotta la tanatosi della volpe, che invece è quella del predatore che si finge morto per poter meglio avvicinare a cogliere il vivo.
“Cartoline”, dunque. Poche righe. Tutto lì. Però molte. E potenzialmente infinite nella loro casistica, innumeri declinazioni del morire. Tanto che, alla fine, tutte sembrano disporsi come altrettanti paesi che Arminio visita e narra. Allotopie: mondi, modi alternativi di morire. In un libro che potrebbe risultare paradossalmente il suo più paesologico. Un viaggio lungo i bordi di un cratere altro, “intorno a questa cosa che forse regge tutto, intorno a questo niente che sorregge e corrode ogni cosa”.
Ha scritto recentemente il paesologo irpino che “in un certo senso e per la prima volta non siamo nella vita come un’esperienza continua interrotta dalla morte, ma siamo nella morte come un’esperienza continua interrotta dalla vita. Forse non sarà divertente, ma è una situazione clamorosamente interessante.” Si tratta di un’intuizione fondamentale (tra l’altro del tutto in linea con una moderna visione scientifica dell’entropia dei sistemi), che induce all’abbandono di certe visioni arroganti della vita e dell’io e ci induce invece alla comprensione della fragilità della vita, qui intesa in un senso dilatato: come comune spazio abitativo, luogo di espressione della nostra esistenza, di valorizzazione della sua qualità. E ci rivela come Arminio possa scrivere cartoline dai morti e poi farsi paesologo e ancora accendersi di civili passioni contro la necrofilia politica di certi amministratori. Ed è un’altra storia, certo. E però abbisogna dello stesso sguardo.
![]() Scarica il file PDF dell’articolo
Scarica il file PDF dell’articolo
Rettifica pubblicata sul QdB del 21/12/2010:
NELL’INSERTO domenicale “Q, la domenica della Lucania”, in edicola domenica 19 dicembre, l’articolo pubblicato a pagina 17 dal titolo “Tanti saluti dall’aldilà” è stato scritto da Antonio Celano e non da Mimmo Mastrangelo come erronaeamente riportato. Ce ne scusiamo con i lettori e con l’interessato.
Recensione a: Ettore Cinnella, Carmine Crocco. Un brigante nella grande storia (Della Porta, 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 05 Dicembre 2010.
_____________
Nuova luce sull’icona
Diciamo la verità. Sarà per come ce l’hanno insegnata a scuola, sarà per la scarsa capacità degli accademici a saperne scrivere in maniera accattivante (per poi lasciarla vittima dei pasticci metodologici di certi giornalisti), sarà per personale avversione, la lettura della storia spesso ci maldispone. Austeri, pedanti, irti di cifre, date e note, i libri di storia.
Tuttavia, a non leggere le pagine di Ettore Cinnella Carmine Crocco. Un brigante nella grande storia (Della Porta Editori, 2010, 188 pp.), si farebbe gran peccato. Innanzitutto perché si presenta come una ricostruzione storica molto ben narrata, con una scrittura godibile e appassionante, adatta anche a un pubblico più vasto di quello solitamente interessato a questo genere di studi. Poi anche perché l’opera pare un’utile anticipazione a Il grande brigantaggio (1861-1865): una ferita nella storia d’Italia, di prossima uscita per gli stessi tipi e sul cui tema proprio Ettore Cinnella si è diffuso il 19 maggio 2010 per il ciclo La parola alla storia. Centocinquant’anni divita nazionale, organizzato a Palazzo Lanfranchi di Matera, a cura del Liceo Classico “E. Duni”.
Centocinquant’anni che saranno, peraltro, festeggiati a partire dal prossimo anno, ma che rischiano proprio in quanto celebrazioni (basti dare un’occhiata, sia pur fugace, ai siti ufficiali sponsorizzati dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero per i beni e le attività culturali) di lasciare in un canto qualche pagina certo meno rassicurante, ma che parimenti ha inciso nella formazione dell’Italia unita condizionandone tuttora un presente apparentemente cambiato di polarità.
Lettura del libro appassionante, si diceva, ma che nulla cede al rigore dell’impianto metodologico che, invece, legge a sua volta la documentazione disponibile e i fatti con il necessario distacco che il secolo e mezzo trascorso impone agli eventi, soprattutto inquadrandoli in quella “grande storia” che impedisce ogni abbandono a localismi di sorta e a idealizzazioni fuorvianti dei protagonisti. Del resto Ettore Cinnella fa da decenni il mestiere di storico in maniera eminente. Nato a Miglionico nel 1947 è stato allievo della Scuola Superiore Normale di Pisa, insegnando poi storia contemporanea e storia dell’Europa orientale nell’Ateneo pisano. Le sue opere maggiori restano legate ai temi della rivoluzione russa del 1905 e del 1917, nel quadro dellequali Cinnella ha, tra l’altro, rispetto ad altre linee interpretative, meglio individuato e valutato il peso e il senso politico delle rivolte contadine.
La biografia di Crocco è dunque il tentativo di far nuova luce, appena fatta l’unità d’Italia, sulla “prima grande tragedia nazionale” a causa della quale “lo Stato unitario nasceva con una ferita che non si sarebbe rimarginata facilmente”. Una ricostruzione che Cinnella affronta privilegiandole fonti lasciate da chi Crocco conobbe direttamente: dalla biografia del capitano Massa fino agli studi dei lombrosiani (con qualche correttivo) Penta e Ottolenghi, che lo definì “il Napoleone dei briganti”.
Un’impostazione critica che, se permette a Cinnella di confermare complessivamente le radici sociali del fenomeno brigantaggio “alimentato dalla spaventosa miseria dei contadini e dall’abissoche divideva ‘cafoni’ e ‘galantuomini’”, permette pure di svecchiarne l’approccio storiografico rifiutandone, con solidi argomenti, la visione che da Molfese a Hobsbawm, non senza passare per Del Carria, ha fatto del grande brigantaggio “una furiosa guerra di classe ed embrionale rivoluzione contadina”, e del brigante un protagonista “animato da un primitivo ma genuino senso di giustizia sociale” (nel caso di Crocco pure con qualche responsabilità nell’uso delle fonti da parte dello storico Pedìo).
Dunque, fuor di ogni leggenda, anche per lo scaltro pastore di Rionero Carmine Crocco (soprannominato Donatelli), figlio di un contadino e una cardatrice di lana, nessuna particolare angheria subita dai suoi familiari da parte di aristocratici locali. La carriera di rapinatore e grassatore comincia con la brusca fine del suo servizio militare nel 1852, quando si dà alla macchia probabilmente in seguito al regolamento di conti con un commilitone. Una carriera che comincia rocambolescamente con arresti, condanne ed evasioni che dureranno fino alla fatidica data del 1860.
In questo frangente la vita di Crocco pare prendere, per un momento, una svolta finalmente positiva seguendo le pieghe della storia più complessiva della Basilicata. Mentre l’azione militare dei Mille dissolve il fragile regno di Francesco II, a seguito del moto risorgimentale che scuote la regione tra il 16 e dal 18 agosto, per Carmine Crocco si apre una possibilità di perdono in cambio dei servigi resi al governo rivoluzionario e alle truppe garibaldine. È un’illusione di breve durata. Già il tumulto di Matera contro “l’irrisolta questione demaniale” presagisce il levarsi della reazione borbonica a fronte dell’incapacità del locale notabilato liberale moderato, dopo il plebiscito, di aprire all’integrazione e all’assenso delle schiere più diseredate della popolazione. Il resto lo fanno la frettolosità, il pressappochismo e l’ottusità della nuova classe dirigente sabauda che finiscono per ingrossare a dismisura la soldatesca dei briganti. Infatti, una nuova denuncia, vincendo le protezioni fino allora godute, spinge nuovamente alla macchia Crocco (lo seguono De Biase, Stancone e NincoNanco) che in breve si farà forte di un esercito di almeno mille uomini.
Sono vicende, quelle di Crocco, “talmente straordinarie e rocambolesche, che non necessitano di ulteriori fronzoli” mitopoietici. E del resto è proprio qui che la penna di Cinnella, ricostruendo la personalità di Crocco il suo genio e le sue mirabolanti vittorie militari, si fa più appassionante.
Quel che però qui occorre mettere in rilievo è che lo scoppio dell’insurrezione borbonica dell’estate del 1861, oltre a connotarsi come una vera e propria guerra civile fatta di contrapposti agguati ed esecuzioni sommarie, sempre si sostenne su un equivoco di fondo (almeno in Basilicata). Cinnella è chiaro: “Sulla carta la causa borbonica disponeva di prestigiosi e devoti paladini, i quali però preferivano ai rischi della guerra la tranquillità e gli agi della Roma papalina (…) A scendere incampo e a rischiare la vita (…) furono per lo più, alcuni aristocratici e ufficiali stranieri” sovente abbandonati a loro stessi. E non a caso, il fallimento di quel moto insurrezionale, mal organizzato e diretto, e l’esecuzione di Don José Borges (Borjes), fecero cadere la “foglia di fico” con cui la reazione colorava politicamente le gesta brigantesche di cui doveva forzatamente servirsi.
Il brigantaggio espresse, dunque, più autonome forza e ragioni di quanto si sia diposti a credere. E del resto mai Crocco, causa anche il suo carattere volitivo e ambizioso, si sarebbe fatto burattino di una causa di cui molto bene conosceva gli attori locali: quei galantuomini che dopo averla sobillata erano “usciti pressocché indenni dalla tempesta politica da loro scatenata, mentre erano stati i briganti e i popolani a pagare il fio della tentata restaurazione borbonica”. D’altro canto certo sempre convenne allo scaltro capobanda di ammantarsi della causa borbonica per ottenere favori, armi e onori, mentre le continue vessazioni manu militari operate dai nuovi burocrati savoiardi sul territorio ne accrescevano il favore popolare e il radicamento.
Caduto l’equivoco sulla guerriglia partigiana e lungi dal rivelare, successivamente, la sua natura di moto sociale, il brigantaggio resta a questo punto per quel che fu sempre nella mente dei suoi protagonisti: “una splendida occasione di bottino e di fama” cui posero lentamente fine le stesse truculenze di cui i manipoli briganteschi si andarono macchiando, la mancanza di strategie politiche meno che abbozzate, nonché una più attenta gestione politico-militare del governo sabaudo a seguito del varo della draconiana e più volte prorogata legge Pica (agosto 1863).
Questa lunga seconda fase del brigantaggio, apertasi tra la fine del ’61 e il ’65, travolge finalmente anche Crocco, a differenza di molti suoi compagni d’avventura sfuggito alla morte e arrestato definitivamente nel 1870. Processato e condannato a morte, pena commutata nei lavori forzati a vita, Crocco si spegne negli stessi panni del suo esordio: dopo aver conosciuto la fama di più importante brigante della storia d’Italia, la ricchezza del bottino, la vittoria militare, di lui restano all’atto della morte nel bagno penale di Portoferraio: “Calze di cotone paia 6; maglie di cotone 1; Maglie di lana 1; Berretto da notte 2” e la comunicazione agli eredi che il deceduto “non ha lasciato peculio”. È il 18 giugno 1905.
Recensione a: Andrea Nicolussi Golo, Guardiano di stelle e di vacche (Biblioteca dell’Immagine, 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 14 Novembre 2010.
_____________
Siamo fuori dal vicolo cieco
È un difficile tratturo nel bosco quello impegnato dallo scrittore Andrea Nicolussi Golo, che incrociando vissuto personale e memoria storica, intreccia i sentieri dei dintorni montani e contadini della comunità dei cimbri di Luserna, oggi sul pericoloso ciglio, come del resto la maggior parte delle minoranze etnico-linguistiche italiane, di una definitiva estinzione.
I Cimbri, attualmente stanziati per la maggior parte in alcuni centri nell’area montuosa tra le province di Trento, Vicenza e Verona, parlano un idioma di ceppo germanico. Provenienti da un’area compresa tra Baviera e Tirolo, si stabilirono in Italia a partire dalla seconda metà del X Secolo arricchendosi in seguito di altre ondate migratorie. Dopo un periodo di fioritura tra ’500 e ’700, subirono una significativa perdita di autonomia durante il periodo napoleonico, una pressoché irrimediabile crisi con la Grande Guerra e, successivamente, furono fortemente gravati da alcune scelte del regime fascista.
Introdotto dalle ultime riflessioni di Mario Rigoni Stern, prima che il grande scrittore morisse, “Guardiano di stelle e di vacche” (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2010) è una raccolta di racconti che tenta di ridare voce, con una capacità narrativa e affabulatoria davvero sorprendente, all’antica cultura degli “tzimbar”, i boscaioli, oggi ridotta a poche centinaia di abitanti sul versante trentino dell’altipiano di Asiago. Però con la convinzione che non basti, per salvare un mondo, limitarsi alla raccolta di vecchie storie tradizionali e leggende, bensì evocarne l’antica voce per rielaborarla in storie nuove e personali, godibili al lettore di oggi. Perché una comunità può avere un passato e una sua storia viva solo se è ancora capace di produrre presente, pena l’autoconsegna all’archeologia. Solo così, forse, “i cimbri vivranno, per gioia, per rabbia, per amore, per orgoglio, per dispetto e un giorno riapriranno la loro piccola scuola”.
Tuttavia l’autore non si sottrae ai perché di un declino. E spetta al racconto “Storia di Katerj” – tra i più belli e convincenti dell’intera raccolta – aprirci alle inquietudini di quel “Secolo Breve” dove luci e ombre, bene e male, identità e diversità sembrano smarrirsi scambiandosi continuamente di posto e di polarità. A partire dalle stagioni, da un insolito inverno caldo di inizio secolo e dalle tardive nevicate primaverili. A seguire con l’incendio del 1911 che distrugge “anche il ricordo delle antiche case, le lunghe case con un solo piano e con i tetti di paglia o di scandole di larice”. Fino a precipitare nel gorgo della Grande Guerra.
Ultimo avamposto austriaco verso l’Italia, i lusernesi sono i primi a fare la prova del fuoco italiano, che ne provoca l’evacquazione in Boemia (e come profughi nella “Città di legno” saranno malvisti e malsopportati da tutti: “se ne incontrate uno, sputategli in faccia!” ebbe a dire un Mussolini ancora giornalista dell’”Avanti!”). Al ritorno si ritroveranno cittadini italiani. È in questo spazio – mentre la Rivoluzione industriale morde a morte le carni del mondo contadino, fa strame dei suoi custodi, ne acceca i profeti – che si muove Katerj, profondamente figlia di questa nuova alba fino a farsene metafora genetica, fino a introiettarne i confini smarriti e confusi della comunità in una marcata androginìa, con il suo guardare bifronte alle vecchie fedeltà imperiali austro-ungariche e il suo realizzare in anticipo la libertà della donna, sia pure sotto mentite spoglie di levatrice e di uomo di fatica.
Non c’è mai, in “Guardiano di stelle e di vacche”, alcuna idealizzazione delle minoranze etnico-linguistiche. Una comunità, lo si è già detto tra le righe, è solo un confine più particolare che si apre e si chiude nel tempo come tante altre realtà. Accoglie gli ebrei profughi dalle repressioni della Serenissima nel 1516 (“Il viaggio di Shimon”), si chiude nelle superstizioni scambiando per streghe altri estranei ai propri costumi (“La storia di Franza”), si scontra con altre minoranze accese della loro autonomia (“Begia e Mino”), subisce le repressioni dei regimi in cui si ritrovano a essere minoranza. È il caso delle “opzioni” imposte dal regime fascista sul finire degli anni Trenta: scegliere, cioè, se restare cittadini italiani, rinunciando alla lingua e alle proprie tradizioni, oppure prediligere la cittadinanza tedesca e abbandonare la propria terra per un Reich che certo non è più quello mitico di Francesco Giuseppe e di Carlo I, ma quello prosaico e liberticida dello “sciocco imbianchino di Branau” (e del resto, in seguito, rapporti distesi non vi furono né con i nazisti in ritirata né con i partigiani).
Il senso delle storie di Nicolussi Golo è tutto qui, in questo passaggio novecentesco dall’esser qualcosa (o ancora qualcosa) in un mondo arcaico e premoderno a non esser più nulla di preciso. Perché, insomma, nonostante il sorriso ritrovato nelle storie di tutti i giorni (“L’ultimo cacciatore”, “Errare è umano?”, “Undicesimo comandamento”) la vera e propria sconfitta dei cimbri giungerà per davvero non con le guerre, ma con la chiusura del “Secolo Breve”, con l’arrivo della modernità, della “furia modernista degli anni Settanta”, con la consapevolezza di aver “gettato il bambino con l’acqua sporca”, ma ancor peggio, di aver forse “buttato il bambino e tenuto l’acqua sporca. Come abbiamo fatto con i nostri mobili massicci di abete o addirittura di larice sostituiti con quelli di formica” (e “ora non esistono più né gli uni né gli altri”).
Ma pure qui, per Nicolussi Golo, la nostalgia per la “sconfitta” definitiva non coincide mai con nessuna foga nostalgica o antimodernista. In una recente intervista, l’autore di “Guardiano di stelle e di vacche” ha condivisibilmente dichiarato: “Non viviamo fuori dal mondo, quindi anche noi siamo stati raggiunti dai prodotti della globalizzazione, dalle ‘cineserie’. Forse quello che ci distingue è l’aver capito prima di altri che questa strada è un vicolo cieco. Siamo abituati da almeno quarant’anni ad essere sotto la lente di ingrandimento: proprio per questo ci siamo accorti prima di altri che non ci sono più identità particolari, o meglio, che tutte le identità particolari stanno morendo… Ora essere cimbri significa avere una maggiore consapevolezza della propria identità particolare, un’identità un po’ diversa dalla massa. Che sia un bene o un male, questo non si può dire a priori, ma di sicuro la consapevolezza di questa differenza ci forma come gruppo”.
Andrea Nicolussi Golo è nato a Trento nel 1963 e vive a Luserna. Lavora in fabbrica e compone filò dal sapore antico. Questo è il suo primo libro.
Recensione a: Gian Carlo Ferretti, Vanni Scheiwiller: uomo, intellettuale, editore (Libri Scheiwiller, 2009)
Questa recensione è stata pubblicata su «L’immaginazione», n. 257 (settembre-ottobre 2010).
_____________
Concludendo l’introduzione al suo Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003 (Einaudi, 2004) Gian Carlo Ferretti, dopo aver interpretato l’importante cambio di fase nelle vicende editoriali del Paese a partire dagli anni ’70, puntualizzava: «la discriminante dell’identità editorial-letteraria […] sembra più efficace e producente della discriminante di un’editoria di cultura o di progetto contrapposta più o meno esplicitamente a un’editoria di mercato: discriminante quest’ultima adottata da tempo in molti studi e viziata da sottintesi elitari. […] la discriminante […] non è tra cultura e mercato, bensì nel diverso modo in cui questi due momenti interagiscono nelle loro rispettive politiche editoriali, e perciò nelle differenze tra le loro rispettive identità».
È una solida visione interpretativa che molto bene si adatta alle vicende della piccola casa editrice All’insegna del Pesce d’Oro. Nata nel 1936, dopo lunga gestazione, dall’attività dello svizzero Giovanni Scheiwiller, è rilevata, nel 1951, dal figlio diciassettenne Vanni, fin lì aspirante sportivo, quando «il tennis perse un mediocre giocatore e l’editoria italiana si guadagnò il suo editore “inutile” di libri e microlibri […] dove la dichiarazione autoironica di inutilità può indicare anche un’ editoria senza utili». Di qui, tra l’altro, una mitopoiesi della figura di Vanni Scheiwiller per certi versi unica nel panorama editoriale dell’epoca che, tuttavia, Ferretti costantemente confronta con la rigorosa ricostruzione delle vicende storiche della casa editrice e della sua singolare personalità.
Basandosi sulle carte dell’Archivio Scheiwiller conservato presso il centro Apice (un repertorio dei quali è offerto al lettore come semplice ricognizione di un fondo molto esteso e per precisare «la figura storica di intellettuale cattolico e liberale» di Vanni) e l’attento studio dei cataloghi (nelle tre parti ideali scelte: 1925-68, 1952-73 e 1952-83) Ferretti ripercorre le vicende di un imprenditore dedito alla costruzione di una sua «paradossale identità» editoriale di proposito rifuggendo, nella strutturazione del catalogo, ogni proposito di «equilibrio e coerenza». Un’identità poliedrica e contraddittoria nel segno della libertà, del gusto e della sperimentazione, propria di un uomo geniale e coraggioso, provocatorio e anticonformista, poco legato alle ideologie e ai partiti. Un editore-autore, ma anche critico-informatore costruttore di uno scaffale «che si rivolge consapevolmente alla parte più elitaria e ristretta della già elitaria e ristretta area di lettura libraria in Italia», nel tentativo di trasformare una marginalità in valore polemico contro una cultura ormai massificata, sia pur all’interno di una chiara scelta antiaccademicistica. E dunque i poeti dialettali, i «maestri in ombra» Sbarbaro e Rebora, la polemica edizione di Céline, la particolare amicizia che lo legò, non senza qualche contrasto, a Ezra Pound.
Ma già qui, di pari passo, alcune scelte ben precise e rivelatorie: la voce data ai narratori dimenticati (La Cava, Savinio, Pizzuto ecc.); le edizioni dedicate agli scrittori più affermati attraverso la scelta di privilegiarne testi minori che possano consentire l’aggiramento dei vincoli contrattuali imposti dalle case editrici maggiori; le polemiche sui premi letterari che rivelano la costante tensione promozionale dell’attività editoriale di Vanni.
Insomma, se gli archivi confermano largamente la figura leggendaria di un editore che «stipula contratti sulla parola […] gira con una borsa pesantissima piena di carte, e porta personalmente i libri nelle librerie di città in città e sempre in treno scrivendo lettere, leggendo testi, correggendo bozze, abbozzando idee grafiche e tipografiche con un frenetico ritmo operativo», vendendo quadri di proprietà nel tentativo di aggiustare i conti di una casa editrice artigianale, Ferretti è sempre attento a evitare l’idea, piuttosto impropria e francamente risibile, di un editore improvvisato, sprovveduto o, peggio, «titano», «matto», «San Francesco», spiritualmente liberato dalla materia e persino «santo bambino» dell’editoria a seconda della vulgata del momento.
In realtà Vanni Scheiwiller fu uomo pragmatico, innanzitutto convinto del libro come prodotto dal valore economico, oltre che culturale, tanto da spingersi a ricorrere, per molte delle sue pubblicazioni e per la quadratura dei suoi conti, a destinatari-acquirenti, ad autofinanziamenti dell’autore, a committenze, a sponsorizzazioni – certo non sempre portate a termine con successo, ma non è questo il punto – senza disdegnare consulenze editoriali anche scomode (vedi quella elargita al reazionario Edilio Rusconi) o risolvendosi, fu vero anche per il grande Giulio Einaudi, per l’insolvenza programmata verso i propri autori. Così come, per contro, i suoi cataloghi dimostrano, qualora ve ne fosse ancora bisogno, precisi sforzi nel tentativo di organizzare e armonizzare produzione, distribuzione, promozione e vendita.
Pure così, va detto, proprio non si riesce a restar distaccati dalle pagine che Ferretti spende, con la sua consueta capacità ricostruttiva, sul saldo costantemente negativo tra ambizioni editoriali e capacità economiche di Vanni, che spingeranno quest’ultimo a stilare un «catalogo dei desideri» che ancor oggi fa malinconia. Ma, proprio per questo, ben più si comprendono gli sforzi di imprimere, a partire dal 1977, una più decisa svolta industriale con il lancio dei Libri Scheiwiller da affiancare e sinergizzare con le vecchie edizioni. L’impresa non manca di palesare, in maniera certo più definita che in passato, un organigramma aziendale, una precisa programmazione delle uscite e del calcolo del fatturato, un più deciso impegno organizzativo nella distribuzione, così come un più aperto ricorso al mecenatismo bancario, alle edizioni realizzate per le aziende e per le istituzioni. Ciò a dimostrare come anche il mito e il fascino incontestabili di una figura come quella di Vanni Scheiwiller abbiano bisogno di vivere mai scollegati dalla generale evoluzione che, proprio a partire dagli anni ’70, andò imprimendo un rinnovato clima produttivo all’editoria italiana.
![]() Scarica il file PDF dell’articolo:
Scarica il file PDF dell’articolo:
Intervista a Maurizio De Giovanni
Questo articolo è stato pubblicato su «Scritture & Pensieri» il 17 Ottobre 2010.
_____________
Napoli nella pelle
Noir mediterraneo – Maurizio De Giovanni racconta il “suo” commissario Ricciardi
Classe 1958, napoletano, Maurizio De Giovanni è arrivato tardi alla scrittura e presto al successo di pubblico e di critica. Con un personaggio dolente quanto ispirato, il commissario Ricciardi, che, nel volume Il giorno dei morti (ed. Fandango), affronta l’ultimo episodio di una saga dedicata alle quattro stagioni. Quest’ultima indagine (ma altre seguiranno) si svolge in una Napoli che il 26 ottobre dell’anno IX dell’Era Fascista troviamo aggredita da una pioggia inesauribile che le “le toglie il sorriso”. Acqua che fa paura, che non lava, che deruba un bambino della sua spensieratezza e del suo futuro.
Nel suo ultimo romanzo Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi (Fandango), la città sembra avere una presenza diversa rispetto ai suoi lavori precedenti.
Sì, è vero. Del resto la città non è una semplice contestualizzazione degli eventi, ma uno sfondo dinamico. E ho sempre ribadito come Napoli sia una città estremamente stratificata. Una realtà che si nota, ad esempio, anche attraverso i mille cliché anche contrastanti, paradossalmente tutti veri, ma pure tutti coesistenti, tutti accumulatisi in secoli di vita cittadina. Non è un caso che Napoli sia un luogo che lungo la sua storia conti nessun assedio, perché qui tutti i conquistatori, tutti gli eserciti invasori sono sempre stati accolti a braccia aperte, senza opposizione.
E come convive con questa città il commissario Ricciardi?
«Il commissario Ricciardi è un uomo che vive una condizione di solitudine, in qualche maniera scollato dalla città, ma in realtà vivendola e vedendola molto più profondamente del resto dei suoi abitanti. Ricciardi ha un dono-condanna, la singolare capacità di cogliere l’ ultimo pensiero dei morti, che non è altro che la percezione di una sincronicità. E infatti è l’unico che vive e attraversa una mancanza di cesura tra passato e presente, di un superamento storico dei fatti».
Napoli. De Silva non la nomina mai, ma poi la città è come se premesse dentro ogni sua singola frase. Lei la sposta in un’altra epoca ma, nel rapporto con il suo protagonista, si rivela poi di un’attualità estrema. Di Napoli si può parlare solo così?
«Napoli si può affrontare con rabbia, con amore o con passione, ma la verità è che resta sempre un argomento che non si può esaurire. Purtroppo è poi anche una città sommatoria di individui, incapace di esprimersi all’ unisono, di dire “noi siamo cittadini”. E questo pur avendo la cultura e tutte le carte in regola per potersi realizzare in un destino comune e positivo».
Ritrova elementi comuni a Napoli nelle altre città del Mediterraneo?
«Gli elementi comuni sono tantissimi, io stesso ne ritrovo una quantità con Genova, ad esempio. Ma oltre che di Mediterraneo si dovrebbe parlare di partecipazione a una comunità orizzontale con tutto il meridione del mondo. Basti pensare ai legami con l’America Latina, ad esempio».
Torniamo al romanzo. L’indagine questa volta gira attorno a una vittima che è un bambino. Il Noir partenopeo ha una particolare sensibilità verso questa realtà?
«Il piccolo Matteo, ”Tettè” , è un bambino povero, denutrito, lacero. Prima e dopo la guerra Napoli è diventata famosa per la presenza massiccia dei bambini tra i suoi vicoli e nei quartieri. Era ed è un’infanzia coinvolta nel crimine. I bambini sono usati come spacciatori, corrieri della droga. Un problema pressante e persistente. Nel mio ultimo romanzo è una tensione che il protagonista vive particolarmente».
Di Ricciardi ha detto che «è un uomo che non riesce a non guardare il male». In realtà nel Noir è sempre presente una profonda tensione a conoscere il male. Secondo lei come se ne può scriverne senza giudicarlo moralisticamente o senza rimanerne compromessi?
«Oggi il vero erede del romanzo sociale è il Noir. E non puoi riuscire a vedere il male attraverso il bene ma, al contrario, puoi recuperare una visione del bene attraverso il male. Per il resto per parlare del male io non adotto una scrittura asettica, ma mi sento coinvolto e partecipe nella sua descrizione. Tuttavia ho rispetto per la vittima di un delitto, non mi attardo in descrizioni splatter e non indulgo in atteggiamenti giallistici perché non sopporto l’omicidio come occasione di racconto. Faccio invece esercizio di pietà, di pudore, di rispetto e comprensione del dolore.
Recensione a: Alessandro Petruccelli, Un giovane di campagna (Gremese, 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 3 Ottobre 2010.
_____________
La campagna racconta
Da Petruccelli a Bufalari: immagini agresti e realtà quotidiana
Mio padre comprò la prima edizione di Un giovane di campagna di Alessandro Petruccelli nel 1976, nella libreria della stazione di una Firenze ancora editorialmente vivace, benché già in rapido declino. Il volume era uscito – dopo essere stato insignito nell’ottobre 1973, ancora inedito, del premio Rapallo – nella collana letteraria “I David”, diretta da Gian Carlo Ferretti per i tipi dei capitolini Editori Riuniti. Come Pietro, il giovane contadino protagonista della storia, anche mio padre s’era da poco “affrancato” dalla terra grazie agli studi universitari. E tuttavia, pur avendolo letto con necessario ritardo, il libro ha sempre avuto una ragione anche per me che invece ho vissuto la mia preadolescenza in una campagna che mi appariva ancora viva e che invece era già morta da tempo.
L’opera di Petruccelli, dopo aver conosciuta una seconda edizione nel 1979, è poi stata ripubblicata in edizioni scolastiche e tradotta all’estero fino a essere riscoperta e ripubblicata dalla piccola Gremese, sempre di Roma. Piccola ma coraggiosa, direi, perché, nonostante la vittoria di un Pennacchi allo Strega, quasi del tutto indisposta appare la grande editoria a stampare, peggio a ristampare (con opera di ricerca), romanzi legati alle nostre radici contadine. Dunque, se il libro è pure stato recentemente insignito a Potenza del primo premio alla XXVI edizione del Concorso nazionale di poesie e narrativa “Lucania”, presieduto da Antonio Santarsiero, l’occasione non può che rallegrare e, in qualche modesta misura, forse, risarcire.
Ambientato nelle campagne del basso Lazio (Petruccelli è originario di S.S. Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Oggi vive a Formia), Un giovane di campagna ha finito, nella mia esperienza di lettura, per confrontarsi con un altro grande romanzo meridionalista, però pubblicato nel ’60: La masseria del fiorentino Bufalari, dedicato alla Lucania della riforma agraria. Perché, se in quest’ultimo i contadini, ignari e indifferenti a ciò che avviene, sono ripresi nel momento dell’improvviso e violento abbattersi di una modernizzazione che sembra seguire fini per loro incomprensibili, in Petruccelli siamo già un passo più in là. Vale a dire alla certificazione dell’avvenuta fine del mondo contadino e rurale. Un’apocalisse senza più schianti e strida, qui narrata ormai per fotogrammi, frammenti disposti a ricostruire l’incerta memoria di una forma ormai infranta, irrecuperabile nella sua unità e unicità.
Certo in apparenza tutto resta uguale: Pietro vorrebbe mostrare a Paola, la sua fidanzata di città, la “casa ai piedi del colle, il gelso che conosce i nostri segreti, il fico che ho piantato quando avevo sei anni” e il lavoro dei campi procede come sempre ognigiorno, le vacche al pascolo, la mietitura, la cura delle piante… In realtà la campagna è un ventre ormai vuoto di uomini, senza più voci – le strade, la luce e l’acqua una modernità (quella immediatamente utile) ancora attesa. E i contadini sembrano ancora tanti ma, frammescolati ai pochi rimasti, fanno numero i morti e gli emigrati: i fantasmi che la memoria di Pietro ci rende vivi attraversando e censendo terreni ormai incolti e pagliai in rovina. Gli emigranti hanno abbandonato le case intatte, come per l’imminente arrivo di un esercito nemico, oppure prima di partire si dedicano essi stessi alle distruzioni preda di una muta sofferenza. Le loro mete l’Australia, la Germania, la Scozia, la Svizzera, il Canada… Qualcosa di irreversibile è avvenuto: “Proprio ieri il compare Filippo ha sradicato decine di piante di fico e le ha messe a seccare con le radici all’aria. È forse questo il tempo in cui i contadini stanno rompendo per sempre quel dialogo che avevano iniziato, chissà da quando, con le cose della terra”.
Oggi, navigando in Internet, non mi meraviglia scoprire che dal 2007, per la prima volta nella storia, più della metà della popolazione mondiale vive in città, in immense periferie o bidonville. Non mi turba rileggere la cronaca di due o tre anni fa, quando una coppia di campeggiatori olandesi subirono un tentativo di stupro a Ponte Galeria, in una desertissima campagna romana, a opera di due pastori nemmeno più italiani.
Procedendo nella lettura, anche il protagonista del romanzo di Petruccelli, Pietro, può essere utilmente paragonato al professore del romanzo di Bufalari. Mentre quest’ultimo viene da Firenze ed è rappresentante di una civiltà più moderna cui costantemente paragonare la realtà osservata, Pietro è figlio della classe contadina di cui narra ma dalla quale, allo stesso tempo – avendo avuto la possibilità di accedere agli “alti studi” – comincia a distaccarsi (“Sento di vivere due generazioni e non so con chi andare”) per diventare in seguito insegnante. Metà dentro e metà fuori della propria condizione, vive una personale mutazione, una sorta di emigrazione da fermo: narra e partecipa alla dolorosa fine della sua comunità di origine, ma può forse narrarla proprio perché ormai individualmente figlio salvato, o prodotto (perché poi possa raccontare), da questa particolare Fine dei Tempi. Può conservare un suo proprio ottimismo nel futuro portando con sé, nella memoria, il ricordo di ciò che è stato proprio perché l’apocalisse glielo ha consentito come partorendolo da sé.
Insomma, la “certezza della perdita quasi supera la sua gravità e induce in una sorta di serenità e perfino di buon umore che non è incoscienza ma forse ancora un bagliore della secolare saggezza contadina”, scrive Giuliano Manacorda nella sua lucida introduzione alla prima edizione del volume. E il romanzo termina proprio con la laurea del giovane di campagna e con la sua successiva partenza per il militare, come a segnare il definitivo distacco per un mondo altro, non noto e irriducibilmente diverso. Una visione progressiva, anch’essa probabilmente giunta oggi al suo binario morto (e non saprei dire con quante ulteriori possibilità palingenetiche).
Manacorda detta qualcosa anche sullo stile di questo romanzo appartenente al filone del realismo ma, come pure sottolineato da Pampaloni per un’altra opera di Petruccelli (“Una cartella piena di fogli”, Interlinea 2001, anche questa su precedente edizione Editori Riuniti 1991), senza le “esibite professioni ideologiche” e gli “stridori espressionistici” tipici del neorealismo.
Nell’opera di Petruccelli, prosegue Manacorda, non si rintraccia “un rigo di arcadia” perché “nata non dalla partenogenesi letteraria ma da un’esperienza reale”. Petruccelli parla da un “fondo autobiografico senza slittare né sui facili piani inclinati della tenerezza e del vagheggiamento del proprio io adolescente, né sugli specchi di una fredda e tutta sapiente letterarietà. Il suo piccolo miracolo lo aveva compiuto proprio in questo equilibrio costantemente mantenuto fra la commozione dei fatti e la dignità della pagina scritta, tra il molto da dire e il dirlo con poco”.
Uno stile conciso, spesso composto di frasi strutturate su un soggetto, un predicato e un complemento, pure mai elementari negli esiti, o tendenzialmente naïf (semmai tra le pagine si avverte un incedere che ricorda la semplicità di certi passi evangelici, pur intrisa di una panica sensibilità pagana). Uno stile letterario tipico di quegli anni e pure di un modo contadino, che non impedisce alle emozioni di trapelare in superficie.
Un’essenzialità che per certi versi trovo condivisa dai grandi scrittori sopravvissuti all’esperienza di guerra o dei campi di concentramento e di prigionia, che è dire un’esperienza nell’asciugarsi preciso delle parole. Come alla fine di un mondo.
___________________
«Nessuno coltiva quel pascolo»
Brani tratti da Un giovane di campagna
Un boschetto di canne
Ora questo piccolo campo nessuno lo coltiva più e io vi pascolo le mucche, ma da esso si alzano ancora le preghiere e le bestemmie per la pioggia che non veniva o per quella che veniva inopportuna; da esso s’alza ancora il mugolio sordo d’una giovane muta che lavorava come un’asina; da esso si alza ancora la voce d’una madre che, trascinandosi ammalata tra i solchi, ripeteva: – Chissà fino a quanto ce la farò.
E una mattina si accasciò sulle zolle e vi rimase. Noi accorremmo solo quando capimmo che il pianto del figlioletto che le stava accanto non era il pianto di vincigliate o schiaffi. Poi quel fanciullo, per ricordarsi del punto dove era morta la madre, vi piantò una canna. Quella canna mise radici e generò altre canne. Si formò un boschetto che ora diventa sempre più grande e in estate e in inverno bisbiglia al vento.
Vivardo e le gazze
Mentre cammino tra le stoppie, eccito le locuste che scappano saltellando; hanno paura come quando, rincorrendole di qua e di là, le acchiappavo e ne facevo lunghe “inserte” per darle alla cola. Com’era contento Vivardo quando le trovava! Prima sceglieva con lo sguardo quelle più grosse e poi con un salto le sorprendeva. Di gazze avvezzate ne aveva due e le portava sempre con sé e quando si sedeva in mezzo ai campi esse gli si posavano intorno e lui sembrava san Francesco. Una domenica se le portò anche in paese e una gli stava a destra e l’altra a sinistra sulle spalle e la gente si fermava a guardare e diceva: – Sembra uno del circo equestre.
Vivardo se ne andò che gli uccelli facevano il nido, ma le sue gazze, quando passavi presso la sua casa, le trovavi immalinconite sulla siepe dell’orto.
Vasi dalla finestra
Ieri sono andato con mia madre al pezzo di terra che abbiamo presso l’Ausente. Al ritorno una ragazza gettava vasi di fiori dalla finestra:
– Perché li butti? – le ha chiesto mia madre.
– Domani partiamo per il Canada.
Chissà come sarà triste restare ad assistere all’ultimo che parte.
All’ombra degli olmi
… Le ragazze ora non hanno neppure voglia di parlare. Causa non solo la stanchezza, ma il pensiero in cui cade ognuna. Le loro compagne, in quest’ora, sono al mare, sulla spiaggia contente o al fresco degli ombrelloni o siedono in compagnia nelle scuole di taglio e non sono rozzi i loro visi né incallite le loro mani; o studiano e imparano tante cose e sono rispettate.
Ognuna, in cuor suo, maledice la terra. Né entusiasma nessuna quella mietitrice meccanica che s’avanza, tirata da un trattore, nella proprietà di Don Marco e che, manovrata da un solo uomo, in un momento ha mietuto già un tomolo di terra. Al vederla, penso che, quando diremo ai nostri figli che noi abbiamo mietuto il grano con la falce, essi ci ascolteranno come se raccontassimo una favola antica.
Il sole è sulla casa di Mario il “guardiacaccia”.
– È già mezzogiorno, – esclama mia madre e va a preparare il pranzo.
Anche gli altri mietitori s’avviano, ognuno alla sua casa. Non si mangia più all’ombra degli olmi, presso le fresche riviere dei fossi, raccolti tutti insieme intorno a pasti preparati come per una festa, dove chi suonava il corno chi la fisarmonica.
Una casa vuota
… Resto a terra col corpo che grava sul cortile… È questo cortile senza bimbi e senza galline. La porta della casa è socchiusa. Entro. Trovo frantumi d’intonaco sul pavimento a mattoni, il camino affumicato ha sul focolare un treppiedi con le zampe in aria e inchiodata al muro una tavoletta su cui è posata una candela a petrolio; in uno stipetto sta una bottiglia riempita a metà di aceto, forse vino un tempo. Una sedia sciancata s’appoggia alla parete; dietro la porta c’è una vanga arrugginita che non sarà lucidata, a marzo; vicino giace un martello che servì a inchiodare scarpe rotte, uno zappone senza manico, un vomero consumato; solo solo, in mezzo alla parete, sporge un chiodo cui il capofamiglia appendeva il cappello; dalle travi del soffitto pendono alcuni anelli di ferro destinati a sostenere salsicce negli anni di prosperità; c’è anche un fascio di rami secchi e penso che, se restassi qui, quest’inverno mi riscalderebbero; le lucertole si rincorrono da un angolo all’altro; sotto il boccaglio del forno giace uno sgabello vecchio attaccato dal tarlo; anche un’immagine di San Giuseppe falegname hanno lasciato! Esco fuori con un desiderio di aria e di sole. Non so che vi sia nella stanza di sopra, ma le rondini e i passeri vi entrano e ne escono per la finestra spalancata. Il terreno intorno è disposto a chiazze: divise da macere, ove nereggia qualche olivo; le viti, non potate, distendono i tralci fra le pietre o si arrampicano bizzarre sui mandorli e sui fichi: di questi ultimi i frutti appassiscono sui rami non raccolti, fornendo cibo ai cani e alle formiche… Qui abitavano Adamo e Gilda. Erano fidanzati quando si costruirono questa casa. Io andavo alle elementari, quando Adamo piantava viti e aranci. Gilda vangava e cantava la ninna nanna alla sua creatura, la prima, che teneva accanto adagiata sulla terra smossa. Poi se ne sono andati in Australia. Ora dicono che quella bambina è diventata una bella ragazza e non sa che cosa sia seminare né vangare.
Recensione a: Antonio Paolacci, Salto d’ottava (Perdisa Pop, 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 29 Agosto 2010.
_____________
La vita in graffiti di MET l’invisibile
Salto d’ottava (Perdisa Pop, 2010), seconda prova del cilentano (ma bolognese d’adozione) Antonio Paolacci, è un romanzo dall’apertura potente che incede epicamente con anafore e accumulazioni, compatto nella trama, soprattutto convincente nella sua sostanziale bicromia: il color ruggine di una fabbrica dismessa (il “Rottame”) che precipita improvviso in una tonalità di sangue rappreso; il tuono grigio e sordo dell’esistenza e di una città “che colpisce dentro, nella carne come una smania” a cui non si può sfuggire. Colori e tonalità che sono pure il linguaggio moderno e complesso di un romanzo sull’identità, ma poi anche sulla morale (le ingannevoli scatole cinesi della maschera e della verità a essa sottesa), sull’individualismo, la società, i graffi della memoria.
Rispetto al primo Flemma niente più storie intrecciate. L’eroe che campeggia nella storia quasi del tutto da solo è Matteo, anche quest’ultimo narrativamente piegato in due da un unico colpo (la tendenziale linearità della vita curvata in una sorta di chiusa “U” temporale): un solo cadavere che è un buco nero densissimo e dall’irresistibile accelerazione gravitazionale.
Matteo. Persona sedicenne, Persona in skateboard. Matteo di famiglia ricca e perdigiorno appena adolescente, uno skater che riempie con lo spray i muri della vecchia rugginosa fabbrica, il «Rottame», nel limbo che è tra stazione e città. “Met”, graffita ossessivamente, come spinto dall’oscura coscienza di un’identità precaria. Met che fa suo però uno stile sottoculturale (“il mito dei reietti che bevono e fumano e scopano”) con cui crede possibile cambiare il mondo, uno skate per mutare gli ostacoli in opportunità. “Quello che ancora non sa è che la sua maleducazione è stata disegnata per lui, pensata dopo un’analisi di mercato, decisa da una Corporation e rifilata a lui da una campagna pubblicitaria in parte occulta”. Un bisogno di futuro diluito ad arte in un eterno presente.
Intorno al “Rottame”, la notte, gay e spacciatori, un mondo di uomini dalla doppia vita.
Un giorno, nella fabbrica, Matteo scopre un cadavere, scopre che è uno skater come lui, vestito come lui (stesse Converse, stessa felpa, stesse scuciture e strappi…), che ha la sua stessa posticcia identità. Ha la testa spaccata, ma scoprire come è morto o chi lo ha ucciso presto perde d’importanza. Nello spazio della vecchia fabbrica ora dilatato dalla paura, tocca improvviso il fondo di qualcosa che lo rivela nella sua limitata pochezza rispetto a un tuono sordo e smanioso d’improvviso più grande che non gli lascia dire l’orrore a nessuno.
La sera va a un concerto – si stordisce di droga e sesso – cerca di aggrapparsi alla sua identità che sa ormai infranta. Ancora intontito Matteo torna alla fabbrica, prende la decisione di occultare il suo facile doppio, di occultare il conflitto tra ciò che forse sa di essere, ciò che non è, ciò che forse sarà o potrà essere.
Ritroviamo Matteo molti anni dopo: non ricorda il suo compleanno, la sua età, il suo cognome. Si ritrova in vestiti costosi, un divorzio alle spalle (che è un altra liquidazione del suo passato), una piccola casa di produzione cinematografica lasciatagli dal padre ricchissimo, la maschera di uomo arrivato in una casa perfetta e asettica. Pure “Matteo Qualcosa” resta un uomo segnato, difficile ai rapporti sociali, dietro l’ufficialità una doppia vita fatta di luoghi equivoci e eccitanti appuntamenti via web. Matteo vive come se l’intera atmosfera del “Rottame” gli fosse rimasta appiccicata. In parte come Davide, il protagonista di “Flemma”, Matteo non manca di capacità di leggere lucidamente squarci del suo mondo e del suo tempo, ma senza la forza di trarsi fuori, ogni giorno un salto d’ottava, una nota che continua a ripetersi uguale benché con toni più acuti, che non produce melodia. Un’umanità, tra l’altro, fatto di finte trasgressioni, di contatti anaffettivi, di uomini con la maschera (protervi e insinceri anche sotto quella), di tentativi di sfuggire a se stessi.
In questo contesto Matteo è un uomo che resta in attesa di qualcosa, smarrito, irrisolto. Fino a quando il regista Campestri (scartando sulle solite produzioni da cassetta della casa) lo affascina con la proposta di un documentario sulla fabbrica dismessa, sulla sua storia e la possibilità di un suo recupero: un problema annoso e pure irrisolto, una ferita enigmatica nell’identità della città (che nulla ha a che fare con i cascami della vita notturna e morbosa della fabbrica). Matteo prima dell’inizio delle registrazioni deve ritrovare il coraggio di fare i conti con il cadavere nel “Rottame”: necessità, perché il documentario possa realizzarsi senza intoppi, ma di più lo stringente, improcrastinabile confronto con l’adolescenza, la possibilità che questo presente esteso torni a frammentarsi nelle tre forme del tempo, che l’alba possa nascere nuova sia pure con il suo carico di difficoltà.
Due ultime considerazioni. La prima stilistica. E si è già detto che la narrazione di Paolacci si precisa e si dispone su una sorta di spazio piegato con un punto comune e due “code” vicine a toccarsi (e non a caso l’adolescenza del protagonista è narrata in terza persona singolare, e l’età adulta in prima persona singolare, come a riprodurre distacco e simultaneità). Tuttavia Paolacci fa di più (perché lo fa ponendosi previamente un problema di sguardo e costruzione con un’accuratezza che credo gli venga dai suoi studi sul cinema): frantuma ad arte lo scorrimento narrativo e ne distribuisce i tasselli come in un paziente mosaico o un collage-frattale di cui può collocare pensosamente pezzo accanto a pezzo. E dunque le istantanee sulla vita del protagonista adolescente si alternano a quelle dell’adulto e così i ritmi narrativi, le informazioni e le analisi. Paolacci scrive un romanzo solo apparentemente realista, invece continuamente innervato di flussi di coscienza, pensieri e stati emotivi che costruiscono la scena percettivamente e in maniera necessariamente limitata. Il lettore è così avvertito di confrontare sempre il singolo tassello al contesto che mano a mano si costruisce.
L’ultima considerazione è sullo sguardo. Nel suo smarrito peregrinare tra uomini, identità e situazioni, Matteo incontra Doris, una studentessa che fa la escort (con regole molto definite) per pagarsi gli studi, eppure personaggio paradossalmente non doppio, anzi onesto nella sua scabra e fredda visione della vita: “Gli equilibri si fondano sui ruoli… C’è chi comanda e chi ha bisogno di essere comandato. A letto o per strada è la stessa cosa. Nessuno davvero aspira all’uguaglianza, e tanto meno all’imparzialità, mi spiego? Perché dove non esiste imparzialità non esiste limite”. Il che – sia detto incidentalmente (ma non tanto) qui e per il resto del libro – di Paolacci coglie il sicuro sguardo morale mentre dice, senza moralismi isterici o oscuri intenti politici, una parola definitiva e dura sull’uomo del tardo evo berlusconiano.
Recensione a: Andrea Di Consoli, La commorienza (Marsilio, 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Scritture & pensieri» il 22 Agosto 2010.
_____________
Andrea Di Consoli riporta alla luce un caso archiviato
“Io non ho scritto un romanzo giudiziario, né ho fatto un reportage narrativo, tanto di moda in Italia in questi ultimi anni. Molto più semplicemente, ho voluto fare un’inchiesta giornalistica, interrogando le carte processuali e alcune persone ‘informate sui fatti’” dichiara Di Consoli nelle prime pagine del suo La commorienza (Marsilio, 2010). Indagine iniziata sulle colonne del “Quotidiano della Basilicata” e dedicata alla morte misteriosa dei “fidanzatini” Marirosa Andreotta e Luca Orioli, avvenuta la notte del 23 marzo 1988 a Policoro, in provincia di Matera.
Una seria impostazione che ha consentito a Di Consoli di non cadere in una serie di fatali trappole e di rapportare al contesto di riferimento ogni singolo elemento di una storia che, dopo innumerevoli perizie tecniche – tutte svoltesi in un clima pesantemente segnato da una quantità di incredibili contraddizioni, imperizie e ridicole sciatterie inquirenti – resta ancora rubricata ufficialmente alla voce “incidente”. Uno scandalo, una vera e propria fregola di archiviazione sviluppatasi in un clima di pigrizia e disonestà intellettuale, di bigottismi paesani preoccupati di dover “aggiustare le cose” nel silenzio, di urti tra forze inquirenti e locali poteri politici, di depistaggi interessati. Attori che hanno finito per strappare la scena ai fatti per sostituirli, complice l’immancabile giornalista scandalistico di turno, con presunti “segreti” (i loschi “festini” a base di coca, orge e potenti del posto) in cui le vittime si sarebbero non si sa come coinvolte e che ne avrebbero “consigliato”, fuori tempo massimo, l’eliminazione.
Una deriva paranoica che non ha trascinato con sé Di Consoli, sempre saldo nella convinzione di dover indagare non sulla vita di Marirosa e Luca, ma su chi li ha uccisi, scoprendo velo dopo velo la più probabile verità di un delitto passionale, tanto più mal eseguito quanto impunito grazie a una serie incredibile di circostanze. Un disvelamento che non poteva che avvincerci con l’appassionata riflessione attorno a cui si coagula l’inchiesta, che è la perdita dell’innocenza, lo spezzarsi delle potenzialità della vita a causa di un male molto più banale di quanto si sia disposti a dipingerlo.
Recensione a: Roberta Lepri, La ballata della Mama Nera (Avagliano, 2010)
Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 26 Luglio 2010.
_____________
Il mondo invisibile accanto a noi
Gli zingari, si sa, rubano. Ed è opinione diffusa che, rubare per rubare, si dedichino parecchio anche ai bambini. Per il suo romanzo “La ballata della Mama Nera” (Avagliano, 2010) la grossetana Roberta Lepri sceglie dunque un tema complesso, irto di luoghi comuni dove è facile cacciarsi. Terreno che però affronta con piglio sicuro, anche forte ormai dell’esperienza di tre romanzi e di una capacità di narrazione ormai solida (e un paio di imprecisioni temporali non incidono sulle sorti del romanzo). La capacità, anzi, di saper porgere senza intoppi e pesantezze la storia tenendone sempre strette le briglie è il pregio più visibile del libro che riesce, così, a svolgersi con una trama coerente e personaggi sempre credibili.
Ughino vive in una famiglia che ha fatto i conti con qualche naufragio di troppo nel gran mare delle speranze. Il piccolo, un bimbo emotivo e sensibile, non può dunque che idealizzare la famiglia della sua amica Sara Signorini: padre brillante chirurgo, madre assistente sociale, nucleo familiare praticamente perfetto. Il padre di Ughino, Gino Cellini, poliziotto manesco e poco brillante è intanto chiamato a indagare sul rapimento di un bambino, Marcellino, che si scopre essere stato ucciso e sepolto vicino a un campo nomadi. A capo della piccola comunità zingara, la veggente Mama nera, e tre donne che sembrano primordiali Eva provenienti dalle altrettanto riconosciute culle dell’umanità: il gelido Nord, L’Est euroasiatico e un Sud africano o amerindo.
Qui Gino Cellini già compie, con la scarsa elasticità dell’occidentale stanziale, un primo errore: confondere il piccolo assassinato con suo figlio in un pericoloso gioco di immedesimazione che si salda con la figura fosca, indecifrabile e dunque minacciosa dei nomadi. A nulla serve l’ovvia constatazione della Mama: “I figli ci avanzano i nostri. Se ne vogliamo degli altri ce li facciamo…” perché ci si mette pure lo zingaro Manuel a pedinare misteriosamente Ughino ogni qualvolta frequenti i Signorini, spaventandolo a morte e confermando Cellini nelle sue congetture.
La catastrofe (nel suo senso originario di “ribaltamento”) scoppia proprio quando Ughino confessa la sua terribile paura all’amica Sara, la quale si sente in dovere di rivelare a sua volta un segreto, ben più inquietante, celato a casa sua. Tutto a questo punto precipita: Manuel rapisce Ughino che è salvato, ma in realtà nuovamente rapito dai Signorini. Un gioco impazzito di pedine su una scacchiera più grande che alla fine si rivela nello scontro, attorno a una losca “donazione” di organi, tra una cosca mafiosa e la polizia dello scaltro commissario Spitzer, capo di Cellini. Quest’ultimo è messo di fronte, così, ai pregiudizi che gli hanno impedito di guardare al di là del proprio naso.
Insomma, pare dirci Roberta Lepri, cosa abbiamo contro gli zingari – che pure, è vero, rubano – quando l’orrore continuamente irrompe dall’interno della nostra società? Però con il pericolo di scagionare indirettamente i ricchi Signorini trafficanti d’organi se la colpa è poi di una potente criminalità che ve li costringe (e la pagina dove il “fascino del male” si fa incontro al chirurgo valeva la pena di essere indagata meglio e forse seguendo altre strade). Pericolo da cui, però, la Lepri riesce comunque a metterci in guardia, in qualche modo segnalandoci che tutti possiamo diventare ingranaggio di un sistema (mafia o altro) quando rinunciamo a lottargli contro in prima persona, magari non accorgendoci per tempo della rete compromettente in cui rischiamo di cadere.
Contraria la figura dello zingaro Manuel che, collaborando con la polizia (d’accordo con Spitzer rapisce Ughino a fin di bene) è costretto, per questa sua compromissione, a essere espulso dalla comunità di appartenenza e a “dissolversi” in quella dei “gagè”, realizzando così il costo della definitiva lacerazione tra coscienza individuale e irriducibile identità nomade. Il che mette la Lepri nella posizione di essere un’idealista pur senza idealizzazioni. Tanto da risultarci larvatamente anche un po’ pessimista, se il lieto fine – una possibilità di nascente convivenza civile – cui non rinuncia, sappiamo essere una convivenza per ora relegabile quasi del tutto solo a un libro.
Non ci rimane, allora, oltre alla Mama (che reintegra nella comunità Manuel in virtù della sua superiore comprensione delle cose), che affidarci a una figura come quella del commissario Spitzer, che si basa su solide indagini, e poco s’abbandona a sacrificare sull’altare dei luoghi comuni. Così come ci piace pensare abbia scorso i dati ufficiali sui rapimenti di bambini raccolti dagli organi di polizia e da studiosi del problema, cifre in cui gli zingari (confusi con chi?), nonostante l’opinione comune, non compaiono mai.
Racconto: Labirinto centrifugo
Questo racconto è stato pubblicato su «L’immaginazione», n. 255 (giugno 2010), p. 18-19.
_____________
Un reportage. Volevo fare un reportage – mi ricordo – e come un matto me ne stavo a un angolo del centro chiedendo ai passanti dove fossero mai i limiti della città e, oltre, cosa poi ci fosse. Ma chi sfuggiva infastidito, chi alzava le spalle. Qualcuno chiamava un agente. Da lì non capivo granché. La città digradava tutta nel tempo, indistinta, dalle colline all’Arno e poi dal centro in lontananza.
La Firenze che cerco invece non è qui, è fuori mappa, fuori dalle pagine di un saggio in una biblioteca, fuori dalla testa dei fiorentini. Sì, certo, questa città non ha confine – l’ho detto – ma ha una frontiera, uno spazio che si dilata e cambia e s’apre la strada in un mondo estraneo. Spazi da attraversare a piedi o con mezzi lenti: niente frenesie, auto veloci. La periferia come esperienza, sangue, carne, vita. Ecco. C’è un posto di questa città che non è fatto di pietra, di Storia, di un Rinascimento di cartone consegnato ai turisti. C’è un posto in questa città dove non c’è l’Uomo, ma i blocchi, i lotti, i palazzi in ferro-vetro. Una terra che nel ventre non ha terra, ma cavi, tubi, cemento, il sangue elettrico. Una campagna sconfitta, atterrita, d’acciaio, dove non ci sono alberi, perché non ci sono radici. Ci sono lingue, dialetti, vernacoli, ma non c’è Dante. E se mai passò di qui, anche da questo inferno, non si vede più.
Tempo fa mi aggiravo a Mestre. Un cielo saturo e indistinto, la testa vagava nel nulla riempito di case, di vecchi, di gente agitata nel volo confuso che fanno le mosche. Presi un mezzo solo per fuggire e più avanti, da qualche parte, l’autobus s’arrestò sulle rive di un mare piatto e salmastro. Dall’argine risalì un mestolone: stava fermo sul ciglio di strada, ci guardava come uno in attesa alla fermata. Così il bus mi parve all’improvviso una cosa fuori posto, una vecchia lavatrice, una tele rotta buttata appena oltre il ciglio della via. Mi ricordai allora di un mondo opposto, un frigo bloccato nell’acqua ghiacciata del Bormida, la notte che mia cugina era morta nell’incidente e se ne stava lì nella camera, vestita di un improbabile rosa, come il suo nome. Cairo Montenotte: l’ossimoro mi apparve dirompente all’improvviso. Col piede scostavo dalla via pietruzze calcinate dal freddo.
Di Potenza mi sovvenne solo dopo, l’autobus pieno di studenti prima di scendere in corteo contro la Falcucci, e mi chiedevo perché diamine mai la gente se ne stesse acquattata dietro le colonne dei palazzi. Fino a quando scesi, ché il vento tagliava la faccia con le lamette.
A Roma, invece, c’era a via degli Ausoni questo amico studente che mi disse «vieni» e io l’andai a trovare e entrai nella corte chiusa dei palazzi, i balconi con le ringhiere sottili di metallo rugginoso. Non un muro imbiancato, tutto era ridotto al suo telaio, al suo scheletro essenziale: una bicicletta senza ruote, una finestra senza vetri, un ombrello senza telo. E questa struttura che mi girava attorno come un mancamento, questa babele che si avvitava come una colonna, aveva il suo Minotauro. Un vecchio dagli occhi sottili, crudeli, una canotta lercia, i calzini, le mutande vecchie con la patta aperta, i testicoli avvizziti. Ci guardava ingobbito dal balcone. Fumava dal naso e la cenere cadeva giù.
A Firenze ci sono le risse e gli omicidi, i matti e gli stupri, i regolamenti di conti, gli scempi edilizi, le fatiscenze come altrove, ma se pensi la città ti scatta come un delirio e il Duomo e le colline fiesolane e i beni artistico/culturali saturano – a un tratto – la testa, la memoria, la coscienza, la nostalgia. E dunque anche il Pacciani io l’ho sempre immaginato alla sbarra cantare improvviso «la mi porti un bacione a Firenzeee!» con seguito di applausi a scroscio e sicuri ritorni turistici.
In via Baracca, sull’insegna del negozio c’era «Ettahoid», adesso c’è «Anour» mi pare, ma apre più tardi. Sulla soglia del negozio una gran barba squadrata. Il macellaio asciuga le mani in un canovaccio lindo. Più avanti, sulla via Pratese c’è una cupolina ottagonale, l’oratorio di Santa Maria Vergine. Non è tra i campi, come a Bolgheri. Fa da spartitraffico, schiacciata da un soprapassaggio, crepata dai motori. Dopo ci sono solo i cinesi, una Firenze che si srotola come una mappa antica, hic sunt leones. Però forse sono io che ci vedo tutte queste cose e altri no, e qui è solo un gran caos e voglio dare un ordine che, insomma, par che ci sia e – se poi t’aggiri dentro – non c’è, e la modernità è solo un gran baccano per distrarre l’attenzione.
Osmannoro. Lungo i viali larghi di questa città altra ma nascosta, cammino nel vuoto surreale, scorro le alternanze di spazi vuoti e capannoni. Ci sono luoghi, qui, in cui le case diradano e i capannoni iniziano, punti dove le costruzioni in muratura non cessano ancora e le strutture in ferro-vetro ancora non trionfano e allora accade che le tipologie si ibridano, le abitazioni ospitano officine d’auto e concessionari. Ci sono un paio di mutande stese nei pressi dell’insegna della banca.
Domenica. Perché sia venuto qui, ora, in questa luce implacabile e vuota, non so dire. Cartelloni muti, macchinari fermi, anche i cinesi sembrano dissolti da questo pomeriggio di primavera. Improvvisi vulcani vomitano dal cemento fiumi di formiche nere.
Dietro una grata c’è un pezzo quadrato di terra. Forse un giardino, nei primi propositi, ma incolto, quasi a dire che lo spazio per disegnarlo questo giardino, per piantarci fiori e per curare l’erba e disporre siepi c’è stato, ma non c’è stato il tempo, il tempo e i soldi per orpelli, belletti ipocriti, utopie da falansterio, decori casalinghi. Sul terreno crescono selvatici i ciuffi di canne, le garighe di inula, se piove le code d’equiseto quando la terra ha memoria dell’acqua, nostalgia del padule che era. Attraverso la grata sfondata entrano furtivi due ragazzi e una ragazza, mi sembrano slavi, portano buste della spesa. Guardo la costruzione che occupano: è piccola, un grumo d’uffici in disuso, con le finestre sbrecciate.
Dall’autobus scende impacciata una vecchia signora, sale una coppia. Sono cinesi, restano in piedi, parlottano aggrappati alla sbarra metallica. Lui segaligno, la faccia tagliata con l’accetta, smorti i suoi pantaloni marroni, smorta la sua camicia a quadri. Anonimo – mi dico – il volto e i vestiti. Ha i tratti tirati, è inquieto, sibila qualcosa a quella che pare essere sua moglie o una parente. Non capisco, ma forse è solo il loro modo di litigare. La donna ha un vestito grigio che non riesco a definire – ma importa? – ha questi capelli neri, forti, spessi, che si porta sulla testa come un buffo copricapo africano, il tetto di una capanna. Le labbra sottili celano due incisivi deformi, ribattono all’uomo con pause improvvise, più perentorie.
Eccoli i controllori: salgono a percorso avviato, come sempre. Parlottano due minuti del più e del meno, come normali passeggeri. Poi attaccano al bordo delle giacche i cartellini. È la loro tecnica, efficace, usata, affinata come quella di un paio di camaleonti. La coppia non fa a tempo ad accorgersi della loro presenza che loro sono già lì, a chiederle il biglietto che non hanno.
L’uomo e la donna subiscono una repentina mutazione. I volti, che prima s’affrontavano, ora sono giustapposti, si distendono, diventano di colpo gioviali, accennano come a un inchino di fronte alle facce inespressive dei tipi, che insistono. Vorrebbero eccepire, farfugliano un paio di parole in italiano imparate chissà dove. Vorrebbero, insomma, non so come, rifiutarsi, ma quelli, ecco, quelli si fanno più fermi, li stringono da presso, esigono e poi emettono un suono che supera il rumore di fondo del mezzo, vibra più delle scosse dell’insieme delle parti metalliche, delle buche della strada, dei seggiolini dove siamo seduti: «prego, documenti». I due s’inchinano, no si piegano, ecco, si
flettono nel loro sorriso finto, ostentato, irritante. Oscillano. Paiono canne di bambù in preda a un vento improvviso, le loro voci come un fruscìo di foglie, gli occhi sgranati, due marionette da teatro imbellettate, da Opera di Pechino. Attorno. Girano attorno una dietro l’altro a passettini, e a passettini dietro di loro i controllori e dietro ancora, a passettini, gli sguardi della gente e finalmente la scena si apre a gesti acrobatici, ai salti, al gong, ai fiocchi delle spade roteanti, alle nacchere e ai piattini sempre più veloci, alle voci flautate, ai lamenti suadenti, i movimenti meccanici, le teste oblique, i mostri blu, i mostri semidivini che chiedono il biglietto, i due cinesi pazzi tra onde di tragedia, che proprio non si possono, non si possono sfuggire.
«Documenti, prego». E tutto si ferma. La farsa finita, il tempo sospeso, la mano che fruga, lenta, i vestiti. Mei Lan-Fang, il volto esacerbato, la bocca aperta, il respiro faticoso che estrae un portafogli. Mei Lan-Fang che si rammarica. Mei Lan-Fang che ha paura, le sue labbra sporcate di ciliegia. E questo tempo interminabile, pari alla cifra infinita che fa cinquanta euro, al tempo infinito che serve a vergare un verbale, al tempo infinito in cui un cervello, due, insomma, si lambiccano all’unisono infinitamente per inventare chissà quale scusa al momento del ritorno, in fabbrica, il capo chino, il capoccia che guarda storto. Oppure sono solo due furbi: ce l’hanno messa tutta per fregare l’Ataf, ma gli è andata male, cinesi di merda. L’autobus improvvisamente stormisce di opinioni da facile democrazia diretta, sul modello dei reality show. E poi la porta si riapre e i due scendono e con loro riprende il tempo e il colore smorto dei panni e romba l’autobus e sgassa e i cinesi, sì insomma, i due, che sono proprio i due cinesi che avevo visto salire (Mei Lan-Fang chi l’ha mai conosciuto?), i due che riprendono il solito colore giallo dei contadini costretti all’industria, costretti al suo ergastolo, a un riscatto che non pagheranno mai, si arrestano un attimo, si guardano in faccia e, mentre il mezzo gli chiude le porte sul muso, alzano il pugno, sì, la memoria per un istante a ravanare in un guazzabuglio di adeguate parole e poi, insomma, poi parte l’invettiva dell’uomo. Fa eco la donna e rincara, ma sempre con voce strozzata, inascoltata, inascoltabile. Sibilata vibrante protesta che l’autobus copre mentre sta sfilando via.















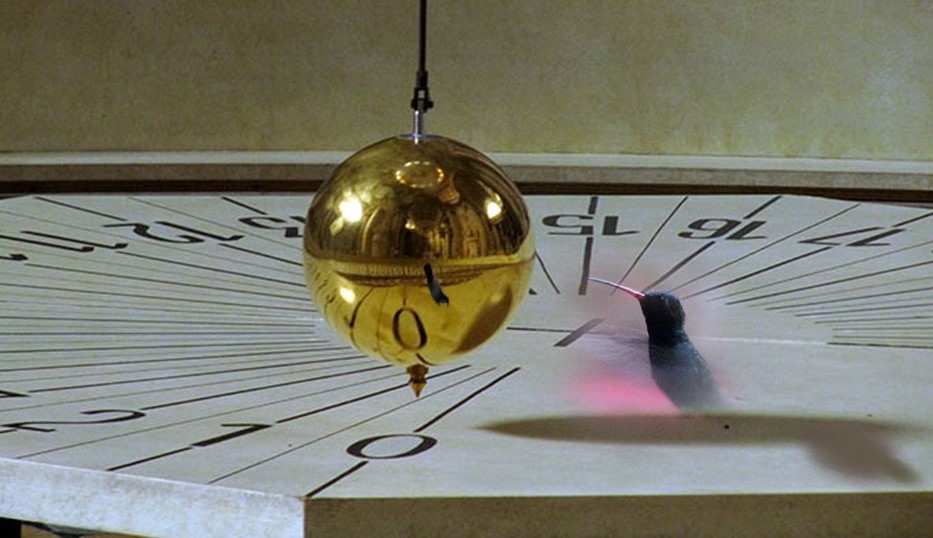
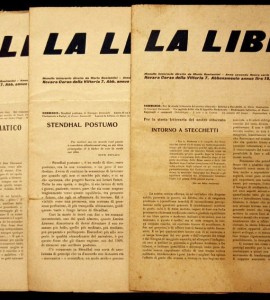
 L’intenso girovagare di Emanuelli si arresta attorno alla fine degli anni ’50. Tuttavia, il desiderio di tornare a occuparsi maggiormente di cultura per La Stampa, dove lavora, resta piuttosto frustrato. Dopo la vittoria al Bagutta, nel ’59, con il romanzo Uno di New York, e la rottura con De Benedetti, nel 1963, finalmente approda alle pagine culturali del Corriere della sera. Dalle colonne del Corriere Letterario, dove lo scrittore lavora nella stessa stanza con Eugenio Montale, Emanuelli dimostra non solo una grande apertura intellettuale, ma anche di saper bene leggere i mutamenti culturali del suo tempo accogliendo, sia pur in burrascoso confronto (fermo restante la sua formazione), gli enragé della neoavanguardia. Forse non è, allora, un caso che Emanuelli, da tempo pubblicato da Mondadori, editi gli ultimi suoi due (e più particolari) libri con Feltrinelli. Casa editrice che, sotto la direzione editoriale di Gian Piero Brega ha, in quegli anni – supportato da
L’intenso girovagare di Emanuelli si arresta attorno alla fine degli anni ’50. Tuttavia, il desiderio di tornare a occuparsi maggiormente di cultura per La Stampa, dove lavora, resta piuttosto frustrato. Dopo la vittoria al Bagutta, nel ’59, con il romanzo Uno di New York, e la rottura con De Benedetti, nel 1963, finalmente approda alle pagine culturali del Corriere della sera. Dalle colonne del Corriere Letterario, dove lo scrittore lavora nella stessa stanza con Eugenio Montale, Emanuelli dimostra non solo una grande apertura intellettuale, ma anche di saper bene leggere i mutamenti culturali del suo tempo accogliendo, sia pur in burrascoso confronto (fermo restante la sua formazione), gli enragé della neoavanguardia. Forse non è, allora, un caso che Emanuelli, da tempo pubblicato da Mondadori, editi gli ultimi suoi due (e più particolari) libri con Feltrinelli. Casa editrice che, sotto la direzione editoriale di Gian Piero Brega ha, in quegli anni – supportato da