Archive for the ‘ARTICOLI’ Category
Come un’onda che si tuffa sullo scoglio: la storia vera di Roberto Tancredi, portiere della Juventus
Breve topologia letteraria della follia
Questo articolo è stato pubblicato sul n. 22 di aprile di «FuoriAsse – Officina della Cultura»
________________________________________________________________________
http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/119-fuoriasse-n-22/935-fuoriasse-22.html
C’è una tela di Goya, esposta alla Real Academia de San Fernando, a Madrid, intitolata la Casa de Locos. Finita nel 1812 dopo alcuni anni di saltuario lavoro, evoca un luogo – manicomiale – dove si aggirano, sotto le volte di uno spoglio stanzone, grottesche figure di alienati seminudi appena rischiarati da una luce opaca e stagnante. Sulla parte sinistra dell’opera, proprio dove nella penombra si ammassano più numerosi i segregati, campeggia un uomo dai mustacchi lunghi e neri, dallo sguardo esaltato e sostenuto, con uno strano copricapo munito di penne. Al suo fianco, come si potrebbe omaggiare un capo o una personalità di spicco, una donna, china, bacia devotamente la sua mano destra.
La suggestione (e, come ogni suggestione, potenzialmente fuorviante) esercitata dalla visione del pittore aragonese, se serve bene a sollevare i temi di cui argomenteremo – il viaggio nella ferita della mente umana e nei luoghi della contenzione manicomiale – serve pure, attraverso un semplice scarto analogico, a sorprenderci già nel vivo di quel racconto/reportage che De Amicis pubblicò (siamo già all’altro capo del Secolo XIX) prima sulle pagine della «Rivista d’Italia» del dicembre 1899[1], poi per i tipi del livornese Belforte e, in seguito, dei Fratelli Treves[2].
Nel giardino della follia (questo il suo titolo) coglie, infatti, lo scrittore alle prese con una cleptomane, gioviale donna di mezz’età, «vestita con garbo» e «con tre penne di cappone piantate nel nodo dei capelli, in forma di raggiera»[3] la quale, più avanti, spiritosamente paragona De Amicis a Pallavicini di Priola, generale vittorioso sui drappelli garibaldini in Aspromonte e, in seguito, comandante impegnato nella repressione del brigantaggio meridionale. I due, in effetti, si somigliano, anche accomunati da due folti baffi neri, ma come il risvolto negativo – biografico, politico e morale – dell’altro. Non a caso la donna «da quel momento, come se si fosse fatta nella sua mente una sostituzione di persona, non mi chiamò più che “generale”»[4].
E così già il titolo stesso dato alla pagina giornalistica, Nel giardino della follia, altro non è che stridente ossimoro, Eden e Limbo dove si trascinano le non battezzate dalla ragione, e dove si rifugiano le inquietudini suscitate dai ricordi del figlio Furio, da poco suicidatosi con un colpo di rivoltella a Torino, al Valentino (un parco!); e le apprensioni per la tenuta mentale della moglie, che si aggraverà più avanti.
Inizia, in questo modo, per lo scrittore una sorta di strano viaggio, di girovagare a più dimensioni: lungo i sentieri del giardino, intersecati da sensi di pena e corrispondenti volontà di fuga; e tuttavia anche della singolare sensazione di essere, oltre che tra le mura del giardino, anche tra quelle della mente delle alienate: «Ebbi un senso di pena, non mai provato, e che non saprei bene esprimere. Ero dunque vissuto un tempo in quell’anima: v’ero vissuto e v’ero morto; il mio nome non era più nella sua mente che un suono, come la mia persona un’ombra al suo sguardo. E continuando a passarsi la mano sulla fronte, pareva che mi volesse dire: – Vedi, questa è una tomba, e anche tu ci sei sepolto»[5].
Ma restano lampi, come, del resto, l’apparizione della giovane inginocchiata e assorta in giochi regrediti di bambina, fasciata in un busto che sembra allo scrittore, in un primo momento, un curioso «abito da ginnastica», ma che si rivela essere, con un brivido, una camicia di forza «in riposo, per adesso»[6]. Le pagine di De Amicis, come nel suo stile, non avevano e non avrebbero potuto avere alcunché di calcato, di espressionistico o di visionario. Come ha ben scritto Carlo Alberto Madrignani, Nel giardino della follia manca «di vistosi elementi coercitivi» e anche questa pagina «vuol, forse, suggerire una latente dimensione di violenza, che tuttavia l’autore evita di enfatizzare»[7]. C’è poco di naturalistico, di fotografico o, all’opposto, di carduccianamente oratorio nello stile di De Amicis; semmai il tentativo, con i suoi pregi e i suoi rischi sentimentalistici, «di offrire al lettore una riproduzione letteraria che lo induca a trovare uno status emozionale specifico»[8]. E tuttavia, nelle pagine del Giardino c’è pure un controllo della pagina che non può che ritrovare le sue ragioni nelle recenti tragedie familiari, tra l’altro sottolineate dalla presenza, nel prosieguo del racconto, del secondogenito dello scrittore, Ugo. Ma se è pur vero che lo sguardo di De Amicis resta «preideologico», resta, cioè, una «forma dello sguardo capace di cogliere le movenze emotive e i bisogni affettivi intesi come esigenze materiali altrettanto urgenti di altre (fame, sesso, denaro) esaltate dalla coeva antropologia positivistica»[9], è anche vero (come pure in Cinematografo cerebrale[10]) che, in più punti, la prosa deamicisiana finisce per incagliarsi e sfumare la sua forza tra la resa colloquiale e l’esigenza del distacco, tra il tentativo di confrontarsi attrezzato di uno stile letterario formalmente composto e una materia, la follia, che continuamente gli si oppone nei fatti.
E se ciò non impedisce allo scrittore di intuire – a proposito dell’improvvisa apparizione della donna agitata «da impeti furiosi di baccante»[11] – quanto limitata possa essere l’analisi positivistica e bonaria del dottore che lo accompagna e, cioè, che la sopravvenuta pazzia non porti con sé, se non in casi rarissimi, una trasformazione radicale dell’indole, allo stesso modo non impedirà a De Amicis di sentirsi superiore nel suo dolore di “uomo pienamente cosciente” rispetto a quello possibile delle sofferenti rinchiuse in manicomio. La qual circostanza rivela, in altre parole, come la frenologia e la prima psichiatria non andassero troppo per il sottile nella distinzione dei casi patologici inserendo, in poche larghe categorie, il disadatto sociale, l’emarginato, il disturbato e il delirante. Di lì a poco, infatti, l’esigenza di giungere a una regolamentazione degli istituti psichiatrici unica per tutto il territorio nazionale portò ad approvare la proposta Giolitti del 1902 nella Legge 36/1904 che avrebbe ispessito le mura di quel giardino fino ad allontanarle definitivamente in un luogo altro, separato e lontano anche se ancora dentro il corpo della città. Se dunque è vero, come scrive Madrignani, che la pazzia per De Amicis è la pericolosa constatazione di «una parzialità, non un segno organico che separa totalmente i malati dai sani»[12], pare anche chiara la contraddizione (che lascia qualche non fugato sospetto di apotropaicità) di mantenere, da parte sua, ogni compostezza formale nella descrizione propostane e ogni distacco dalla sua patente irrazionalità.
I folli sono come sonnambuli, spiega allo scrittore il dottore: soffrono poco perché la loro coscienza è anestetizzata dal male che rende rapsodico il loro dolore. In tal modo anche il savio può, in alcuni casi, soffrire di periodica follia. Il dubbio si insinua così tra le maglie delle solite sicurezze e apre le porte all’introspezione. Avviene quando irrompe sulla scena la giovane bionda cantante sull’aria (guarda caso) della belliniana Sonnambula: è qui, con questo richiamo all’Opera e all’Arte o a un effetto di specchio, che la riflessione sulla fragilità mentale più colpisce i pensieri di De Amicis. Ma anche qui l’episodio non resta che un momento, un lampo, incapace di dare ulteriore sangue allo stile certo caldo, ma mai definitivamente coinvolto dello scrittore.
Del resto, a che pro insistere in un dialogo se adoperare coi pazzi lo strumento della ragione sarebbe – sono ancora le parole del dottore – «come suonare il violino a un sordo o scrivere la lettera a un cieco»[13]?
Cosa, a Torino, sarebbe diventata questa apparente resa della razionalità rispetto alla mente ferita dei ricoverati ce la racconterà, poi, il Novecento, con l’aggiunta del peso di due guerre devastanti, della scoperta dell’universo concentrazionario, del controllo politico del privato dei totalitarismi e dell’abdicazione a ogni verifica democratica dei poteri da parte della nuova società affluente e del “benessere”. Da questo pozzo fondo, verrà tirato su un Leviatano o, che è lo stesso, le parole agghiaccianti di un ormai quasi del tutto dimenticato Giorgio Coda: «Portami su quello che canta!». È lo scandalo che Alberto Papuzzi, con l’ausilio di Piera Piatti, riportano a galla nell’omonimo libro pubblicato da Einaudi[14] con un linguaggio ormai scarno, giornalisticamente maturo eppure coinvolto, partecipato. Non si tratta più, infatti, di parlare ai sordi, come nelle parole del dottore del giardino di De Amicis, ma di riconoscere l’identità dei reclusi di Collegno, di riconoscerne i diritti a un trattamento pienamente umano. Sono gli anni dell’antipsichiatria che porteranno di lì a poco alla frettolosa approvazione antireferendaria della “Basaglia” (180/13 maggio 1978). Anni che avrebbero chiuso definitivamente la pagina pure coraggiosamente aperta da De Amicis con la condanna a cinque anni di reclusione e e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici di Giorgio Coda per maltrattamenti e applicazione indiscriminata e punitiva del mezzo più noto come elettroshock.
______________________
Note:
[1] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, «Rivista d’Italia», a. II, vol. III, dicembre 1899, pp. 581-600.
[2] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, con disegni di G. G. Bruno, Livorno, S. Belforte e C. Editori, 1902; con qualche variante in più rispetto alle precedenti l’edizione milanese dei F.lli Treves del 1904 alle pp. 147-176 della raccolta Nel regno del Cervino. Nuovi bozzetti e racconti.
[3] Tutte le citazioni del racconto deamicisiano saranno qui riprese dall’omonima edizione, a cura di Roberto Fedi, Firenze, Le Càriti Editore, 2002. Cfr. pp. 33-36.
[4] Ivi, p. 36. La donna, così come la figura del dottore che accompagna De Amicis, non è, in realtà, che la figura di uno psicopompo dantesco: l’ambasciatrice della follia nel mondo dei sani, così come il dottore (e lo stesso scrittore), è il mediatore con il mondo dei matti. Tuttavia, vedremo che, nonostante le reciproche fascinazioni, i mondi resteranno sempre ben distinti e separati.
[5] Edmondo De Amicis, Op. Cit., p. 34.
[6] Edmondo De Amicis, Op. Cit., pp. 57-58.
[7] Carlo Alberto Madrignani, Verità e narrazioni. Per una storia materiale del romanzo in Italia, a cura di Alessio Giannanti, Giuseppe Lo Catro e Antonio Resta, p. 261. Il titolo è di prossima uscita per i tipi di ETS, Pisa. Il testo raccoglie, tra l’altro, quanto prodotto da Madrignani nella curatela del libro di De Amicis, Il giardino della follia, Pisa, ETS, 1990. Ringrazio il professor Giuseppe Lo Castro per avermi dato la possibilità di consultare il libro in anteprima.
[8] Madrignani, Op. cit., p. 258.
[9] Madrignani, Op. cit., p. 260.
[10] De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995.
[11] De Amicis, Nel giardino della follia, cit., pp. 40-41.
[12] Carlo Alberto Madrignani P. 263.
[13] Edmondo De Amicis, Il giardino della follia, cit., p. 45.
[14] Alberto Papuzzi, Portami su quello che canta. Processo a uno psichiatra (scritto con la collaborazione di Piera Piatti), Torino, Einaudi, 1977.
Prigioni, camere, cinematografi e altri strani viaggi da fermo

Questo articolo è stato pubblicato sul n. 21 di dicembre di «FuoriAsse – Officina della Cultura»
________________________________________________________________________________________
http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/cooplett-news/118-fuoriasse-21/832-fuoriasse-21.html
In un passo dell’autobiografico Il frutto del fuoco (Adelphi, 1982)¹, Elias Canetti racconta del suo casuale incontro, in un caffè del quartiere viennese di Hacking, con un gruppo di gente di malaffare, dal linguaggio rozzo e violento. Tra questi, spicca un certo Poldi, alto e minaccioso, che una sera lo segue, col malcelato tentativo di estorcergli informazioni sulle ville della strada che Elias frequenta. Per distoglierlo, Canetti gli indica, invece, la casa dove abita un paralitico di nome Marek. Quest’ultimo, pur assomigliando molto, nei tratti del viso, a Poldi, non può assolutamente muoversi e gira le pagine dei libri che legge con un colpo di lingua. Poldi è dapprima incredulo (lui così forte potrebbe mai assomigliare a uno «sciancato», sia pure così intelligente?), poi, sempre più sconvolto dalle parole di Elias finisce singolarmente per bloccarsi sui suoi piedi, dimenticando di camminare e, solo alla fine, trovando la forza di tornarsene indietro, senza portare a termine il suo compito. Tempo dopo, Canetti, viene a sapere che la banda di Poldi è stata catturata e, immaginando quell’uomo, così fisicamente energico, assaggiare nuovamente le restrizioni di una cella angusta, improvvisamente gli si rivela il perché della bizzarra reazione di blocco del ladro durante quella sera.
Ecco, dunque, il luogo, il crocevia di temi dove Canetti ci pone con il suo peculiare stile da talpa, sempre capace di intersecare e annodare gallerie e strade provenienti da direzioni apparentemente lontane ed eterogenee. Tensioni, equilibri o cortocircuiti tra il muoversi e lo stare fermi in un luogo, tra liberazione e costrizione, fino al paradosso del viaggio da fermo o quello del riuscire a spostarsi, pur in una condizione di prigionia.
Un crocevia dove ritroviamo alcuni personaggi letterari, tra i quali, a esempio, il «Cavaliere» protagonista del breve racconto deamicisiano Cinematografo cerebrale (pubblicato la prima volta, insieme ad altri racconti, su «L’Illustrazione Italiana» tra il 1906 e il 1907), che un giorno si ritrova – fin là sempre preso dall’ufficio, dalla casa, dagli amici – inusualmente solo con se stesso, sprofondato in una poltrona davanti al camino di casa. Onde far trascorrere prima le ore, prende una decisione curiosamente contraria al Porthos, moschettiere tutto azione, ricordato dal filosofo Brice Parain nel film Vivre sa vie (regia di J.-L. Godard, 1962), il quale, fuggendo, si sorprende a pensare per la prima volta e, facendolo, si arresta, trovando la morte.
Risolvendosi a non voler pensare a nulla, il Cavaliere scopre, invece, che la mente può essere una casa usata da idee e visioni nomadi. Essa appare «aperta da ogni parte, senza battenti e senza imposte, come un edifizio non finito, dove entra chi vuole»². Inizia così un inarrestabile flusso di coscienza che, di associazione in associazione, porta il protagonista a un forte stato di spaesamento e di angoscia. E, nonostante l’uomo cerchi di far mente locale, tentando di volgere o guidare quei pensieri da qualche parte, finisce per ritrovarsi prima nella soffitta delle cianfrusaglie del pensiero, poi nella cantina delle pulsioni primarie, della trasgressione, della collera e della disonestà.
È questo il De Amicis più tardo, forse letterariamente meno efficace di Amore e ginnastica (Treves, 1892) o di Il giardino della follia (Belforte, 1982)³. E, tuttavia, è pure il più amaro e sulfureo: quello, per dirla con Biagio Prezioso (nella sua introduzione a Cinematografo cerebrale, Roma 1995), che porta il Franti di Cuore a farsi, da elemento deviante della società, momento perturbatore dell’Io. Del resto De Amicis ha, in questa ultima fase della sua vita, già consumato la sua crisi con le idee socialiste, il rapporto tormentato con sua moglie e il suicidio di suo figlio Furio. Uno snodo storico da dove, oltre ogni dissolto positivismo, De Amicis realizza, finalmente e col dovuto sarcasmo, che la mente «è un meccanismo da nulla, che può incepparsi all’improvviso»4 e in qualsiasi momento della vita.
Prima di De Amicis e patendo una più forte costrizione, anche il savoiardo Xavier de Maistre aveva tentato, sul piano creativo, la via di una liberazione attraverso un «viaggio da fermo» che, al di là delle sue ragioni originarie, chiunque potrebbe facilmente sperimentare. Infatti, nel 1790, durante il carnevale di Torino, Xavier, a causa di un diverbio, si era battuto in vittorioso duello d’onore con l’ufficiale Patono de Meyran. Fu quindi, per questo, arrestato e condannato per legge a 42 giorni di cattività da scontare nella Cittadella di Torino. Seguirono giorni oziosi, grigi e destinati al rimpianto della libertà perduta. E, nondimeno, furono proprio i disagi seguiti a quella esperienza di spaesamento a creare l’esigenza di un nuovo impaesamento, cioè la possibilità di un felice ritorno a casa, sia pure letterario. Ritorno che si realizza, «avventurosamente», tra influenze Rousseauiane e digressioni di ascendenza sterniana, tra briose flânerie, meditazioni sul tempo, e pigri, quanto pericolosi, spostamenti «a cavallo» del proprio seggiolone (del quale scosta da terra, per avanzare, alternativamente le zampe a destra e a sinistra, con effetti di buffa instabilità).
Fratello del più noto Joseph, Xavier fu scrittore in definitiva episodico, ma sempre umanamente e moralmente partecipato, «pieno di grazia, delicato e commovente» (così Sainte-Beuve, nel 1839, sulla «Revue des deux mondes»). Perdigiorno indolente e svagato, intellettualmente vivace, ma pure capace di affrontare ascensioni in mongolfiera, campagne militari e poi lunghi e faticosi viaggi, Xavier sempre apparve un carattere curiosamente polarizzato. Condizione che, insieme agli aspetti contenutistici propri della sua opera, non manca di permeare e di illuminare, ancora oggi, la sua produzione, come pure ha fatto notare Carmelo Geraci (curatore dell’edizione italiana di Voyage autour de ma chambre e di Expédition nocturne autour de ma chambre, Bergamo 1999)5.
Del resto, de Maistre stesso si persuase di questa sua inclinazione caratteriale se, dopo i primi convenevoli, scrive del suo Viaggio che: «Esso farà piena luce sulla natura umana; è il prisma con cui si potrà analizzare e scomporre le facoltà dell’uomo»6 sebbene, in realtà, il prisma altro non si rivelerà essere che il dispositivo rivelatore della natura del savoiardo. E il congegno atto a far funzionare l’intera struttura del libro, che, non a caso, si dipana dal ricordo di una banale scottatura delle dita frutto di una paraprassia, di una distrazione generata da un sovrappensiero.
Atto sintomatico che presto rivela la sua origine platonica, essendo composto l’uomo «di un’anima e di una bestia […] assolutamente distinti, ma talmente compenetrati l’uno nell’altro, oppure uno sull’altro, che l’anima deve aver proprio una certa superiorità sulla bestia per essere in grado di distinguere l’uno dall’altro»7. Un’idea di bestia, dunque, forse non così sovrapponibile a quella di corpo inteso come pura vegetatività. Perché la bestia (l’altra, come la chiama, platonicamente, Xavier) rivendica una sua volontà, una sua sensibilità e un suo gusto autonomi. Ne deriva che: «La grande arte di un uomo di genio è di sapere bene educare la propria bestia a tal punto che questa possa andarsene da sola, mentre l’anima, libera da quella penosa intimità, si eleva fino al cielo»8. Oppure, quando così ben allenata, trovandosi la bestia in stato di cattività, possa ogni giorno volare a riaprire la porta di casa ritrovando i libri, i quadri, le esperienze là vissute, e raramente percorrendo una linea retta nel muoversi, a esempio, dalla tavola al letto, abbracciando il cane o parlando con il proprio maggiordomo.
Ecco, allora, che nel suo commiato, alla sua scarcerazione, Xavier potrà farsi beffe di chi pretende restituirgli la libertà, pur rammaricandosi di dover riprendere le catene della quotidianità, degli affari, della convenienza, del dovere. E tuttavia, de Maistre coglie, nel rimpianto delle sue «gioie» di prigioniero, la consolazione di una «forza segreta» che lo trascina dicendogli che ha «bisogno di aria e di cielo, e che la solitudine somiglia alla morte»9. Che è quel sentirsi «duplice» che Xavier risolverà solo molti anni dopo, tornando da una nuova spedizione intorno alla sua camera una notte lunga una guerra e un’epoca.
_______________
Note:
¹Ed. orig.: Die Fackel Im Ohr, Lebensgeschichte 1921-1931, Munchen-Wien, Carl Hanser Verlag, 1980.
²Cfr. Edmondo De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 29.
³L’articolo Nel giardino della follia, scritto a seguito di una visita presso l’allora ospedale psichiatrico femminile di Torino, fu pubblicato prima di uscire in volume, sulla «Rivista D’Italia», 15 dicembre 1899.
4Biagio Prezioso, Introduzione, in Edmondo De Amicis, Op. cit., p. 14. Il curatore sintetizza un passo tratto da E. De Amicis, Nel giardino della follia, a cura di carlo Alberto Madrignani, Pisa, ETS, 1990, pp. 66-68.
5Ed. orig.: Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre e Expédition nocturne autour de ma chambre, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1896.
6Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera, traduzione, introduzione e note di Gennaro Auletta, Catania, Edizioni Paoline, 1961, p. 27.
7Ivi, p. 28.
8Ivi, p. 29.
9Ivi, pp. 133-134.
La masseria di Giuseppe Bufalari e la modernizzazione del Sud – Intervista a Antonio Celano di Sara Calderoni su Fuori/Asse, novembre 2016, n.18

La copertina del n. 18 di “Fuori/Asse” illustrata da Lucio Schiavon

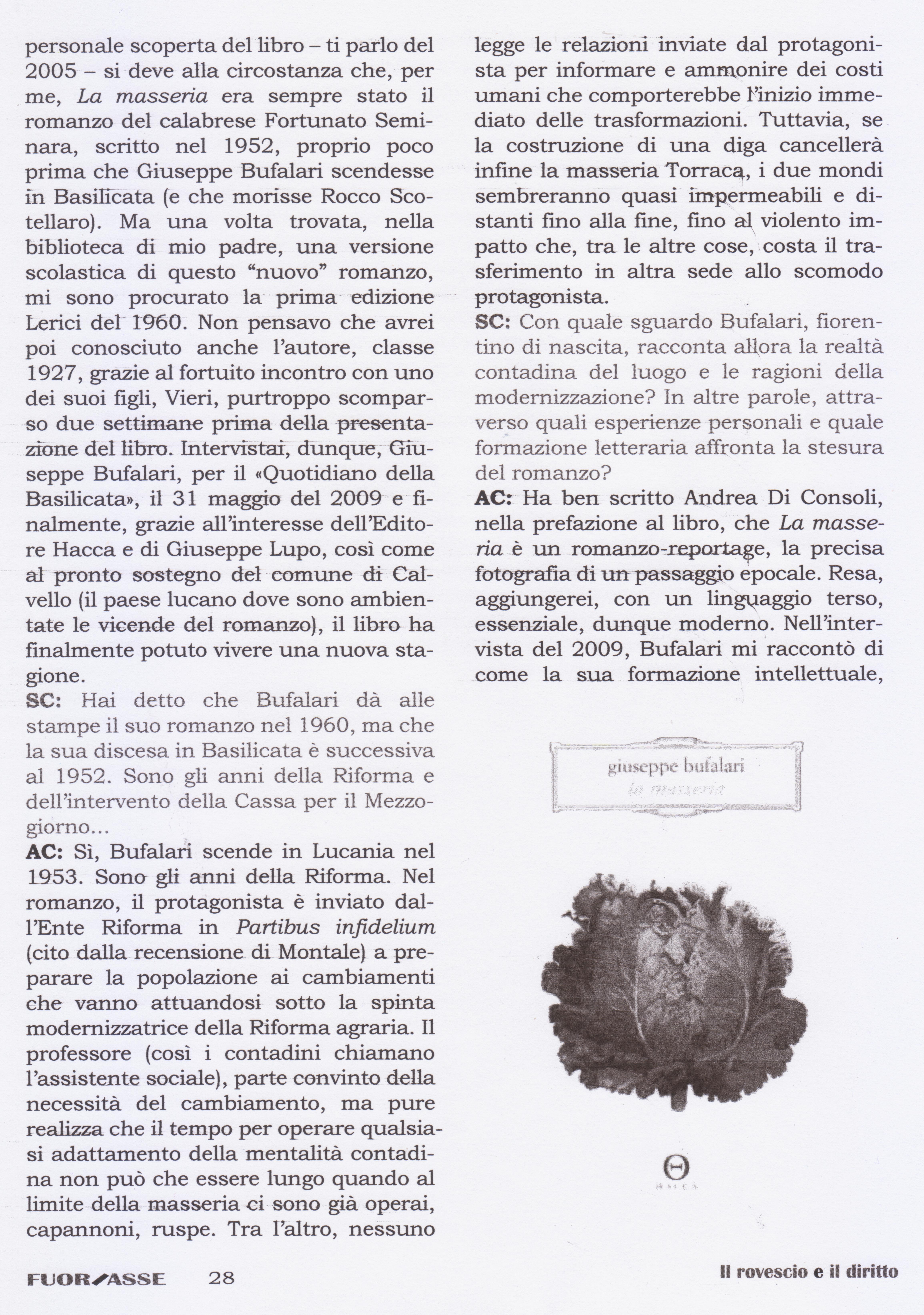

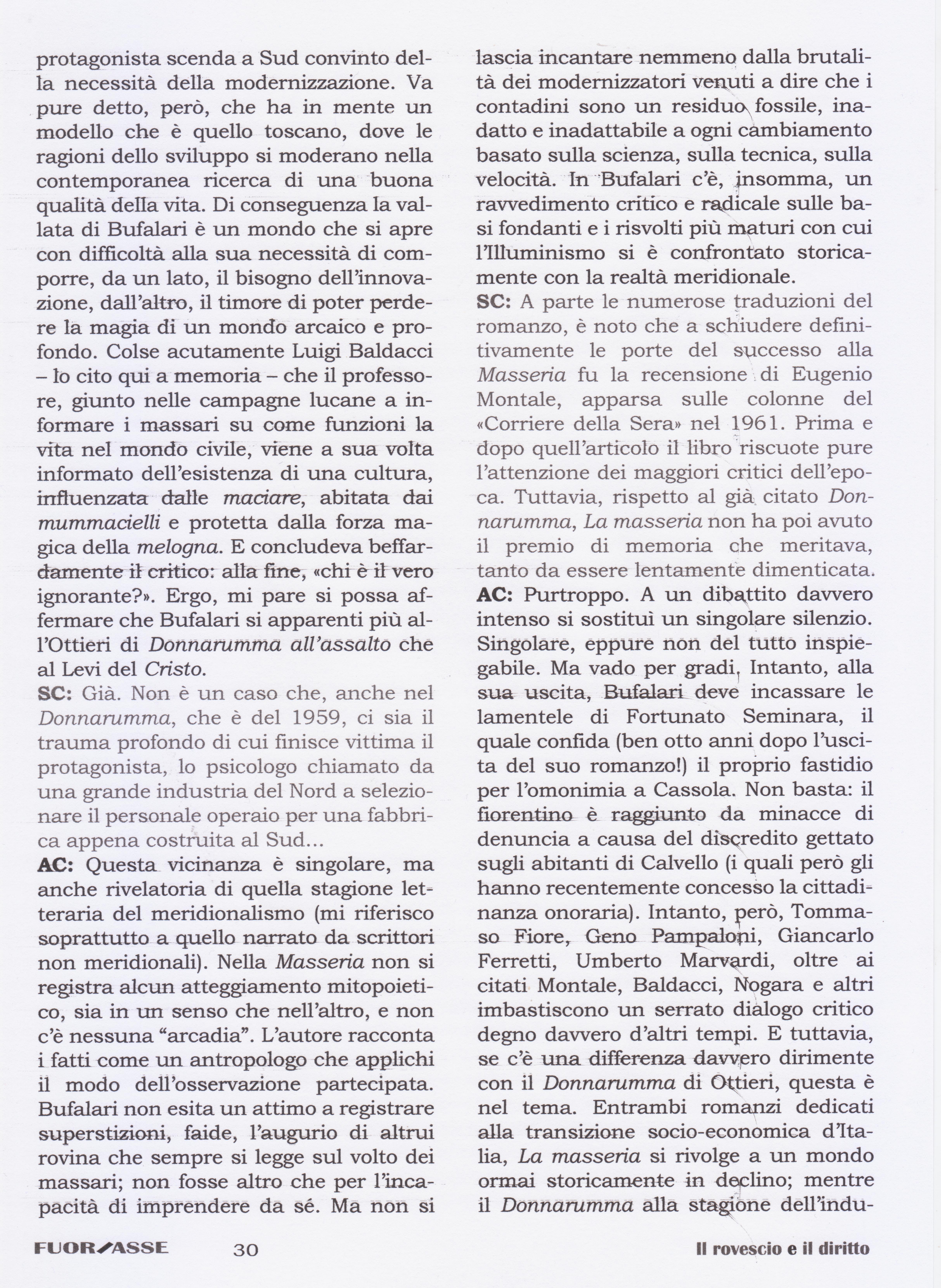
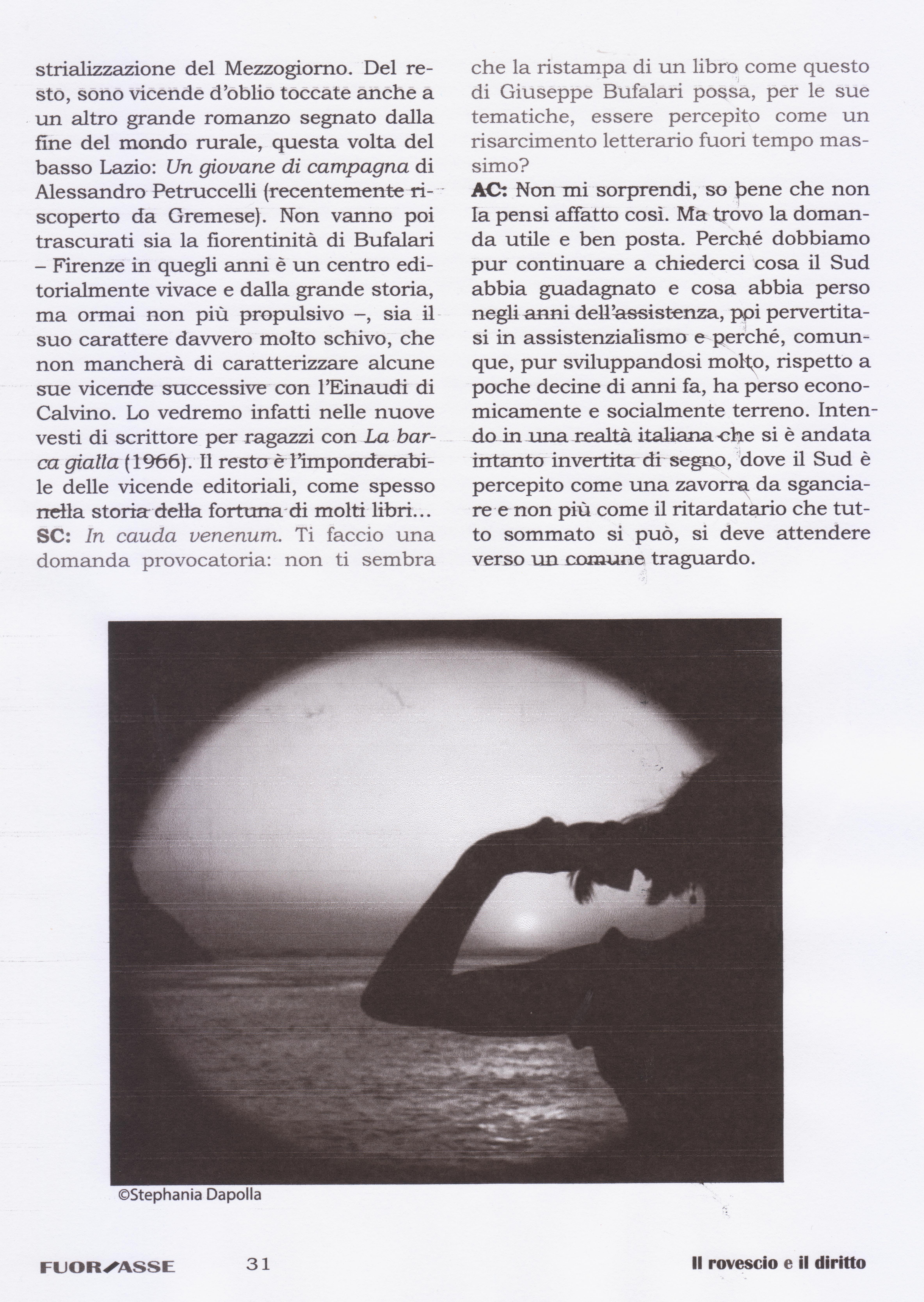
http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/115-fuoriasse-18/744-fuoriasse-18.html
Premio “Carlo Levi” ad Aliano. Tra calanchi e letteratura
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», lunedì 1 dicembre 2014.
___________
Ero ad Aliano, a seguire la riuscita cerimonia di consegna del “XVII Premio letterario Carlo Levi” e, confesso, anche per godermi ancora una volta il paesaggio così assoluto dei calanchi che già mi aveva entusiasmato quest’estate, in occasione del festival di paesologia. Mi è parso di leggere alcune difficoltà durante lo svolgimento del premio che, a questo punto, avrebbe bisogno di poter spiccare un ben più deciso salto di prestigio e autorevolezza. Nulla di irrisolvibile, ovviamente, anzi. Però vorrei ragionarci ora, a bocce ferme.
Intanto la mattina, i vincitori del premio e i loro libri, sono stati presentati dagli ormai mitici Don Pierino Dilenge e Raffaele Nigro alle scolaresche di alcune medie superiori del circondario.
A parte qualche breve lazzo di alcuni studenti nella parte superiore della sala, è accaduto che solo una studentessa abbia posto una domanda a Laura Pariani e solo una docente si sia avventurata a chiedere una curiosità all’ottimo Ettore Catalano. Il resto della truppa è rimasto sprofondato in un diuturno silenzio. Solo colpa della solita scarsa attenzione studentesca – e ce ne laviamo le mani?
Bene ha fatto Nigro, allora, a richiamare un maggiore sforzo organizzativo del Premio in sinergia con le scuole del territorio, perché occorre che la concentrazione e il coinvolgimento a una cerimonia di tal genere sia sollecitata da una lettura e da una riflessione (anche sul contesto) degli studenti, per almeno qualcuna delle opere, che preceda l’incontro. E, del resto, sarebbe più proficuo cercare di rendere istituzionale l’appuntamento con le scuole medie superiori anche attraverso la proposta, ogni anno, di una data più certa e stabile della manifestazione. Così come gioverebbe osare una formula meno “classica” e più interattiva di incontro tra giovani e scrittori che non sia solo quella delle valutazioni e degli spunti provenienti dagli scrittori il giorno della premiazione.
Non lo so, ma presumo che questa sia una questione (sempre dolorosa, e non solo per il “Carlo Levi”) di fondi – l’acquisto dei libri da diffondere nelle aule, il noleggio degli autobus con cui trasferire le scolaresche, il budget comunale ecc. – o, in altri termini, “una croce”, di cui non si può far ulteriormente carico chi si sbatte, e parecchio, per assicurare ogni anno la piena riuscita della manifestazione. E il discorso, mi pare, valga anche per la scuola, sempre alla canna del gas per quanto riguarda budget, fondi, possibilità, così come per i tempi di preparazione specifica da parte di insegnanti e studenti.
Un altro punto. Il pomeriggio, nonostante la formula del premio fosse stata invertita nell’ordine degli interventi, privilegiando, come giusto, prima l’escussione degli scrittori e delle loro fatiche, i politici hanno fatto la loro passerella serale al Premio. Non mi pare uno scandalo, se a loro si debba pure l’accesso ad alcuni fondi o la formulazione di proposte valide. Però mi ha sconcertato non poco che tre uomini di politica– mentre il pubblico sciamava via inesorabile – abbiano complessivamente parlato un tempo superiore a quello che i quattro scrittori e i due conduttori hanno utilizzato per confrontarsi in una sera a loro dedicata. Un tempo tra l’altro, m’è parso, parzialmente sprecato a parlare di cultura con un’idea, a un certo punto, francamente generica, rimbalzando tra tematiche e suggestioni le più disparate. Alla fine anche il pubblico, ormai poco lucido, non so quanto sia riuscito a far propri discorsi che, ad averli resi più sobri e più centrati sulle esigenze del Premio e sulla cultura del libro – quella cui Levi tra gli altri, ha completamente dedicato genio, esistenza e dolori – avrebbero reso certo un miglior servizio alla serata e agli intervenuti. Perché, a ben guardare, in mezzo al fumo un po’ d’arrosto c’era.
Comunque sia, il problema pressante mi pare essere derivante dalla scarsità oggettiva dei fondi per il Premio a seguito della crisi economica (che, però, non mi pare affluissero abbondanti alla cultura nemmeno ai tempi in cui le vacche erano grasse) e di una questione, quella culturale, anche per il governo Renzi inesorabilmente e “tremontianamente” non prioritaria in agenda. Occasione che spinge i politici di ogni risma a trincerarsi dietro un generico “potremo, vedremo, faremo” confidando in un uditorio ormai ipnotizzato da vent’anni e passa di berlusconismo a stare perennemente con le mezze maniche estive invece che con il vecchio maglione di lana di nonno Enrico Berlinguer.
Un altro problema verte, invece, su come meglio veicolare i libri premiati – se nelle scuole magari in accordo con gli editori attraverso particolari sconti, solo per fare un esempio banale.
Sono tra quelli che, pur auspicando più provvidenze di legge (e meno scellerate) a sostegno dell’editoria, vanno da anni ripetendo la formula – diciamo così – “concordataria” riassumibile nella formula: “libera istituzione in libera editoria”. Perché se una Regione si costituisce essa stessa come editrice allo stesso tempo facendosi sostenitrice economica della locale editoria, va da sé che la scelta abbisogni di una concertazione massimamente chiara per non creare inevitabili conflitti tra le parti o, peggio, esiziali “infiltrazioni”. Sarebbe cioè preferibile un sostegno “a valle” e mirato al sostegno dell’acquisto, diffusione e lettura del libro, tra cui, spiccherebbe un appoggio più deciso alle librerie (o di ciò che ne resta) sul territorio.
Mi pare Lacorazza abbia accennato (e occorrerebbe rifletterci meglio) a un punto importante: cosa può fare la politica perché gli intellettuali lucani possano frequentarsi e – se fuori – ritornare più spesso in Lucania attirati da momenti di più frequente elaborazione e proposta culturale? A mio avviso, lo dico convinto a Lacorazza, poco servono nuove riviste così come nuovi cenacoli dell’autoreferenzialità. Servono, invece, momenti di confronto aperti tra vari attori della cultura (pittori e poeti, fotografi e critici o saggisti ecc.) e di questi con la gente lucana. Come si può fare, allora, se non con incentivi a circoli e librerie meritevoli, se non con un adeguato sostegno alla lettura scolastica e giovanile?
E perché le scuole? La Basilicata è tra le ultime regioni in tutte le classifiche nazionali per la lettura dei libri, anche grazie alla forbice negativa tra istruzione e reddito medio regionale. Dunque gli investimenti – che chi di dovere dovrebbe fare – possono lasciare una traccia duratura quasi solo nella fascia di lettori oggi potenziale: i preadolescenti e gli adolescenti (chi ha la mia età ormai se non legge già ora, difficile sviluppi il tarlo). E devono essere investimenti non solo dedicati all’acquisto del libro in quanto tale, ma alla sua lettura. I salotti buoni delle famiglie lucane sono già piene di enciclopedie e altre opere acquistate nei ’70 e quasi mai sfogliate; e, allora? siamo punto e a capo. Altre idee possono essere le visite alle fiere, l’uso mirato di internet, piccoli corsi sull’editoria e sulla lettura, premi per i più piccoli, incontro con scrittori ed editori, incontri con giornalisti ed edicolanti per meglio capire la lavorazione di certe filiere, con i restauratori di opere antiche ecc ecc.
Insomma, non si tratta solo di acquistare un libro, ma di giungere alla consapevolezza che il libro è uno strumento teorico-tecnico per imparare o un modo per accedere a una qualche notizia del mondo, a un’esperienza di vita che possa renderci meno provinciali. È questo che fa, oggi, anche il premio Levi che, come ha detto il sindaco di Matera Adduce, potrebbe entrare in una fase propulsiva virtuosa se la sua città riuscirà a proporsi come Capitale culturale d’Europa capacedi scambio intellettuale proficuo con l’intero territorio su cui poggia.
Fin qui, luci e ombre della politica. Ma la crisi italiana è crisi non solo politica, e mostra i limiti e l’inadeguatezza di un’intera classe manageriale e dirigente. E dunque anche imprenditoriale, bancaria, del management regionale. Una classe dirigente incapace di pensare a uno spazio pubblico che non sia né contrapposizione né commistione tra stato e privato, bensì terreno neutro – sia pur non neutrale nell’impegno – di collaborazione, scambio, crescita tra parti.
Sono stato recentemente al “Festivaletteratura” a Mantova: nella brochure di invito tante sigle di banche e investitori piccoli e grandi che si sono impegnati, anche senza un ritorno economico immediato, nella riuscita organizzativa dell’evento. Certo territori ricchi, ma noi parliamo di una piccola eccellenza realizzata in una terra di bellezza sconvolta e sconvolgente, che porta il nome di uno scrittore tra i più grandi del Novecento! Un premio di caratura e di ulteriore potenzialità nazionale e internazionale che ha già dimostrato, con le sue diciassette stagioni, di stare più che bene in piedi.
E dunque, lo dico qui con un termine toscano, che qualcuno “si frughi”. Ma ci sta che le compagnie di autobus per il trasporto delle scuole (faccio solo un esempio) o le banche, pur intenzionate, abbiano trovato nelle tasche ricci di castagno. Eppure, se il territorio non si promuove, non si sostiene anche nella sua crescita culturale, mi chiedo, quale possibile o ulteriore sviluppo può avere?
La Notte Europea dei Ricercatori è Made in Lucania
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», domenica 12 ottobre 2014.
_____________
Lucani che si confermano. Vale a dire Francesco Larocca, lagonegrese, oggi docente di scienze dell’Istituto Salesiano Villa Sora a Frascati (Roma) e vicepreside di quel Liceo Scientifico; soprattutto instancabile mediatore culturale: una figura, quest’ultima, di cui oggi in Italia c’è disperato bisogno. Iniziò, nel febbraio 2012, con l’acquisto di quattro telescopi, attorno al quale aggregò il gruppo di astrofili “Segui la Stella”. Un’associazione che oggi alterna anche incontri con personalità del mondo scientifico e sessioni d’osservazione dello spazio.
Così, anche quest’anno, l’istituto è stata autorevole sede della “Notte dei Ricercatori” e partner di “Frascati Scienza”, un’organizzazione costituita da tremila scienziati, otto istituti e ben tre università. A cominciare dal 25 settembre, per finire il 27, offrendo un programma davvero ricchissimo, mossosi tra sessioni di osservazioni dello spazio tenute da Gianluca Masi, del locale osservatorio “La Torretta”, mostre fotografiche su “Il lavoro dell’uomo e la natura” (foto e allestimento realizzati dai fratelli Angelo e Francesco Larocca), percorsi didattici, sbandieratori teatrali di Borgo Spante e, più in evidenza, conferenze. Queste ultime a partire da quella di Roberto Somma (dirigente di Thales Alenia Space Italia) sull’osservazione della Terra dallo spazio come strumento a supporto della sostenibilità del Pianeta; per continuare con quella accattivante del biologo marino Luciano Bernardo, che ha parlato dell’importanza dell’osservazione diretta nella sua disciplina, a partire dai tesori lasciati a riva dalle onde; fino a quella sui “Nuclei fondanti dell’apprendimento significativo”, lectio dello psicoterapeuta dell’Università di Tor Vergata Filippo Pergola.
A chiudere, il 27 settembre, le giornate – ormai lo si sarà compreso, virate sui temi dell’ecologia come scienza e sulla correlata sostenibilità planetaria – Salvatore Curcuruto, dirigente dell’ISPRA, sulle nuove tecnologie di illuminazione urbana LED e il loro impatto ambientale.
Tuttavia, anche quest’anno, mattatore dell’incontro, il 26 settembre, è stato senza dubbio Davide Giacalone (opinionista per RTL e di “Libero”) che, in anteprima sull’uscita in libreria a ottobre, ha presentato la sua ultima fatica “Senza paura. Per non perdere il bello di un mondo migliore” stampata per i tipi della Rubbettino (pagg. 296, 15.00 €). Tanto in anticipo, grazie alla tempestività di Larocca, da essere presentato allo stesso autore prima che l’editore riuscisse a fargliene avere copia.
Il libro, nato un po’ per caso a partire da considerazioni empiriche sulle conseguenze psicologiche della crisi economica ancora in atto sugli italiani, parte dalla ragionevole constatazione che “Scansati i tempi paurosi” del passato “ne abbiamo creati di impauriti” di cui la radice è “l’aspettativa che le cose possano andare peggio di come sono andate e di come vanno”, soprattutto per i figli. Una paura tale da cogliere, perché osservatore necessariamente coinvolto, anche il nostro autore sia pure, però, in un senso totalmente positivo se essa “salva la vita” facendoti “avvertire il pericolo, mentre la perde e rovina se induce a un tremore paralizzante” o trasformandosi in rabbia sociale. Di fronte a ciò, secondo Giacalone, bisognerebbe fermarsi a ragionare per essere più consapevoli.
Tuttavia, mentre la conferenza di presentazione a Villa Sora ha girato intorno a tematiche parecchio spinose, pure dal punto di vista del diritto, ma più circoscritte (ogm, eterologa ecc.) e in difesa della scienza dal pregiudizio e dall’accusa di nutrire appetiti faustiani sul nostro mondo, in realtà le pagine del libro aprono a problematiche ben più ampie, dall’economia e dalle politiche fiscali fino alla famiglia e al “declino del maschio”, dal problema immigrazione ai fondamentalismi (ben presenti anche in occidente) alla sovranità europea. Per esortarci ad aver la fibra di andare, seguendo una via pragmatica di ritorno alla realtà e di consapevolezza delle difficoltà, oltre i vuoti ottimismi o i facili, persino interessati, pessimismi. Certi che di fronte agli sconquassi della crisi che andiamo attraversando: “non ci aspetta il cilicio, per redimerci dal peccato, non è auspicabile alcuna stagione penitenziale. Ma neanche ci aspetta un’interminabile ‘happy hour’, nell’incoscienza dell’inutilità. E fortunatamente, perché la pausa, senza il precedente e successivo impegno produttivo, finisce con il somigliare orrendamente al vuoto”. Insomma, commentando Croce, scegliendo uomini sì onesti e integri, ma pure preferendoli “per capacità e forza realizzativa, altrimenti la vita collettiva si corrompe nella stagnazione e degenera nel declino. Che, se anche onesto, è ben gramo destino”.
“Messo a tacere”: Quel Mundtot tra musica e impegno civile. Intervista a Marco Lenzi
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», domenica 24 agosto 2014.
_____________
In Calabria, si sa, la ruggine non la fa l’acqua, ma le uova. E così, nel febbraio di un ormai lontano 1991, a un gruppo di giovani viene l’idea di lanciarne alcune su un circolino. È carnevale e la burla, pur sopra le righe, potrebbe finire là. Ma siamo nel reggino, nel comune di San Luca, e qua le cose tutti sanno come iniziano, ma nessuno può dire come vanno a finire. Un uovo colpisce la macchina sbagliata e nasce un litigio con tanto di spedizioni punitive. Durante una di queste ultime, un giovane aggredito si “spagna” e spara, uccidendo due persone e ferendone altrettante. E, di lì a poco, finisce per fare la stessa fine.
La Calabria, si sa, è un paradiso dove i diavoli sono di casa. E ci sono le ’ndrine, tra le quali il litigio deflagra: quella dei Pelle-Vottari e quella dei Nirta-Strangio. Dunque 1991, 1993, e poi 2005, 2006, 2007. Gennaio, agosto, persino a Natale: non c’è mese, non c’è giorno, non c’è luogo (San Luca, Casignana, Bovalino) che non possa essere quello buono. I conti si saldano. Affiliati, parenti, amici. Paga a chi tocca. Se non fosse che quello della ’ndrangheta è un mondo capovolto e sempre finisce che, al momento del saldo, il debito, invece di chiudersi, s’allarga.
La Calabria, si sa, è terra che alla storia bada poco, e però ha memoria radicale delle offese. Si chiama “faida”. Un termine, “fēhida”, che ha viaggiato nel tempo e nello spazio prima di avvelenare questa terra meridiana. Una radice alto tedesca, “fēh”, “nemico”, che già nella pronuncia ha l’urgenza di colpire: un’empia violenza che il diritto germanico cercò subito di mitigare. Tuttavia, le ’ndrine son caparbie, hanno saputo rendere la pratica alla sua antica, nuda ferocia. Riportandola ai suoi antichi inventori quando ormai non la conoscono più e ne sono indifesi.
Il “regalo” arriva a ferragosto a Duisburg, grosso centro nella Renania settentrionale-Vestfalia, all’uscita, pare, da una cena di compleanno consumata al ristorante “Da Bruno”. Fa sei morti con nessun risparmio di proiettili. La Germania si risveglia incredula di fronte a fenomeno che gli par nuovo, ma che i locali inquirenti già conoscono pur non concedendone spiegazioni.
Di tutto questo si accorge Jürgen Alberts, scrittore di gialli che, per i suoi libri, si è già occupato di crimine organizzato e di triadi cinesi. E come tutti, più di tutti, rimane scosso dalla strage. È allora che si convince a indagare meglio, incuriosito da un paio di articoli pubblicati in Italia che riportano le confessioni di Giorgio Basile sui riti di affiliazione alle mafie. E si tuffa in una ricerca che lo cambia.
Scrive Alberts: “Quando progettai di scrivere il mio libretto per ‘Mundtot’ – ‘Messo a tacere’ – dovevo trovare inizialmente una forma per una semplice ‘pièce’ teatrale – che si configurò come un processo giudiziario nel quale il testimone ‘canta’ e solleva il velo che copre il crimine organizzato”. Alberts legge “Gomorra”, si chiede come le mafie riescano a far soldi con i rifiuti (nel testo sono citati anche seicento barili di rifiuti tossici che la mafia avrebbe “smaltito” in Basilicata), quale sia il legame con la società civile, la loro capacità di resistenza alle intrusioni esterne. E, con un linguaggio semplice e diretto, “perché la gravità dei suoi contenuti è tale da non consentire al pubblico di venir distratto da esperimenti formali”, rivela alla Germania quanto pure la società tedesca possa essere permeabile alle mafie. E a noi come i tedeschi ci guardano.
Capita che a musicare il libretto sia chiamato un livornese, Marco Lenzi, che resta colpito dal testo, che nulla concede alla retorica e al compiacimento lirico nel racconto dialogato in dodici arie chiuse o “canti”. Pur nel sarcasmo cui spinge la denuncia morale. Musica che mai soffoca il testo, molto ben adattandosi, tra l’altro, alla cultura teatrale e al cabaret espressionista tedeschi, e impregnata di colonne sonore, di rock e di psichedelico o di moduli espressivi musicali ripresi dalla folk song, dal Lied (“Canzone tedesca”), dal rap, alternando canto, “Sprechgesang” (“canto parlato”) e voce recitante.
In Germania, la rappresentazione di “Mundtot” riscuote buona eco. Arnsberg, Bremen. E tuttavia accade che, in Italia, il testo non sia stato ancora rappresentato. Perché? Mistero. Che proviamo a dipanare proprio con Marco Lenzi, classe 1967, musicologo che ha al suo attivo diversi saggi e la prima monografia italiana su Morton Feldman. Le sue composizioni sono stati eseguite in Europa e Stati Uniti.
Inizio subito con la domanda che ti aspetti: chi ti ha contattato per questo lavoro e perché?
Dunque il lavoro ha avuto una lunga gestazione, conclusasi solo nel 2012. La prima telefonata la ricevetti, invece, nell’estate del 2008 da un carissimo amico livornese emigrato e che ha girato mezzo mondo prima di stabilirsi in Germania: Alessandro Amoretti, pianista compositore, collaboratore di enti lirici. Alessandro mi chiese se fossi stato disposto a musicare un libretto operistico, “Mundtot”, firmato da Jürgen Alberts, figura poliedrica di scrittore. Avrei dovuto scrivere l’opera per il 2010, anno dedicato alla cultura europea nella Ruhr; ma subito un rap (che poi è diventato la quarta aria dell’opera) perché potesse essere rappresentato a un festival del crimine a Unna (i “Krimifestival” sono là molto sentiti e coinvolgono artisti di varia estrazione). Dopo questa rappresentazione iniziai a scrivere mano a mano le altre musiche del libretto nelle sue successive versioni, anche perché i tempi erano, nel frattempo, slittati. E così la prima dell’opera fu rappresentata nel 2012.
Ti sei fatta un’idea di come guardino i tedeschi al fenomeno mafioso in relazione all’Italia a seguito della strage di Duisburg? Perché nell’opera non c’è solo uno sguardo fosco, ma anche punti e personaggi positivi: il PM, la “Baronessa coraggiosa”, la memoria di Fortugno…
Sì, è vero, è crollato un po’ questo castello folkloristico della mafia e del crimine organizzato italiano come nota locale, forse risibile, di colore. Dopo i fatti di Duisburg lo sconcerto è stato grande, così come il clamore suscitato. Non era più una questione di pizzo e questioni tra famiglie italiane. Sulla strada, davanti a tutti, c’erano morti ammazzati in tutta la loro tragicità. È venuta meno pure una certa idea di Germania, scopertasi più fragile, meno pronta ad affrontare certi episodi: la prima vibrata reazione alla strage fu quella degli italo-tedeschi.
A questo punto viene data la prima ad Arnsberg con ottima affluenza di pubblico.
La sala era piena. Curiosamente la rappresentazione è stata data in un tribunale, anche a scapito della capienza, problema cui si è sopperito dando ben due spettacoli in un giorno. Ma tutto questo ha restituito alla fine un effetto verità molto forte, rilevato tra l’altro dalla stampa, nonostante lì fossero state utilizzate solo basi musicali. A Brema, invece, l’opera è stata data in un teatro di prosa. Era chiaro che per quest’opera servissero cantanti attori e non cantanti lirici. Furono scelti quelli bravissimi, della Compagnia shakespeariana di Brema, con protagonista un italo-tedesco di Colonia Luca Zamperoni, che ha collaborato anche con Bob Wilson. Comunque sia, con pochi personaggi di un processo che recitano queste dodici arie chiuse, la forma è diventata più una musica di scena che un’opera. La sfida futura sarà quella di dare alla musica più peso, cioè con i dodici momenti messi maggiormente in evidenza e con il cantato a essere interrotto poche volte dal parlato.
Che riscontri hai avuto in Italia dopo la rappresentazione dell’opera?
Beh, l’opera è piaciuta molto, tanto da riscuotere il plauso di un Bob Wilson. Intanto un bravo regista livornese che è Emanuele Gamba pure l’ha ascoltata e si è dato molto da fare per diffonderla, ultimamente inviandola al Direttore artistico del Comunale di Bologna Nicola Sani, che però non ci ha ancora dato risposta. Sempre grazie ad Emanuele siamo andati vicino alla rappresentazione teatrale con attori del genere di Claudio Santamaria e Beppe Fiorello. Un altro amico l’ha fatta girare in Trentino. Però in Italia, a queste premesse entusiastiche, nulla è seguito. Pur ponendo mente al fatto che i budget per la rappresentazione sono davvero risibili e il testo è ispirato a tematiche forti. Forse ha giocato, tra le altre cose, la mia inesperienza (questa è stata la mia prima opera) o il mio scarso peso “politico” nel sistema dei teatri.
E nella tua città, a Livorno?
A Livorno la situazione è stata paradossale, perché il “Goldoni” sembrava davvero interessato alla cosa, potendo così “sdoganare” l’opera in Italia. La cosa buffa è stata che, all’entusiasmo iniziale, sono seguite richieste di riduzioni progressive dell’organico e continui aggiustamenti di budget. Mi resi disponibile a riorchestrare l’opera per cinque tastiere, dunque per cifre irrisorie, ma nonostante ciò mi fu proposto prima di spostare tutto alla “Goldonetta” e, infine, addirittura mi fu proposto di rappresentare “Mundtot” in quella che mi venne indicata come la “sala specchi” che era, in realtà, la sala prove del teatro, poco più di uno spogliatoio seminterrato.
La motivazione?
Perché avrebbe accentuato il carattere di modernità, indipendenza e eccezionalità dell’opera rispetto a quelle più “classiche” in calendario. Un delirio, per un unico atto di un’ora.
E a Sud, dove i tentativi per una rappresentazione di “Mundtot” potrebbero trovare alla stessa maniera entusiasmi o qualche complicazione in più?
Sarei molto contento se il Sud potesse dare una risposta diversa, positiva a quella che mi è stata data fin qui (dove qualcuno pensa che, in fondo, una certa parte dell’Italia dalla ’ndrangheta possa essere, forse, immune). Sono disposto a realizzare l’opera traducendo il libretto e adattandolo meglio al gusto italiano.
Per me, quella di Mundtot, è stata un’esperienza formativa, perché da compositore non mi ero mai misurato con i fatti della criminalità organizzata e, su un altro piano, con la forma canzone. L’opera mi ha consentito di allontanarmi dai registri sperimentali marcati che mi erano soliti; qua invece ho usato di tutto. Forse il modello inconscio più forte è stato quello dei Pink Floyd, il finale di “The Wall”, insomma, tirando fuori dei temi culturali che mi erano cari, ma che non erano mai entrati nella mia musica. È stato un lavoro che ha messo alla prova il mio modo di comporre, per la prima volta confrontatosi con temi così forti e concreti.
Ezio Taddei, lo scrittore dei poveri confinato a Bernalda. Oltre 60 anni dopo, il ricordo dell’uomo che cammina.
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 2 febbraio 2014.
_____________
“Nessuno è profeta in Patria”. Vangelo. Destino tanto vero da esser toccato a Livorno, per lunga pezza, perfino allo scrittore Ezio Taddei, nato nel 1895 da famiglia agiata, precoce militante anarchico poi comunista, diseredato dal padre, per anni vittima della repressione fascista, confinato a Bernalda nella seconda metà degli anni ’30, poi profugo a New York dove non tardò a entrare in rotta di collisione con la mafia locale, scrittore dalla vita avventurosa e temeraria più di un Rocambole.
A risarcire in parte la dannazione della memoria toccata allo “scrittore dei poveri” ha provveduto, così, il circolo Arci “Al verde” del comune materano di Bernalda, con la presentazione del libro “L’uomo che cammina” edito, appena lo scorso anno, per i tipi della labronica Erasmo, a cura del prof. Giancarlo Bertoncini. A parlarne il 31 gennaio, una data importante per il comune lucano, è stato Angelo Tataranno, insegnante, militante PCI, assessore alla cultura e sindaco bernaldese fino al 1994, quando passò a occuparsi della Provincia di Matera in qualità di suo presidente. Tataranno già fondatore nel ’78 del Coordinamento Teatrale di Basilicata (CTB), prima associazione tra comuni per la promozione del teatro nella nostra regione; e poi animatore culturale e ricercatore di storia locale.
“Ezio Taddei ha lasciato a Bernalda, nei due anni di confino scontati dal ’36 al ’38, tracce indelebili della sua presenza” ci racconta, appassionato, Angelo. “Nonostante lo stretto controllo cui era sottoposto, riuscì ad integrarsi nella comunità locale stabilendo molte relazioni di amicizia. Cominciò col frequentare intensamente la bottega Vincenzo Dibiase, barbiere, collocata nella via principale del centro storico, che costituiva, in quell’epoca, un vero e proprio ‘circolo culturale’ frequentato da socialisti e qualche anarchico. Non a caso in quella bottega c’era sempre tanta gente, non sempre per servirsi del barbiere, ma per chiacchierare, per scambiarsi informazioni su tutto quello che accadeva in paese, e, spesso, per parlare, con molta circospezione, di politica. Del resto è noto come Bernalda rappresentasse tradizionalmente uno dei punti di più ostinata resistenza al fascismo delle origini, tanto da essere fatta oggetto, proprio il 31 gennaio del 1923, di una vera e propria spedizione punitiva che costò tre morti e una quarantina di feriti. Per quanto, in seguito, si tentasse di minimizzare quella brutta vicenda, nella popolazione più attenta e politicamente attiva se ne trassero analisi relative al fascismo. Nel 1948, l’amministrazione socialcomunista intitolò una piazza ai ‘Martiri del 31 Gennaio’ e, nel 1974, fu dedicata una lapide ai caduti di quella spedizione punitiva organizzata a Potenza dall’allora segretario del fascio, l’avvocato Sansanelli”.
“In quella stessa bottega Taddei ebbe modo di conoscere gli studenti dell’epoca, che frequentavano le scuole superiori a Matera, ottenendo da loro libri e giornali da leggere, e ricambiando con lezioni di greco, latino e matematica. Aver saputo successivamente, dalla sua biografia, che Ezio aveva frequentato, poco e male, solo fino alle elementari fu, dunque, per noi bernaldesi, una sorpresa straordinaria”. Evidentemente, come ha ben scritto Massimo Novelli, in carcere ci si poteva ancora istruire: attingere dagli altri compagni una più viva coscienza politica e, da chi più sapeva, imparare a leggere e scrivere, servendosi di un abbecedario clandestinamente scritto nelle celle, per terra, con torsoli di cavolo imbevuti d’acqua. Prontamente cancellabile, in caso d’ispezione. Domenico Javarone ha del resto rivelato il metodo scarno, ma di tutta efficacia, usato da Taddei con gli studenti bernaldesi: “Il tema è come una persona” gli spiegava “ha la testa, il tronco e le gambe; la testa piccola è l’introduzione, il tronco più grande è lo svolgimento, e le gambe, pure piccole, la chiusura”. Esortava, Taddei: “È così che devi scrivere, seguendo le cose una per volta…”. Faceva leggere Tolstoj e Dostoevskij. Dal canto suo, il livornese leggeva proprio di tutto. Aggiunge, ironico, Tataranno: “una volta, mentre si trovava in piazza Plebiscito, nei pressi del Municipio, e stava leggendo un giornale, un troppo esuberante milite fascista gli si avvicinò, gli strappò il giornale dalle mani e lo schiaffeggiò pubblicamente. Ezio Taddei non reagì. Aspettò che il fascista avesse finito per poi, con calma, chiedergli se sapesse leggere, perché quella volta stava sfogliando “Il Popolo d’Italia”.
Fu pure a Bernalda che Taddei finì per invaghirsi “di una bella ragazza, originaria di Ginosa. La relazione, ovviamente, fu furtiva e nascosta, non solo perché queste erano i costumi del tempo, ma soprattutto perché egli era un ‘forestiero’ e per di più confinato politico. La giovane ricambiò il suo affetto fino a quando suo padre, venuto a sapere della ‘tresca’, proibì in modo categorico alla figlia di continuare a frequentare ‘quell’individuo’! Ezio soffrì molto per questa vicenda, al punto da tentare il suicidio tagliandosi le vene. Fortunatamente l’amico Vincenzo, non avendolo visto a bottega quel pomeriggio, pensò di andare a casa sua, forzando l’ingresso per entrare. Lo trovò, riverso per terra, in una pozza di sangue, e lo soccorse come poté, in gran segreto”.
“In seguito” conclude Tataranno “tornò nel 1949” a Bernalda e a Pisticci, come ricorda lo stesso Taddei nel libro “La fabbrica parla” e come anche confermato da un filmato, oggi disponibile su You Tube (“Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato”, Regia di Carlo Lizzani), che lo ritrae in visita con altri dirigenti politici e sindacali a Matera. “A Bernalda fu accolto con festose manifestazioni di affetto da tutti quegli amici e compagni che aveva conosciuto durante il confino e che, in gran parte, erano diventati i locali amministratori del dopoguerra. Tanto che, nel 1976, l’Amministrazione Comunale gli intitolò una strada che sta ancora lì, a ricordarne il generoso impegno per la nostra gente”. Oggi Angelo Tataranno è al lavoro per ricostruire le vicende di Taddei a Bernalda. Come dire, un altro monumento.
Detto ciò, non ci si può nascondere che, però, recentemente, anche a Livorno, più di qualcosa è stato fatto per recuperare il ritardo della memoria. A partire dal convegno tenutosi lo scorso anno al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e promosso da Comune, Provincia e Istoreco (Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, diretto da Katia Sonetti). Tuttavia, nonostante l’intervento, in quella sede, di importanti studiosi quali David Bidussa e il già citato Bertoncini, e nonostante la successiva pubblicazione di un’ulteriore raccolta di racconti intitolata C’è posta per voi, mr. Brown! (Books & Company, Livorno 2013) qualcosa è parso essersi parzialmente inceppato. L’impressione è che i duri attacchi a Taddei sferrati da un filologo dell’esperienza di Luciano Canfora, accusato di essere, in realtà, al servizio dell’Ovra, abbiano un po’ gelato gli ambienti labronici.
Si potrà tornare sull’argomento, ma per quanto riguarda Bernalda, rimangono forti le parole di Tataranno: “Qui in Basilicata giudichiamo le persone col metro della memoria di persone ancora vive, e per quello che abbiamo visto e vissuto direttamente. Per noi Taddei ha fatto molto, al di là di ogni suo limite personale. E su questo noi siamo chiamati, come comunità, a giudicarlo”. Il che – come ha recentemente ribadito David Bidussa (Fondazione Feltrinelli) in una sua polemica con Paolo Mieli sulla ricostruzione delle vicende del PCI di Ruggero Grieco e su Taddei – fa strame di un certo modo di vedere la storia da un ristretto buco della serratura oltre il quale paranoicamente resterebbero a muoversi esclusivamente i falsi, le spie, i doppiogiochisti.
Quelli che seguono le stelle. Francesco Larocca e i suoi telescopi.
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 24 Ottobre 2013.
_____________
“Lucani nel mondo”, si diceva una volta. Ma anche “in Italia” – o, più in piccolo, nel Lazio – si danno parecchio da fare. Ad esempio Francesco Larocca, oggi a Frascati (Roma) docente di scienze dell’Istituto Salesiano Villa Sora, del quale riveste anche il ruolo di Vicepreside del Liceo Scientifico, ma lagonegrese DOC. Che, nel febbraio 2012, acquisendo ben quattro telescopi, ha avuto l’idea di fondare, con i suoi studenti liceali, il Gruppo Astrofili “Segui la Stella”. Così l’istituto – sollecitato da una didattica per scoperta, dove l’apprendimento sui testi poggia sullo studio diretto sul campo – si è fatto poi carico della ristrutturazione di una torretta con ampia terrazza annessa (già proprietà dei duchi di Sora) che, negli anni Venti del Novecento, era stato edificato appositamente per effettuare osservazioni astronomiche. Ma non basta, perché l’associazione organizza anche incontri con personalità del mondo scientifico quali Gianluca Masi, (astrofisico e curatore scientifico del Planetario di Roma”) o Roberto Somma (legato a Thales Alenia Space Italia), solo per citarne un paio. Ciliegina sulla torta, quest’anno la struttura è stata prestigiosa sede della “Notte dei Ricercatori” progettata da “Frascati Scienza”, un’organizzazione costituita da tremila scienziati, otto istituti e ben tre università.
L’osservatorio è oggi dotato di cinque telescopi specifici, sia per l’osservazione planetaria che per il cielo profondo, e uno esclusivo per il Sole (che rende possibile vedere le granulazioni, le protuberanze, le macchie e i brillamenti della nostra stella) ed è aperto anche alle famiglie degli studenti. Ogni sessione di osservazione è spesso preceduta da conferenze, alcune interessantissime, quali, dal 2012 a oggi, “Missioni spaziali per l’esplorazione di Marte”, “Il Calendario Gregoriano. La riforma moderna del tempo”, “Lo studio della Geografia Astronomica nella Scuola. Come le nuove tecnologie possono rivoluzionare la didattica” e “Il rischio di impatto di asteroidi con la Terra”.
E così, sempre sotto l’egida e l’instancabile attività di Francesco Larocca, il 18 ottobre l’istituto è stato ancora una volta sede di un doppio appuntamento: la presentazione del libro di Davide Giacalone “Rimettiamo in moto l’Italia” (Rubbettino, 2013), e l’incontro con il già citato astrofisico Gianluca Masi, che ha parlato del quadro di Van Gogh “La notte stellata sul Rodano”.
Davide Giacalone è giornalista e opinionista, ma principalmente si occupa di internazionalizzazione delle imprese. Non a caso, il libro nasce dal bisogno di porre finalmente un argine all’autodenigrazione cui di solito si abbandonano gli italiani. In realtà l’Italia è un Paese dal corpo solido e di straordinaria inventiva, ma che gli italiani spesso dimenticano. Il problema è che non essere capaci di risolvere i nostri mali – soprattutto quello di pensare di poter ormai vivere a spese della collettività senza più il gusto della competizione – ci rende incapaci di riconoscere le nostre forze. Così la nostra vita collettiva dà il peggio, soprattutto in politica, con un deficit impressionante di classe dirigente, portando purtroppo il sistema nervoso nazionale vicino al tilt. E tuttavia, la crisi è solo un pezzo della realtà che abbiamo di fronte. Bisogna, invece, avere il coraggio di ritrovarsi; ritrovare quella capacità di navigare in mare aperto che richiede la nuova sfida che la concorrenza globale pone oggi.
Il legame della presentazione vangoghiana con le argomentazioni di Giacalone è stata offerta proprio dalla presenza di Stefano Masi, perché il suo studio, già apparso nel 2007 come un brillante risultato dell’eclettica e versatile creatività italiana, fu particolarmente apprezzato proprio dal Van Gogh National Museum di Amsterdam, in Olanda. Con buona pace anche delle odierne convinzioni su certa limitante divisione dei saperi umanistici e scientifici.
Uno studio, quello su la “La notte stellata sul Rodano”, che ripercorre uno dei temi più in voga in questo primo scorcio di secolo, in ambito artistico e letterario: il rapporto dell’autore con la realtà. Dunque, Van Gogh, allora in Provenza, riproduttore emotivo o dal vero – meglio: dal vivo – del cielo? E con quale consapevolezza astronomica? Ebbene la rappresentazione artistica del Grande Carro sulla tela ha permesso a Masi, in realtà, di stabilire data e orario del gesto pittorico (le 23.15 del 25 settembre). E ciò a differenza di tanta pittura “realistica” più attenta alla riproduzione luminosa del firmamento che alla sua precisa resa spaziale. Il fatto si rivela, così, capace di svelare l’eccezionale passo stilistico dell’artista olandese, perché il Gran Carro, dal luogo dove è dipinto (Arles, verso Sud-Ovest) non può essere nel campo visivo. Dunque, di qui, nuovamente, l’irrompere della potenza desiderante e stravolgente il dato realistico con un paesaggio cui è sovrapposto un cielo altro (come con occhi bifronti già modernissimi e furiosi e ribelli a invertire l’orizzonte, scompaginandone le geometrie), e tuttavia ritenuto l’unico degno di essere rappresentato da Van Gogh come cielo.
Livorno
Questo articolo è stato pubblicato sul «Corriere Nazionale» il 1° febbraio 2012.
_____________
Città d’autore – 20
Le facce di Livorno: il tuo punto di vista la fa plebea o nobile
“Ehi, amico, come va?” abborda sorridente il ragazzone di colore sul lungomare di Livorno, calze di spugna, fazzolettini, un po’ di occhiali in mano. “Dé, s’agguanta!” scivola via il cliente, una mano in tasca, l’altra fuori, in un gesto aperto e netto, a un tempo sincero ed elusivo. “S’agguanta”. Che in livornese sta per “si tiene”, “si prova a non cadere”. Io stesso rimango folgorato dalla scena. Col dubbio se il tipo abbia tirato dritto indifferente agli articoli proposti oppure per non dire che in tasca, spicci, niente.
Livorno va così, oggi non la leggi con la solita chiarezza. E tu spulci una statistica e sembra voli, e poi ne leggi un’altra e ti ritrovi giù di almeno dieci posti. Livorno su, Livorno giù. Livorno che gira la testa, un poco da ricovero, da ottavo padiglione, quello dove, una volta, agli “Spedali Riuniti”, ci tenevano i matti.
Livorno mostra i lati secondo come la guardi. Livorno dei servizi, bene, pare, e pure l’inflazione. Salute, forse ottima, ma su un muro, dell’Asl numero 6, si leggeva: “se la conosci la eviti” e già pareva chiaro che qualcuno, scrivendone, ne volesse lasciare l’esperienza. Una certezza, invece, la Livorno del lavoro. Però nera. Diciamolo, che c’è da interpretare? Trentasei abitanti su cento senza occupazione, o giù di lì. Poco consola che il dato è provinciale. Penso a una generazione buttata via, o che andrà via da sola, negata nel diritto a restare dov’è nata, se vuole, e metterci del suo. Certo come altre, nel resto del Paese. Ma che cambia? È una crisi diversa questa. Non è personale, non ombelicale, non riguarda il numero complessivo – che so? – dei divorzi, dello stress, di un disagio non meglio precisato.
E forse si vorrebbe glissare, far finta di non vedere. Aspettare. Aspettare magari che giunga un colpo di Libeccio, il vento teso che qui ti soffia vigoroso in faccia il mare, ma poi netta il cielo dalle nubi e le strade dai fumi e dalle angosce di ogni santo giorno. Le crisi a volte son così: qualcosa le porta, qualcosa le trascina. Però a dicembre anche il vento ha soffiato a burrasca, impetuoso, cattivo. Ha frustato di onde le terrazze e le rotonde, schiaffeggiato di sassi Viale Italia, la strada che segue la costa e scorre il mare. Scatenato, paziente, ha scartocciato facciate, cartavetrato persiane, piegato segnali, danneggiato le auto, accasciato gli scooter, i mezzi per i quali i livornesi nutrono una venerazione tutta loro.
Come il lupo della favola, il Libeccio ha rovesciato i tetti più deboli, fischiato nelle commessure più lasche. Si è introdotto tra i dubbi, tra le indecisioni di questa città allargandoli, fiaccando l’albero di un’identità politica già stanca, lavorando senza sosta nelle crepe tra l’anima tradizionalmente industriale e commerciale e quella delle velleità turistiche, di porta aperta sulla Toscana. Fino a colpire il cuore pulsante che è il porto, con i suoi lavoratori e il suo vasto entroterra, capace di potenzialità infinite, e però mai del tutto bene espresse, se si pensa a cosa fanno certe volte i genovesi in quella loro buffa città fatta di spalti e di scalette che non ci scommetteresti sopra un soldo.
Un vento che ha soffiato cattivo, ricordavo. Anche sulle navi. Quelle più incaute, quelle che fregandosene della prudenza da tenersi intorno all’area protetta attorno alle secche della Meloria, si sono perse, nel mare a burrasca, duecento fusti di rifiuti tossici. Ora da bonificare per bene e in fretta, per non ridurre un bel pezzo di costa labronica a un posto invivibile per uomini e pesci. Guardo il mare, tornato tranquillo, le navi illuminate al largo, di notte, e penso a una nemesi. Cos’altro può essere se il cargo dei veleni si chiama “Venezia”? Qui è il nome del quartiere figlio delle maestranze venete e di Livorno è il nucleo storico, l’ombelico che diede vita, nel Sei- Settecento, alla città. Un gioco di canali, ponti, magazzini, piccole imbarcazioni e attività tra la Fortezza Vecchia e quella Nuova.
Del resto, oggi, come se non bastasse, i nervi cittadini sono scossi anche per l’incredibile incidente accaduto giorni or sono, a pochi metri dall’isola del Giglio. Che poi è Grosseto – e potrebbe interessare meno – ma che è tale da sollecitare invece i ricordi delle fiamme, ora più rugginosi e lividi, del “Moby Prince” nei pressi della costa. Era il 10 aprile 1991, ma è restata una ferita mai rimarginata. Una storia dove, peraltro, a differenza della “Costa Concordia”, tutti i passeggeri si consumarono in un istante. Un fiammifero fregato, bruciato insieme alle responsabilità del disastro. “S’agguanta”, però, si diceva, e qualche volta davvero si dimentica. O ci si prova. Perché Livorno guarda al mare, ma spesso abbassa gli occhi sulla costa. Il che parrebbe uguale, ma non tanto. A volte prendo la piccola funivia, il giocattolo che porta al santuario di Montenero, nel bisogno che mi prende ogni tanto di cogliere la città dall’alto, tutt’intera. Da qui, osservando Livorno alle spalle, l’impressione che la città si ammassi, che corra, anzi, a schiacciarsi sulla costa. Ogni singola casa, frenetica, corre. E tutte assieme, come i Lemming. Tutte di là, a precipizio. Un volo d’auto alla Gassman nella celebre pellicola “Il sorpasso”. Del resto, per quanto spazi, l’occhio del livornese, ben presto s’incaglia in quel volto di donna che è l’isola Gorgona. Oggi un carcere, come una volta Capraia. E, ancora, nel profilo della vicina Elba, o in uno scorcio seghettato che pare salito dal nulla dell’inverno, che è il “dito” che fa la Corsica indicando la Liguria e poi la Francia, ma più malvolentieri.
I labronici sono legati a questa linea di costa, al mistero della sua pietra rosso o giallo ocra, di tela macchiaiola. Un bisogno forte come un approdo se d’estate, la piccola flotta di barche, barchette, gommoni, gozzi e fuori-bordo che la domenica, dopo una muscolare sgassata che alza più acqua di quanta non ne solchi, è raro che si apra al mare largo, preferendo in gruppo ancorare attorno all’antica torre della Meloria. Una piccola Livorno fuori porto.
La costa è sole e aria, soprattutto in inverni miti come questo. Un sole che intenerisce la stizza dell’inverno. Un’aria ottimista, “eterno fior di mare” se anche Carlo Coccioli ne coglieva, insieme alla città, il nesso più profondo: “Oh Livorno Livorno, miracolo di vita, e di saggezza amara. Dipenderà dall’aria, ma, se non l’assassinano, è raro che qui la gente muoia. E chi vive è troppo vivo per non sfiorare, dimenandosi, le soglie della ridente pazzia”. Ma era il ’71. E oggi son tempi più prosaici persino della penna maledetta di Curzio Malaparte. Così, sdraiati sulla spiaggia, si prova a celiare, ma non più di tanto, usando le parole del comico Migone. “Meglio disoccupati a Livorno, che ingegneri a Milano”. E via esorcizzando, ché ormai in gran parte la città s’appoggia alle pensioni, sperando reggano un istante in più della crisi anche quelle.
Insomma, arrostire sulla spiaggia come granchi. Ingrediente importante di quel kit dell’edonismo casereccio, di quell’arte di apparire che a volte ai labronici prende un poco la mano, eccessiva: certe signore tirate, col tacco dodici anche per il mercato rionale; certi maschietti palestrati e stra- vestiti (altrimenti, giuste eccezioni che confermano la regola, inguaribilmente sciatti). E supertatuati dappertutto, manco fossero pirati da Caienna (Livorno è pazza del tattoo). Fino al contrappasso, e al contraccolpo estetico. Eccolo allora, il ”trottatoio” serale sul lungomare, sulla terrazza Mascagni o la Rotonda dell’Ardenza, dove fa fresco e si arieggia tra baracchine e giostre, tra tamerici e lecci. E i turisti, invece, appena scaricati dai traghetti, si aggirano accaldati per Via Grande, i negozi tutti chiusi che è una pena, con la faccia un po’ perplessa, ché gli pare che qualcosa d’importante della vita stia sfuggendo, mentre appena più in là, negli storici bagni cittadini, l’immancabile rito d’elezione della miss si consuma. Come in certi film di Virzì, ma struggenti un poco meno. O forse sì, a guardar meglio, ché apparire un po’ chiassosi, a scordare aiuta.
Lo dico. Livorno non è tutta così. C’è una città diversa, più impegnata, meno esibita. C’è una città che ci dà sotto sodo, che sa stare al pezzo, che sa tenere il punto. E l’associazionismo, un volontariato ancora forti; più in generale un’empatia per l’altro e i suoi bisogni del tutto alternativa ai pisani ghiacci, ai sussieghi fiorentini, al secessionismo contradaiolo dei senesi. Anche se certe volte è come la città insistesse a imporsi prima stereotipa, compiaciuta dei difetti suoi. Invece che fiera, forte, capace, come è la Livorno che meno ti aspetti, che ti sorprende, ma più ha bisogno di essere cercata per mostrarsi. Potenzialità lasciate spesso appese, scoordinate o messe in fuga, eppure dalle quali ripartire se è vero che per scienza, pittura, musica, fotografia, prosa, poesia ha un Novecento di certo molto più moderno, ricco e vivace di tante più blasonate città, anche toscane. Ma “Moneta cattiva scaccia moneta buona”, è l’andante di certi economisti. O almeno, la moneta cattiva, ci prova. E dunque le baracchine sul lungomare casiniste, le vinerie, anzi, i wine- bar (noblesse oblige), della Venezia e della “ribotta” a oltranza, le discussioni etiliche fino alle quattro del mattino. Gli insulti, le minacce da gorilla o qualche breve zuffa o forte bercio. Sarà la primavera, l’estate, il testosterone? Chissà. Ma “vivi-e-lascia-vivere”, poi ti esortano, “è la Movida!”. E a dirti questa cosa provinciale è poi il solito che sulle Ramblas (quelle vere) non ci ha mai messo naso.
“S’agguanta”. Ma allora ci sarà la crisi, o no? no e sì, mi dico, se guardo a certo tenore di vita troppo alto, un po’ sospetto, di una città troppo innamorata del facile guadagno (e della spesa). E sì, poi no, se guardo a tutto il resto, a chi lavora per sé, o per il prossimo. Sulla terrazza giro le spalle al mare. Guardo i bei palazzi d’epoca, le nuove costruzioni spesso stonate col contesto. Rido (e non dovrei) riflettendo che Livorno è stata una delle città più colpite della seconda guerra mondiale. Ma è che ogni volta mi viene in mente la battuta di un amico un po’ pungente, per cui è vero sì – mi dice – ma hanno continuato a bombardarla pure dopo. Torno serio, ricordo le tonnellate di rovine viste in decine di foto d’epoca. Il porto sfatto, la città un buco nel terreno. La fame di case da tirar su in fretta, l’esigenza di costruire quartieri nuovi. Mi chiedo come avranno fatto a ritirarsi su. Però la notte ormai alle spalle, il sole in fronte.
E pure questa crisi di Livorno, penso, più va avanti, più pare un incruento dopoguerra, le case tutte in piedi, ma nient’altro, più o meno. Che solo quattro anni fa era diverso, o quanto meno si tirava a campare. Ma poi che passerà. Che i valori economici importano, che i soldi mordono il sonno e molestano i pensieri, ma lasciano alle volte un buco, un varco, alla città. Guardo un gruppo di ragazzi. Forse amici che si incontrano, si abbracciano e poi ridono. Però non mi consolo. Mi è difficile capire a che punto sia la notte. E oggi proprio non riesco a collocare il sole.
Lettera al Quotidiano della Basilicata
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 10 Ottobre 2011.
_____________
Nuova classe di amministratori per i piccoli comuni lucani
Di recente si sono susseguiti una serie di interventi sull’adeguatezza della politica e della classe dirigente lucana chiamata a innalzare i propri standard di intervento o a chiudere con certo disdoro un ciclo politico, rimettendo in tal maniera ai soliti noti il saldo salato dei costi di una crisi epocale. Dico classe dirigente in senso lato, considerato il clima di ulteriore sfiducia ingenerata nel cittadino lucano da avvenimenti sul genere dello scandalo Fenice, già divenuto il classico ginepraio fatto di omertà, scarichi di responsabilità e incompetenze di cui ogni giorno leggiamo.
Certo, in questo clima, è difficile prevedere se un certo mondo politico riuscirà ad autorigenerarsi (in mancanza d’altro all’orizzonte), come si attende Di Consoli, oppure, come auspica D’Agostino, saprà spiegare, con l’aiuto di un manipolo di impavidi, la tormentina necessaria per navigare il mare tempestoso della crisi (e desistendo, dunque, dalla distribuzione di incarichi a marinai più adatti a noiose e autoreferenziali bonacce portuali).
Però non vorrei, restando in metafora, che tenendo sotto controllo la cattiva circolazione arteriosa del malato, lo si perdesse per non aver badato a quella venosa, magari nel frattempo altrettanto bloccata. Una circolazione, quest’ultima, costruita sugli stretti rapporti tra società, amministrazione e politica in quella che è la Basilicata diffusa e dispersa dei medi e piccoli comuni.
Comuni che ci hanno dato prove di virtù civilmente battagliere, come fu per Scansano nel 2003 e per Rapolla e Melfi fino all’anno successivo. Ma pure contraddizioni socialmente scioccanti, come certi risultati comunali dell’ultimo referendum su nucleare e acqua pubblica o certe acquiescenze rispetto ai guasti ecologici portati dalle trivellazioni. Luci accese, luci spente. È dalla fine delle Guerre Sannitiche che il lucano non sa ancora decidersi per le furie guerriere o per la (troppa) pazienza contadina. E a volte, un mese prima del confronto elettorale, il basilisco si agita come una bambola spiritata, per poi (come se avesse un tasto nascosto) abbandonarsi al sonno fino alla successiva tornata.
Insomma, non si può che auspicare, per usare le parole di D’Agostino, che la tormentina abbiano il coraggio di aprirla anche i lucani. Recuperando, cioè, uno spirito modernamente battagliero di una società altrimenti latitante e l’apertura a un nuovo atteggiamento di vigile attenzione alla dimensione politica. Magari smettendo di pensare che in una situazione nazionale e internazionale come questa ci si possa limitare a lasciare la nave in balìa del mare, vale a dire tirando la quotidiana carretta, tentando di sopravvivere nel proprio piccolo. Invece la politica e l’amministrazione vanno ben scosse. Il voto è necessario, ma non sufficiente.
Ed è la società lucana che deve dire a se stessa, finalmente con verità, se abbia lasciato crescere una classe dirigente locale spesso inadeguata e incompetente purché foraggiasse inconfessati appetiti individualistici e calcoli familistici. Oppure se non sia altrimenti capace di esprimere dal suo interno una qualsiasi nuova dirigenza. E dunque se, nel primo caso, voglia darsi ancora una speranza rispetto alle onde che arrivano ormai a squassare il ponte o, nel secondo caso, alzare le spalle e ascoltare ancora per un poco i musicisti sul Titanic. Io credo che, dopo i dovuti mea culpa, l’asticella la si possa alzare. Penso che la società lucana possa pretendere da sé un po’ meglio, partorendo una classe politica finalmente diversa, che non sia l’area di parcheggio per trombati o incapaci di risolvere la vita altrimenti. È una cosa difficile, richiede del tempo, ma per fortuna non siamo in una sfera di immutabilità antropologica, ma in quella della stortura storica. Dunque emendabile.
E amministrare un comune non è per nulla facile, è noto. Ma vale ancora la pena di mantenere la barra su rapporti socio-politici che sono, nel migliore dei casi, la soddisfazione di un famulo, l’elargizione di una pensione, un pezzo di acquedotto, un lavoro di rifacimento? Altrimenti discariche a cielo aperto, buchi di bilancio paurosi, malversazioni di ogni tipo, giunte nate per continuare a coprire i dissesti di quelle precedenti.
Che questo genere di inadeguatezze, poi, fossero strutturali alla maggioranza della classe politica locale (salvo eccezioni) lo si è paradossalmente capito proprio con quei comuni che, invece, hanno potuto beneficiare di insperati maggiori introiti o possibilità di sviluppo e dove le risorse si sono sovente rivelate superiori alla quantità e alla qualità delle idee.
Va ovviamente compreso perché è stato così. E mi pare che si sia abbandonata troppo decisamente la vecchia, sana abitudine del meridionalismo classico di guardare e giudicare il contesto con strumenti socio-politici, piuttosto che esclusivamente economicistici.
Un’impostazione, quest’ultima che, riducendosi a considerare il Mezzogiorno una variabile dipendente da movimenti e decisioni economiche di natura esclusivamente esterna, contò di conseguenza su un intervento straordinario (fino al ’92) nel tentativo di innescare un qualche ciclo virtuoso di crescita. Invece, oltre agli innegabili risultati – e sapendo che anche ora dagli attuali frangenti la Lucania non può uscirsene da sola – si favorirono pure formidabili anticorpi proprio allo sviluppo infrastrutturale locale, rinforzando il pervertimento e la pervasività della politica nella società e foraggiando un ceto culturalmente povero, specializzato, più che a ben amministrare, ad accompagnare, controllare e gestire il flusso di danaro dal centro alla periferia (ovviamente con flussi diventati gocce). Come scriveva Trigilia: “qui più che altrove i politici hanno goduto di tanto consenso ma di poca legittimazione; hanno avuto cioè un consenso basato sulla capacità di soddisfare continuamente domande particolaristiche più che un consenso fondato su identità allargate e valori condivisi”. Insomma, “non avendo un consenso di tipo ideologico alle spalle, la classe politica locale” a ogni livello “ha usato tali risorse per interventi particolaristici e clientelari”. Tutto ciò con pesanti ricadute sulle comunità locali, rafforzandone, in un quadro di arretratezza economico-culturale, una storica tendenza alla questua, alla richiesta più o meno risolutiva della propria condizione individualistica o familiare (prova ne sia che, sia pure in un quadro di sviluppo debole e con una scarsa fornitura di servizi, il reddito medio e i consumi aumentarono). Ovviamente nell’incapacità comune di società e politica di andare oltre lo stimolo pavloviano, di immaginare mondi più progressivi e vivibili qualitativamente, magari affrontando per tempo i problemi con criterio, interessandosene con coraggio, abbandonando i vincoli costrittivi di comunità ma pure trasformandoli in valori e solidarietà condivisi.
E ora che i nodi inerenti un possibile decentramento amministrativo non si sono sciolti, ma anzi avvitati su se stessi non sostenendo adeguatamente uno sviluppo di forze endogene che promuovano scelte economiche positive? Ora che una crisi internazionale di proporzioni bibliche sottrae fondi e impone tagli dal centro rendendo la casta politica sempre più nervosa, sempre più tentata di rinchiudersi dentro le torri dell’autoreferenzialità e del privilegio? Ora che siamo di fronte a una costrizione della spesa senza rilanci produttivi e dei consumi?
Chi non si sentirebbe i piedi slittare nel vuoto? Tutto vero. Pure si abdicherebbe alla politica se, non si capisse che questa anomala condizione porta con sé anche inaspettate opportunità. E cioè che venga innanzitutto fuori una società locale capace di imporre alla politica uno scatto, ma anche capace di controllarne i passi.
Questo coraggio, oggi, è possibile. Basti guardare, ad esempio, a quegli spezzoni di società civile quali associazioni e movimenti che si sono impegnati a fondo nell’ultima tornata referendaria, molto di più di tanti esponenti e militanti dei tradizionali partiti politici. E, chi era a Grassano giorni fa, mi pare abbia ben registrato, con Di Consoli, l’esigenza profonda di “più società, meno politica”. Il che equivale a dire meno palazzo. Ci sarebbe bisogno, infatti, di una nuova classe di amministratori. Onesti non basta (l’onestà è solo il palleggio). Invece capaci di visioni disinteressate, capaci capire soprattutto i bisogni inespressi di una società, capaci di capire dove portare con passione una terra, di progettarla con rigore in uno sguardo che incateni il quotidiano al disegno complessivo. E poi ci sarebbe bisogno di una società capace di guardare al di là del proprio naso, che non si riduca a sopravvivere individualisticamente, che usi gli strumenti di democrazia per sospendere il voto dato, alla meglio, al meno peggio. Capace di smettere quel grigio ridurre e ridursi alla delega quotidiana in bianco (figlia storica, questa sì, di lunga pratica con poteri anche localmente deresponsabilizzanti).
La visionarietà non è, intendiamoci, fare i ponti di Messina (in Lucania ne abbiamo intere collezioni), ma è certo smettere di pensare che la sommatoria di piccoli passi amministrativi disarticolati possa essere in sé positiva. Sapere dove si va, insomma, oggi dovrebbe essere più importante. Il progetto complessivo (che subordina a sé il programma) è l’unico che possa dire dove chirurgicamente tagliare, dove poter promuovere, dove poter attingere eventuali nuove risorse. Si tratta di avere idee su uno sviluppo finalmente radicato e complessivo. Consultandosi. Cioè uscendo fuori dalle angustie del paesello, mettendo in rete, quella reale dei rapporti socio-politici, gli sforzi (non ci vuole mica Tremonti per leggere, in maniera costrittiva, quella che è la possibilità dei comuni di concertare collettivamente lo sviluppo invece dei tagli smettendola, magari, di azzannarsi anche per un mattone sul confine).
Utopie, si dirà. Ma, in alternativa, l’appiattimento su questo esistente? L’utopia è, l’ho già detto altrove, un carattere normativo della realtà. Una terra verso cui navigare, senza mai approdare o naufragare. Una terra, tuttavia, il cui mare chiede di essere costantemente solcato. Altrimenti, la terra che invece abbiamo sotto i piedi, quella per cui badare concretamente al giorno per giorno, potrebbe definitivamente affondare.
Lettera al Direttore Paride Leporace sulla lettura in Basilicata
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 29 Maggio 2011.
_____________
Caro Paride,
come ben sai lavoro in editoria da un po’ e, sia pure con un poco di ritardo e dopo qualche esitazione, non mi dispiace confrontarmi con l’indignato garbo della Signora Rosaria Scaraia sul “Quotidiano” di qualche giorno fa. Benché, sia bene inteso, l’argomento – la lettura dei libri in Basilicata, regione fanalino di coda in questo genere di maggiore o minor amena attività –, io lo affronti ormai solo con l’ottimismo della volontà, ché la ragione ha qui già da tempo buttato la spugna.
Dunque, riassumendo velocemente: per la Scaraia lascerebbe l’amaro in bocca scoprire che “i dati contenuti nel report pubblicato dall’Istat rivelano che l’anno scorso solo un lucano su tre” ha letto un libro “per il piacere di farlo (e non per ragioni di studio)”. E sconcertante “scoprire che, due famiglie su dieci, di libri in casa non ne hanno neppure uno”. Ed è la realtà, non discuto. Soprattutto a fronte del legame tra istruzione e reddito medio territoriale che la Scaraia individua come ragione di uno specifico ritardo locale sul tema.
Però a questo punto, io mi chiedo: è davvero una specificità quella lucana o in Lucania è solo più approfondito un abisso comune? E non dico di fronte ad altre regioni meridionali, ma pure rispetto a quelle con più alto reddito. Insomma il meccanismo istruzione/reddito si rivela davvero così meccanico? Ho i miei dubbi. Non lo affermo ovviamente perché la Lucania possa così trovare un’utile foglia di fico (non so quanto larga, del resto) alle sue “insopportabili” mancanze (che restano dunque mancanze da emendare), quanto perché il declino della cultura del libro in Italia è generale. Certo più marcato al Sud, ma comunque assai diffuso. Perché il problema non è solo nell’analisi quantitativa del dato, cioè il rapporto spesa/libro, ma va oltre, fin nel suo vero nocciolo malato, cioè il rapporto libro/lettura.
Signora Scaraia, se lo lasci dire da uno che vive le magnifiche sorti e progressive della civile e avanzata Toscana, che si fa le fiere letterarie e librarie a Roma, a Torino, a Pisa e altrove. La gente che gira interessata (intendo il lettore medio) poi è sempre la stessa. Una minoranza importante per la sopravvivenza del libro, ma spesso pure ombelicale, autoreferenziale, e di cui ho imparato anche a diffidare, perché spesso si incaponisce a leggere libri alla “Firmino” e ad autorassicurarsi che “leggere è bello” e che “il libro non finirà mai” in saecula saeculorum. Invece, faccia la prova: se regala a un compleanno un libro (non solo a un giovane e se non già bulimico lettore) il festeggiato la guarderà quasi sempre con stampato sulla faccia un mal dissimulato “ecchene n’antro!” dove per altro dovrà necessariamente intendere “lo sfigato di turno”. Figuriamoci sostituire o accompagnare con un bel volume la “busta” da consegnare a una felice coppia di nuziandi: apriti cielo! e giù familistica riprovazione fino alla settima generazione!
La verità è, invece, opposta, ché in Italia, mica solo a Potenza e Matera (anche se ci ingegniamo sempre a fare peggio), si è consumato ormai storicamente il distacco definitivo tra produzione di benessere e produzione di cultura. Ma ce lo vede “il modello vincente” Briatore a pubblicizzare la lettura?
E poi, anche se così fosse? Le case dei lucani, come del resto dei meridionali, sono piene di libri e enciclopedie vendute negli anni ´60-´70 dai commessi della Fabbri, della Laterza ecc., e comperati in un momento in cui oltre alle pentole e agli aspirapolvere c’era una minima capacità di spesa anche per un po’ di carta stampata. Certo, non c’era la volontà di leggere in chi s’era appena elevato economicamente al rango di piccolo-borghese inurbato, però forse c’era la speranza che i figli potessero farlo in vece loro prima o poi. Che calcolo sbagliato! Ché invece i figli se ne sono andati e per loro, per i genitori del “Boom”, non poteva che finire com’era iniziata, perché in Italia la Lettura è sempre stata scritta con la L maiuscola, come la Cultura con la C grande, ammettendo già con questo tra le righe che trattavasi di roba maneggiata dai galantuomini per fottere il prossimo oppure attività dal significato oscuro e di nessun interesse. E dunque, certo in non tutti i casi, considerato il modello così alto (LA CULTURA) doveva finire così: che i Libri potevano continuare a farsi le cose loro (arredo e status) nei soggiorni buoni e, di lì, a sviluppare muffe. E, del resto, i tardi lettori in erba iniziato poi lo “sboom”… ma sì, chi tiene tempo?
Non parliamo del contributo della scuola d’antan: un romanzo, una poesia? roba buona per riassumere o per mandarla a memoria a forza di girare attorno a un tavolo fino a sfinimento (ricordiamo ancora i “Riassumi!”, i “Tema!”, i “Ripeti!: La Vispa Teresa avea tra l’erbetta…”, degli scolastici sketch stralunati e non-sense di Cochi e Renato?). Come non disamorarsi e averci sulle balle Carducci, Manzoni e Omero e poi, per riproduzione di spiacevole sensazione introiettata, evitare la lettura autonoma di un Pagliarani, di un Pirandello, Svevo, Moravia, Patti?… Ma se io, per aver citato Pasolini, beccai uno dei miei più memorabili cinque in un compito scritto di italiano con professoressa che tra un sonno e una “Corona” di Rosario, vecchia com’era, ricordava pure con orripilata indignazione di aver fatto scuola con il sovversivo Riviello?
Certo non tutto è perduto, ad esempio, se si pensa all’aumentato numero di lettrici in Italia. Ma soprattutto se ci si darà da fare ancora e meglio. Però i coupon da spendere in libri, da soli, sono come l’alfabetizzazione informatica in Basilicata: non basta cioè comperare i computer a tutti, anche al contadino o al sessantenne, perché questo, in un momento, metta a frutto le potenzialità dell’ordigno. E le potenzialità sono oggi già di più se, proprio grazie al collegamento Internet, posso essere messo in grado di comprare quel libro che la totale mancanza di una rete di librerie sul territorio mi impedisce.
Parliamoci chiaro, Signora Scaraia, in realtà non le sarà sembrato, ma io sono con lei: io non leggo solo i dati Istat, ma pure quelli AIE (Associazione Italiana Editori) e le dico che, secondo me, la nostra generazione è quasi del tutto perduta alla lettura e, per certi versi, alla cultura. Pensi solo quanto sia arretrato il nostro italico e romantico “vissi d’arte” usato da tutti gli scrittori (migliaia) che inondano le case editrici di manoscritti (migliaia) senza nemmeno aver letto due libri in vita loro.
I forti investimenti che la Regione e le Province devono fare (ma ci vogliono dei bei “dindini” Signora, come si dice in Toscana) sono per la fascia di lettori oggi più diffusa e potenziale: i preadolescenti e gli adolescenti (e oggi son pure pochi e dunque che si investa e poche chiacchiere!). E devono essere investimenti tesi mica solo a favorire l’acquisto dei libri: ben altre idee creative ci vogliono, ben altre sfide per i nostri locali politici, ben altri circoli virtuosi tra istruzione scolastica sostenuta per l’obiettivo libro, lettura dei giornali, visite alle fiere, uso di internet, piccoli corsi su cos’è un libro e come si legge, premi per i più piccoli, incontro con gli scrittori, ecc. Si ha bisogno, insomma, di quello che si potrebbe denominare la “creazione di un sistema lettura” sollecitando tra i giovani un interesse che poi, la fascia generazionale investita, avanzando d’età, potrà lasciare come speranza alla generazione successiva (creando dunque anche qui un circolo virtuoso) prima che ogni interesse si spenga. Non a caso è assodato che ci siano più possibilità che scatti l’interesse per la lettura nel bambino che a casa vede leggere. Sottolineo: non il bambino che contempla libri-soprammobile e tendenzialmente intoccabili (“ché si sciupano!”), ma che vede leggere attivamente un quotidiano, un libro ecc. Infatti qui non si tratta solo di acquistare un libro, ma di giungere alla consapevolezza che il libro è o uno strumento tecnico per imparare (non solo a scuola) oppure un modo (parlo di romanzi e poesia) per accedere a una qualche notizia del mondo, a un’esperienza di vita, a una nuova e più fresca visione delle cose che possa rinnovarci, renderci più ricchi, più aperti, meno provinciali. E ciò vale per la carta o l’e-reader che dir si voglia.
Ho parlato poco prima di speranza che si possa recuperare una generazione alla lettura: perché un interesse non si sa mai se, perché e quando possa o meno scattare (è nota di Pennac, ad esempio, la non gloriosa carriera scolastica), ma questo non deve esimerci dall’attivarci per tentare ogni strada con l’obiettivo di favorire alla lettura, alla cultura, un contesto più propulsivo, altro, alternativo all’egemonia della società dello spettacolo in cui siamo immersi fino al collo.
Gli elettori raramente scelgono i migliori (come diceva Salvemini)
Questa lettera al direttore è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 6 gennaio 2011.
_____________
Caro Paride,
ho letto con interesse l’intervento di Andrea Di Consoli e alcuni successivi, soprattutto quello di Pino Suriano. Insomma, al di là dei singoli casi sollevati, Di Consoli, come l’innocente e (sospetto io) libertario bambino della fiaba di Andersen, grida: “il re è nudo!” o, meglio, “il satrapo è nudo!”. Grida, e fa bene, ché i panni vestiti dai “nuovi” imperatori (nuovi, intendo dire, rispetto alle vecchie gerontocrazie politiche che in Basilicata hanno preceduto) son purtroppo i vecchi e, ora, pure parecchio più sdruciti per servire a una sfilata in stile “vintage” apprezzabile dai contemporanei.
Però, poi, io che sono un tantino più vecchio e forse pure un po’ più pessimista, mi terrorizzo. E mi terrorizzo perché so mica io l’appello ai lucani di Di Consoli a chi potrei indirizzarlo… Sennonché, “Le novità virtuose nascono sempre dal basso”, integra e indica Suriano, ed è verissimo. Ma invece di racquietarmi, mi ritorna alla mente una famosa frase di Salvemini in cui, duro, diceva: “L’esperienza ha dimostrato che gli elettori raramente scelgono i migliori”. Però poi, va beh, mi dico, magari avranno smesso pure “di scegliere normalmente i mediocri” o i peggiori. Che forse coincide un po’ con la tua posizione, Paride.
Tuttavia penso e ripenso, e in tutto questo ripensare qualcosa non mi torna. Perché i giovani di cui parlano i Di Consoli e i Suriano (quelli che votano i migliori tra loro) c’erano anche quando io me ne stavo in Basilicata, e quelli non vanno dunque contati, prima di tutto perché son sempre stati tanti, ma mai abbastanza, e dunque non hanno contato, e poi perché hanno sempre votato contro la vecchia Dc e ora continuano (ché molti politici, Emilio Fede può piantare sulla nostra regione tutte le bandierine rosse di stizza che vuole, ma in gran parte son democristiani di ritorno).
E allora? Allora mi prende alla gola un retropensiero, forse qualcosa di paranoico, ma che alla fine mica riesco a scacciare: e se la restante parte dei lucani, mi interrogo, la stragrande rimasta, votasse quelli che sono come loro? Magari però qualcuno mi dirà: ma mica ora è come prima quando i maggiorenti democristiani avevano a disposizione di volta in volta le chiavi dei forzieri dell’erario, del terremoto ecc., per cui qualche favore (per favore io intendo quelli più odiosi, i più prevaricanti, sia beninteso) fatto al famulo più vicino poteva passare in cavalleria che tanto “tutti”, nel marasma e bailamme dei favori di favori, ci “uscivano qualcosa” pure loro. Qualcuno mi ha anzi replicato: “e qui ora non ce n’è più per nessuno e davanti a queste cose vedrai i lucani come si incazzano!”.
Però, poi, pure che me ne sono andato lontano da un po’, poi lo so. Poi lo so che nel segreto dell’urna il lucano imbufalito, quando prende in mano la matita di stato, mannaggia!, proprio mannaggia, e cavolo!, gli viene in mente che proprio perché è crisi maledetta, proprio perché il figlio a trent’anni ancora gli rompe le scatole e non se ne toglie, proprio perché la figlia (e come si fa con la figlia) ecc., al lucano imbufalito gli viene il dubbio che mica lo sa se di risorse proprio non ce ne sono più. E magari qualche cosa da qualche parte – nel forziere ravanato e derubato – può essere rimasto. E chi lo sa? E non c’è il petrolio, il comprensorio industriale? E non ci sono i parchi nazionali, le tipicità, le eccellenze? E chi lo sa se tutta questa modernità qualche posto non ti dico lo produce, ma almeno lo conserva?
E, dunque, nel legittimo dubbio, come fosse una bambola col tasto dietro, il lucano imbufalito, come si dice in Toscana, si “spenge”.
Epperò, non per questo, non per questa sempiterna “maggioranza speranzosa” (che non giustifico, ma di cui però capisco i dolorosi bisogni che è inutile cercar di risolvere così), una classe politica deve comunque pensare di poter dare il peggio di sé. Se non proprio in quanto a favoritismi (nessuno ha ancora condannato nessuno, è stato ben detto), almeno in quanto a capacità teorico-culturale e politico-amministrativa. Che è la cosa più importante, a ben guardare.
Un caro abbraccio e buon anno.
_____________
La lettera aperta ai lucani di Andrea Di Consoli
Cari lucani,
in seguito alla notizia data dal quotidiano milanese “Il Giornale” – che rivelava che il Presidente della Giunta regionale Vito De Filippo e il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Folino sono indagati per turbativa d’asta presso la Procura di Potenza – io mi sarei aspettato che i diretti interessati ci fornissero immediatamente qualche elemento in più di riflessione, qualche approfondimento ulteriore, anche perché la notizia è di quelle che, ancora una volta, pongono perentoriamente il tema umiliante e problematico – non solo lucano – del connubio nefasto tra politica sanitaria e consenso elettorale (la malattia reale e la malattia del potere si abbracciano proprio lì: negli ospedali).
Invece il Presidente De Filippo, a poche ore dalla pubblicazione dell’articolo, dirama un comunicato stampa in cui definisce la notizia de “Il Giornale” come “trita e ritrita”. Eppure, francamente, questa notizia non si era mai letta sui giornali – né locali, né nazionali – e quindi davvero non si capisce in base a quale criterio la si possa definire impunemente “trita e ritrita”. Può una strategia di comunicazione prevedere la dichiarazione di un falso? Perché sì: dire che la notizia de “Il Giornale” sia trita e ritrita” è una bugia a tutti gli effetti, e i cittadini lucani perbene non pagano le tasse per sentirsi dire delle bugie da parte di chi governa – a spese nostre, su nostra delega – la Regione Basilicata.
Altra cosa, s’intende, è rimarcare senza mezzi termini – come voglio fare anch’io – che si tratta solo di un’indagine, e che un’indagine non significa né rinvio a giudizio, né condanna definitiva. Questo deve essere chiaro, ché si è colpevoli solo alla fine del terzo grado del processo, benché in passato, proprio in Basilicata, alcune persone siano state personalmente demolite con appena qualche anatema di piazza e qualche articolo (chiamiamolo pure così) di giornale. Mai nessun cambiamento politico dovrebbe passare attraverso le azioni della magistratura, anche perché in un Paese sano la magistratura rispetta regole rigide e non assume mai ruoli politici diretti o indiretti, come pure in Italia troppe volte è capitato e, ancora, capita.
E Vincenzo Folino? Continua la politica della loquacità reboante a tavola e della lingua di legno in pubblico, avviata all’indomani del suo insediamento alla Presidenza del Consiglio regionale. Una delusione totale, francamente.
Mi chiedo anche se sia giusto che la più vista televisione lucana (più vista perché, di fatto, l’unica), ovvero il Tgr regionale, il cui caporedattore è Oreste Lo Pomo, dia la smentita di De Filippo e non la notizia che ha originato la sua smentita. Non voglio fare e non farò mai lezioni di giornalismo a nessuno (anche perché non sono mai voluto diventare neanche pubblicista, e quindi non faccio parte, per scelta, di nessun Ordine), ma è normale dare la smentita di una notizia che non si è mai data? Non dico che c’è malafede, in Lo Pomo, che pure conosco come persona seria da molti anni. Dico che c’è quieto vivere, fiacca, stanchezza, spleen impiegatizio, che, a certe ore della vita pubblica, sono più pericolosi della stessa malafede.
Eppure, nonostante questo, qualcosa si sta muovendo, in Basilicata, come un lontano bubbolio di tuono, di tempesta che si avvicina. Un certo clima putiniano e oligarchico viene guardato con sempre maggiore diffidenza, più spesso con rabbia, soprattutto dai giovani, dai tanti non appartenenti agli apparati chiusi del Partito-Regione, colmi di galoppini tristi e impauriti di via Verrastro.
Le ultime cronache sulle nomine dei dirigenti alla Regione, sulle assunzioni all’Arpab (la prima classificata al recente concorso indetto dall’Agenzia lucana per l’Ambiente è la sorella di un nominato dirigente alla Regione, ex portavoce di Vito De Filippo), i casi di Vito Di Lascio (vincitore di concorso regionale nonostante sia assessore provinciale in carica) e di Marcello Pittella (la moglie è stata assunta all’Asl 3), per tacere di altri casi, stanno accendendo lentamente una miccia sulla quale pure, grazie al clientelismo di almeno tre decenni, si è gettata non poca acqua. Ed è proprio questa sensazione di strapotere, a indignare; questa guasconeria strapaesana e un po’ megalomane che porta il Presidente della Regione a dire che una notizia inedita è “trita e ritrita”; questa convinzione – di una decina di persone: i geniali Luongo, gli ineffabili e pirotecnici Viti, e poi i Lacorazza, i troppi Pittella, i taciturni Antezza – nel poter pensare “qui comandiamo noi”.
Lo confesso: non mi aspetto una battaglia di opposizione dal Pdl, il felice perdente. Mi chiedo solo che con che faccia i signori Viceconte, Latronico, Taddei e Pagliuca possano ancora continuare a presentarsi alle elezioni proponendosi quale alternativa all’attuale oligarchia putiniana. Una svolta è necessaria. Sono però felice che recentemente a Roma, in una conversazione informale alla Camera dei Deputati, almeno tre parlamentari meridionali del Pdl mi abbiano detto che presto il Pdl di Basilicata sarà commissariato, e che si stia studiando una strategia per far intervenire nella questione finanche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ci sono momenti in cui per uscire dal pantano occorre una mano esterna, una sorta di sbarco in Normandia di liberatori.
Mi chiedo pure cosa voglia dire il segretario regionale del Pd che in ogni circostanza ripete che “bisogna andare avanti con la modernizzazione della Basilicata”. Come si fa a essere così ineffettuali e astratti a trent’anni? Cioè, come si fa a parlare di modernità in una situazione di fatto oligarchica, ai limiti della satrapia? Ci sono ore in cui la diplomazia diventa stucchevole. Siccome non parlo a nome di nessun popolo, non ho paura di dire che vorrei che i trentenni lucani non gli somigliassero neanche un po’, mai. E mi chiedo, tra le tante cose: è “moderno” un partito in cui ci sono figure levantine come quella di Maria Antezza, che ha fatto eleggere alla Regione il cognato e la sorella Nunzia al Comune di Matera? Si dirà: i voti si contano, non si pesano. Benissimo. Almeno però si eviti di usare belle parole per siffatti contesti familistici. Le parole, si sa, sono importanti, anche se, purtroppo, sono gratuite.
So, o immagino, che il direttore Paride Leporace non condividerà alcune di queste mie riflessioni. Il fatto che le pubblichi è però segno che non tutte le bocche sono tappate. Questo mi dà fiducia che, presto, le cose possano cambiare in meglio. Ma è necessario che gli uomini liberi e forti che amano la Basilicata la liberino per sempre dalla tirannia della politica politicante. Questa terra merita amore e umiltà, non disonore, non paranoia, non arroganza, non familismo partitico, non megalomania velleitaria, non ignoranza, anche se abbiamo un assessore regionale alla cultura di primo piano e di entusiasmante carisma intellettuale.
Piccola postilla. Recentemente il Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo mi ha detto a muso duro che il 60% dei lucani ha votato lui, e che se il centrosinistra ha vinto, ha vinto grazie a lui, perché “io ho un rapporto speciale con i miei elettori”. Sono rimasto a bocca aperta, allibito.
Cari lucani, non voglio aizzare l’antipolitica, che detesto massimamente. Ma, mi chiedo: chi critica questa oligarchia lucana fa solo antipolitica? Basta a salvarsi la coscienza il dire che si fa del basso populismo? Per fugare ogni dubbio demagogico, dirò chiaramente che molti di voi lucani sono complici di questo sistema. Molti di voi non fanno altro che elemosinare aiuti e interventi del politicante di turno, anche quando qualcosa vi spetta di diritto, anche quando il politicante di turno sapete benissimo che non può aiutarvi, e che millanta poteri che non ha, o che utilizza solo per i propri camerieri fidati. E’ un’abitudine umiliante che detesto, e che vi toglie dignità. Purtroppo la brutta situazione attuale non la si ribalta né con gli esclusi rancorosi, né con chi cambia carro non appena si profili all’orizzonte un nuovo vincitore. Diciamo che sto ancora cercando di capire se questa classe dirigente rispecchi davvero il suo popolo. Se è così, il cammino verso la libertà e la democrazia è ancora lungo. Ma non mi scoraggio, né lo farò mai, ché il maledetto amore che provo per la mia terra me lo impedisce.
Andrea Di Consoli
Intervista a Maurizio De Giovanni
Questo articolo è stato pubblicato su «Scritture & Pensieri» il 17 Ottobre 2010.
_____________
Napoli nella pelle
Noir mediterraneo – Maurizio De Giovanni racconta il “suo” commissario Ricciardi
Classe 1958, napoletano, Maurizio De Giovanni è arrivato tardi alla scrittura e presto al successo di pubblico e di critica. Con un personaggio dolente quanto ispirato, il commissario Ricciardi, che, nel volume Il giorno dei morti (ed. Fandango), affronta l’ultimo episodio di una saga dedicata alle quattro stagioni. Quest’ultima indagine (ma altre seguiranno) si svolge in una Napoli che il 26 ottobre dell’anno IX dell’Era Fascista troviamo aggredita da una pioggia inesauribile che le “le toglie il sorriso”. Acqua che fa paura, che non lava, che deruba un bambino della sua spensieratezza e del suo futuro.
Nel suo ultimo romanzo Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi (Fandango), la città sembra avere una presenza diversa rispetto ai suoi lavori precedenti.
Sì, è vero. Del resto la città non è una semplice contestualizzazione degli eventi, ma uno sfondo dinamico. E ho sempre ribadito come Napoli sia una città estremamente stratificata. Una realtà che si nota, ad esempio, anche attraverso i mille cliché anche contrastanti, paradossalmente tutti veri, ma pure tutti coesistenti, tutti accumulatisi in secoli di vita cittadina. Non è un caso che Napoli sia un luogo che lungo la sua storia conti nessun assedio, perché qui tutti i conquistatori, tutti gli eserciti invasori sono sempre stati accolti a braccia aperte, senza opposizione.
E come convive con questa città il commissario Ricciardi?
«Il commissario Ricciardi è un uomo che vive una condizione di solitudine, in qualche maniera scollato dalla città, ma in realtà vivendola e vedendola molto più profondamente del resto dei suoi abitanti. Ricciardi ha un dono-condanna, la singolare capacità di cogliere l’ ultimo pensiero dei morti, che non è altro che la percezione di una sincronicità. E infatti è l’unico che vive e attraversa una mancanza di cesura tra passato e presente, di un superamento storico dei fatti».
Napoli. De Silva non la nomina mai, ma poi la città è come se premesse dentro ogni sua singola frase. Lei la sposta in un’altra epoca ma, nel rapporto con il suo protagonista, si rivela poi di un’attualità estrema. Di Napoli si può parlare solo così?
«Napoli si può affrontare con rabbia, con amore o con passione, ma la verità è che resta sempre un argomento che non si può esaurire. Purtroppo è poi anche una città sommatoria di individui, incapace di esprimersi all’ unisono, di dire “noi siamo cittadini”. E questo pur avendo la cultura e tutte le carte in regola per potersi realizzare in un destino comune e positivo».
Ritrova elementi comuni a Napoli nelle altre città del Mediterraneo?
«Gli elementi comuni sono tantissimi, io stesso ne ritrovo una quantità con Genova, ad esempio. Ma oltre che di Mediterraneo si dovrebbe parlare di partecipazione a una comunità orizzontale con tutto il meridione del mondo. Basti pensare ai legami con l’America Latina, ad esempio».
Torniamo al romanzo. L’indagine questa volta gira attorno a una vittima che è un bambino. Il Noir partenopeo ha una particolare sensibilità verso questa realtà?
«Il piccolo Matteo, ”Tettè” , è un bambino povero, denutrito, lacero. Prima e dopo la guerra Napoli è diventata famosa per la presenza massiccia dei bambini tra i suoi vicoli e nei quartieri. Era ed è un’infanzia coinvolta nel crimine. I bambini sono usati come spacciatori, corrieri della droga. Un problema pressante e persistente. Nel mio ultimo romanzo è una tensione che il protagonista vive particolarmente».
Di Ricciardi ha detto che «è un uomo che non riesce a non guardare il male». In realtà nel Noir è sempre presente una profonda tensione a conoscere il male. Secondo lei come se ne può scriverne senza giudicarlo moralisticamente o senza rimanerne compromessi?
«Oggi il vero erede del romanzo sociale è il Noir. E non puoi riuscire a vedere il male attraverso il bene ma, al contrario, puoi recuperare una visione del bene attraverso il male. Per il resto per parlare del male io non adotto una scrittura asettica, ma mi sento coinvolto e partecipe nella sua descrizione. Tuttavia ho rispetto per la vittima di un delitto, non mi attardo in descrizioni splatter e non indulgo in atteggiamenti giallistici perché non sopporto l’omicidio come occasione di racconto. Faccio invece esercizio di pietà, di pudore, di rispetto e comprensione del dolore.
Salone internazionale del libro di Torino (2010)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 23 Maggio 2010.
_____________
Le pagine che salvano
Cos’è un albero capovolto? Cosa le sue radici e i rizomi che affondano come mani nella terra? Che si strutturano come assoni, dendriti, sinapsi del cervello? Sono il ricordo, la memoria, il tema di questa ventitreesima edizione del Salone internazionale del libro di Torino. Ma pure il legame profondo con l’anima di una terra e di un popolo. Nel nostro caso quello della Lucania, un ricordo che non si estingue e perdura nei suoi figli, anche quelli più lontani, anche quelli emigrati e che Torino e il Piemonte hanno voluto accogliere.
Questo pare volerci dire la presentazione del libro Circoscrizioni civili ed ecclesiastiche nella Basilicata di Carlo I d’Angiò di Mauro Di Benedetto propostaci dall’Associazione “Cultura e solidarietà senza confini” di Maria Celano (e presentato da Giorgio Filograna giovedì 13 maggio). Un volume che nasce infatti dalla volontà di conoscere certi aspetti della propria regione di origine che Di Benedetto individua nella grande crisi seguita alla fine di Federico II di Svevia. Uno studio sulle fonti del potere amministrativo degli Angiò che comunque, alla lunga, stabilizzarono un periodo di forte mutamento storico a cui la Basilicata, nei rivolgimenti che pure interessarono tutta la Penisola e che portarono lentamente alla nascita degli stati nazionali in Europa, non seppe farsi trovare preparata.
Il particolare tema del legame degli emigrati e dei suoi figli con la propria terra di origine è stato proposto anche dal Consiglio Regionale della Basilicata (presenti allo stand Rossana Nardozza, Antonio Ierardi, Carlo Petrone, Lorenzo Tartaglia e Pietro Simonetti), quest’anno presente con un’installazione snella, ma più funzionale e senza la presenza dei libri degli editori lucani. Il che ha posto fine a una contraddizione che si individua in una “concorrenza” di fondo tra prodotti editoriali e una oggettiva carente capacità di autonomia degli editori nei confronti del supporto del Consiglio che non potrà che avere effetti positivi se in seguito si vorrà riproporre il sodalizio degli scorsi anni su altre basi, necessariamente più chiare, meglio meditate e magari con qualche mezzo economico in più offerto in tal senso.
Un ultimo accenno va doverosamente fatto all’infaticabile attività di Giuseppe Lupo, professore alla Cattolica di Milano di origini lucane, presente in Fiera con una serie di presentazioni e appuntamenti.
_____________
Luci e ombre dell’ex Fiera oggi Salone
Canta vittoria l’organizzazione del Salone internazionale del libro di Torino (13-17 maggio 2010), quest’anno tornato al nome originario una volta risolti i problemi burocratici che ne avevano imposto negli anni scorsi il cambio di nome in Fiera del libro. E snocciola percentuali importanti. Almeno secondo le proiezioni elaborate (prima di avere le cifre definitive) tra il diciassette e il venti per cento in più di affluenza. E tuttavia, per chi da più anni frequenta la manifestazione, ma anche per molti dei responsabili delle case editrici intervenutevi, le cifre proposte (anche quelle del volume di affari sviluppati) appaiono forse più contraddittorie. Innanzitutto a partire dalla constatazione che, in pratica, ogni anno si propone un incremento percentuale che, tradotto in cifre, porterebbe a stivare di visitatori – tanto da non poter permetterne più la deambulazione nonostante le capienti uscite – i tre padiglioni messi a disposizione dall’organizzazione. Ma va beh, “marketing oblige” e non vogliamo certo rovinare il fascino di una manifestazione in grado di proporre cifre comunque imponenti e scarsamente opinabili: intanto ben 11 le regioni presenti con un proprio stand (tra cui anche la Basilicata), 27 le sale incontro o dibattito per 1425 convegni con 2204 autori, 1400 gli espositori con proprio stand o stand collettivi, 75 gli espositori debuttanti (20 con stand autonome, 43 nello spazio incubatore, 12 nello spazio “Invasioni mediatiche”), spazi dedicati a nazioni quali Perù, Romania, Brasile, Slovacchia, Albania. Insomma una vera e propria festa del libro.
Quest’anno, ospite di riguardo del Salone, l’India. Stato-continente ricco di contraddizioni tra strutture arcaiche e spinte modernizzatrici fagocitanti e problematiche. Luogo dell’anima, della sua luce e della sua perdizione, capace da sempre di affascinare italiani come Guido Gozzano e rapire scrittori dell’esotismo di un Emilio Salgari, che pure mai là viaggiò, solo reinventandone il mito compulsando cartine e volumi di biblioteca. E poi l’India di Pasolini, quella dei diseredati della terra di Terzani, ma pure quella degli indiani: dal famosissimo Salman Rushdie alle nuove leve del romanzo come Kiran Desai, Tarun Neipal (il Saviano indiano), Vikas Swarup fino alla bellissima e piccante Shobhaa Dé.
Tra i temi più interessanti, quello del futuro del libro e della diffusione degli e-book, uno scontro sotto l’incalzare di una tecnologia sempre più sofisticata che propone aspetti importanti anche sotto il profilo dell’informazione e della memoria, il tema principe del Salone di quest’anno. “Siamo di fronte a tre parole” ha detto Umberto Eco, “che in realtà vogliono dire la stessa cosa: cultura, anima e memoria. L’anima è memoria: se perdi quest’ultima perdi anche te stesso, e la cultura è ciò che mette insieme l’anima e la memoria di una società”. La cultura, per Eco ha la fondamentale funzione di “conservare il ricordo, filtrare ciò che è importante da ciò che non lo è, ma anche lasciare in latenza memorie che vengono prima dimenticate e poi recuperate in un secondo momento”. Già Platone, ha poi aggiunto il filosofo Maurizio Ferraris, “metteva in guardia sul pericolo di affidarsi a una memoria esterna, la scrittura, tralasciando la pratica della memoria interna di ognuno di noi, più vera e affidabile”. Un problema che diventa dirompente con l’apparizione di internet e supporti che sempre più si affidano a risorse fragili come la corrente elettrica generata dalla scarsità del petrolio. All’antropologa Patrizia Viola non è restato che chiudere il cerchio, perché “anche se i supporti di registrazione fossero immortali avremmo comunque il problema dell’immensa proliferazione delle tracce che lasciamo… come faremmo a decidere cosa ricordare e cosa no?”. Come a dire che troppa memoria coinciderebbe con la sua pratica inutilità, che solo l’oblio può mitigare.
Intervista a Franco Arminio: Nevica e ho le prove (Laterza, 2009)
Questa intervista è stata pubblicata sul sito della rivista «Stilos», febbraio 2010.
_____________
Sud, senso di fallimento e di sconfitta
“Ho sentito che non c’è riposo da nessuna parte, che nessuna vita può difendersi da niente, siamo esposti, irrimediabilmente esposti a tutto, tranne che alla gioia, questo sento adesso stando qui”.
Più che paesologico, Nevica e ho le prove. Cronache dal paese della cicuta di Franco Arminio (Laterza), è un libro climatologico, che richiede una lettura lenta, ripetuta. E un lettore che abbia voglia di impregnarsi di una prosa apparentemente tradizionale, ma custode di un forte istinto sperimentale. Ne abbiamo parlato con l’autore.
Mentre il sottotitolo del tuo libro richiama a un velenoso fiele del vivere in chiave paesologica, il titolo Nevica e ho le prove, pare rifarsi a un’altra possibilità di lettura…
La decisione che ha portato a intitolare il libro Nevica e ho le prove è stata in realtà un po’ sofferta. In un primo momento la scelta era ricaduta su Il dito sul cuore, che è il titolo del secondo paragrafo di “Diario concitato”. Però, estrapolato dal suo contesto, m’è parso restituisse un senso un po’ sdolcinato che invece non ha. Abbiamo dunque optato per Nevica e ho le prove, un pezzo di un aforisma tratto dal paragrafo “Pensatori delle panchine”. È un rafforzativo di Cronache della cicuta che richiama all’inverno, al cattivo tempo, all’invariante climatica tipica dei miei luoghi.
Il libro pare faccia uno scatto in avanti rispetto alle tue precedenti prove. Cioè, fino a ora, i tuoi lavori avevano trovato un punto di coincidenza tra l’ipocondria del tuo sguardo di scrittore e la malattia paesologica. Qui, invece, tu parli in tono rassegnato di un “noi”, della banalità delle relazioni umane nei luoghi in cui vivi…
Non parlerei di scatto, almeno non nel senso del lavoro che ha preceduto la preparazione del testo. In realtà la stesura delle singole parti del libro procedeva parallela da lungo tempo, in alcuni casi addirittura dagli anni Ottanta. Direi che, invece, la differenza con le mie precedenti prose resta la particolare intersezione tematica. Nevica e ho le prove è innanzitutto un libro intimo, poi un ritratto corale degli abitanti dei luoghi dove vivo, infine un monologo collettivo. Temi poi annodati su un filo conduttore forte che mi è congeniale e che è la nevrosi, il senso di fallimento e di sconfitta.
In una sua recensione al tuo libro, Emanuele Trevi ha parlato di un tuo atteggiamento diaristico nella scrittura. Non ti senti di aver in qualche modo tradito quanto è rilevato positivamente da Celati nella lettera-prefazione a Viaggio nel cratere (il paesologo è tale proprio perché mai impigliato dalle trame dell'”io” romanzesco)?
Ho inviato il libro a Celati, ma non credo lo amerà molto: il libro non affronta tematiche propriamente paesologiche. Del resto, dopo Vento forte tra Lacedonia e Candela, non potevo continuare a scrivere qualcosa che avrebbe rischiato di suonare monocorde, basato com’era su una tecnica da reportage. Ripeto, Nevica e ho le prove ha avuto una gestazione lunghissima, è un libro più complesso e difficile. Sinceramente non mi aspetto la stessa accoglienza critica tributata ai miei lavori precedenti e questa considerazione mi lascia un po’ di amarezza: lavorare per trent’anni a un libro è una fatica che ti fa desiderare di meritare maggiori attenzioni.
Il tuo libro procede con una molteplicità di stili (apologhi, aforismi ecc.) che mano a mano richiedono un passo di scrittura sempre più corto, fino al singhiozzo, all’accumulo elencatorio di oggetti e situazioni. Perché questa scelta di montaggio?
Il libro si presenta con una struttura a imbuto, che inizia con un giro largo per poi stringere e velocizzarsi alla fine. Vuole anche mostrarsi capace di accogliere pulsioni diverse di scrittura e di ispirazione che vanno da Bufalino a Lee Masters. Come dicevo, pochi autori, secondo me, riescono a giustapporre così tanti fili in un libro senza perdersi oppure stancare. Certo aiuta anche il dato geografico: restiamo sempre a Bisaccia, il che costituisce un fattore di unificazione. Comunque credo di essere riuscito nella creazione di un libro complesso e non scontato.
Sempre nella prima parte di Nevica e ho le prove parli anche molto del tuo rapporto con la scrittura, una pulsione irrinunciabile seppure schiva dei rapporti umani, che nasce nelle ore antelucane, addirittura già nel dormiveglia. Ci vuoi parlare anche dell’universo che la partorisce?
Io sono nato e ho sempre vissuto e scritto a sud e da sud. Pur stando qui non mi hanno mai appassionato gli scritti dei grandi meridionalisti. Forse gli unici che ho letto con attenzione sono stati Levi e Scotellaro. Insomma, guardo alle cose del sud senza fare riferimento alle astrazioni sociologiche e storiche. Seguo più la via dei dettagli. E in questo mi aiuta la mia lunga frequentazione con la poesia, che è proprio la scienza del dettaglio. Ho cercato di raccontare singole vite con singole frasi in un tentativo estenuante di schivare la prosa industriale che c’è in giro. Ogni pagina del libro è stata scritta e riscritta molte volte, montata e smontata, affiancata di volta in volta ad altre pagine fino a trovare la soluzione che ho consegnato alla stampa. L’indagine ovviamente non è chiusa, il lavoro paesologico è ancora tutto da fare. Ho già quasi ultimato un nuovo libro, sempre seguendo la passione di capire come sono adesso i paesi e come sono quelli che li abitano.
____________________
Classe 1960, Franco Arminio è di Bisaccia (Avellino), comune dell’Irpinia Orientale. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie ed è collaboratore di alcune testate giornalistiche locali e nazionali. È animatore del blog Comunità Provvisoria, che ne testimonia l’impegno civile soprattutto, ma non solo, a difesa del paesaggio. In prosa ha pubblicato opere – Viaggio nel cratere (Sironi, 2003), Circo dell’ipocondria (Le Lettere, 2006) – che lo hanno fatto conoscere ai lettori appunto come “paesologo”. Con Laterza, nel 2008, ha già pubblicato Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia. La sua ultima raccolta di versi è Poeta con famiglia (D’If). Con Nevica e ho le prove, Arminio sposta l’obiettivo dai paesi alle persone e, rispetto ai suoi precedenti lavori, più forte si sente la presenza dell’io narrante.
Intervista a Maria Carmela Calice
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 30 Giugno 2009.
_____________
La penna non è snob
L’editrice fra istituzione, voglia di sinergie e realtà lucana
Finita la festa, gabbato lo santo? Qualcuno può averlo pensato dopo la chiusura della Fiera del libro di Torino, magari pure rassicurato dal ruolo poco più che testimoniale espresso dalla presenza dello stand del Consiglio regionale della Basilicata.
Fatto sta che i problemi sul tavolo dell’editoria lucana sono rimasti tutti penosamente aperti. Il difficile stato delle case editrici creato dalle poche risorse non solo economiche, soprattutto la mancanza di una normativa regionale dedicata e una difficile concertazione dei tanti soggetti parte in causa: dagli autori alle case editrici, dall’Università alla scuola, dalla Regione al sistema bibliotecario, in un gioco culturalmente suicida di presente latitanza – ci si passi l’ossimoro – di un po’ tutti gli attori di questo singolare cast.
Tuttavia, grazie anche alla disponibilità di Maria Carmela Calice e di Rosetta Maglione, ci va di iniziare a scoperchiare finalmente la pentola, diradarne il fumo e saggiarvi lo stato dei principali temi contenuti. Uno sguardo dal di dentro, pregi e difetti inclusi, da chi questa situazione vive con disagio.
Con una speranza. Quella cioè che tutti quanti leggeranno le due interviste vorranno (editori, scrittori, politici, funzionari di istituzioni bibliotecarie e scolastiche, perché no?, intellettuali e lettori) a loro volta intervenire, dando maggior sostanza e senso al dibattito.
In questa prima puntata abbiamo incontrato la Calice Editori di Rionero in Vulture nella persona della Signora Maria Carmela che gentilmente, ma fermamente, come nel suo stile, ci risponde:
Dott.ssa Calice, sempre convinta che a Torino sia stato più importante portare i libri che partecipare di persona? Non crede che le fiere siano un’ottima occasione per intessere relazioni sul piano nazionale, per parlare del contenuto dei suoi libri ai curiosi e ai lettori?
Non ho mai pensato che sia meglio mandare i libri e non partecipare. Quest’anno è andata così, ma sia l’anno scorso a Torino che a Roma sono stata presente ed è stato interessante proprio per i rapporti che si sono creati con gli altri espositori e con i visitatori.
Nel suo intervento di risposta sulla mia inchiesta sulla presenza dell’editoria lucana alla Fiera del Libro di Torino ha molto ben spiegato quali sono le cause del ridotto peso dell’editoria libraria in Basilicata. Non crede se ne possa uscire anche con la collaborazione tra case editrici, magari associandosi, dividendo i costi dello stand (quello del Consiglio Regionale a parte) e ottimizzando i profitti con in più il vantaggio di dare un’idea di compattezza dell’editoria lucana sul piano dell’immagine?
Mi piacerebbe consorziarmi con le altre case editrici lucane, ma credo sia molto difficile perché, a parte qualcuna più antica, le altre sono di recentissima costituzione e penso che vadano ancora alla ricerca di una loro identità.
Non crede invece ci sia anche una certa dose di diffidenza o di pigrizia imprenditoriale? In fondo non si tratta di un afflato volontaristico, bensì di scelte con ricadute economiche anche importanti…
C’è senz’altro anche pigrizia e diffidenza, ma la verità è che ci vogliono investimenti rilevanti e nessuno di noi è in grado di rischiare.
Partecipa a fiere più piccole, dove i costi sono magari più contenuti?
Sì, soprattutto alle piccole fiere locali.
Rispetto a quanto è possibile fare, come sono i rapporti con gli altri editori lucani? Nonostante la varietà dei vostri cataloghi, mi sembra di leggervi comunque uno stile, un tono piuttosto accomunante… proponete delle coedizioni, delle presentazioni, dei progetti comuni?
I rapporti sono buoni e cordiali, ma finora ancora non siamo riusciti a fare iniziative comuni.
Come mai l’editoria locale (se non per casi singoli) non riesce ad attrarre i grandi scrittori lucani? È una questione economica? Di distribuzione? Di innovazione delle collane? Oppure dipende dagli scrittori che magari vi snobbano?
Credo che nella sua domanda ci siano già le risposte, ossia: è un problema di costi, di distribuzione sul territorio nazionale (ma le grandi messaggerie non prendono piccoli editori), ma anche di snobismo: chi scrive un libro preferisce pubblicare fuori regione, anche pagando e spesso il libro non viene distribuito affatto. A me, però, è capitato anche di rifiutare alcune proposte per mancanza di coraggio e poi me ne sono pentita.
Accosto due fatti solo apparentemente scollegati. Il primo è che nel panorama italiano il lavoro editoriale è andato mano a mano perdendo il peso di una volta anche con ricadute pessime sulla qualità del prodotto finale. Il secondo è il dato di fatto sottolineato giustamente da Paride Leporace e cioè che la “battaglia” per la presenza dell’editoria lucana a Torino si sia persa proprio sul piano della visibilità. Alla luce di ciò ritiene che gli sforzi per eventuali investimenti in marketing, comunicazione e grafica giochino tutto sommato un ruolo ancora marginale in Basilicata?
Sicuramente a Torino poteva andare meglio sul piano della visibilità e se avessero fatto gestire a noi editori l’intera operazione forse avremmo ottenuto di più, ma il problema è che il protagonista era il Consiglio Regionale con le sue pubblicazioni a cui si accodava l’editoria lucana e non viceversa, anche forse per colpa nostra…
Ma non ritiene una contraddizione nei termini o, per dirla più francamente, uno scandalo, che il Consiglio Regionale vi porti nel proprio stand e che invece la Regione invece non sia stata capace di varare un qualsiasi provvedimento di legge a sostegno delle vostre attività? Possibile che la Regione anche attraverso singoli esponenti non vi abbia mai fatto proposte concrete? E, se sì, perché sono sfumate?
Le spiego: quando fummo convocati la prima volta dall’allora presidente Bubbico, che aveva deciso di dare una svolta con una legge a sostegno dell’editoria, ci presentammo in tanti, pieni di entusiasmo e voglia di fare. Successivamente, quando si è compreso che la legge non sarebbe mai arrivata (e non ne comprendo i motivi) e che l’unica proposta che rimaneva in piedi era la partecipazione alle fiere con lo stand del Consiglio, si sono tutti persi per strada e alla fine ci siamo ritrovati solo in 3 o 4, ma temo che l’anno prossimo non ci sarà proprio nessuno.
Non si capisce perché non si riesca a fare una legge come in altre regioni. Ogni tanto qualcuno ci promette che se ne occuperà, ma poi tutto tace. Forse si crede che produrre cultura, tutto sommato, non serve a nessuno.
Certo in tutto questo la Regione sconta una pericolosa fragilità di costruzione degli spazi di democrazia nel senso che l’istituzione non si fa, in quanto soggetto politico forte, promotore della crescita di un pezzo della società civile in Basilicata. Ma non crede che nel discorso, sul piano culturale, si annidi pure una malintesa concezione della modernità per cui protagonisti dell’editoria siano soprattutto quotidiani e televisioni? Che non esista una modernità del libro e anche un modo moderno di fare i libri, il che mi pare nasca da una generazione di politici che legge poco?
Il punto cruciale è proprio questo: si guarda al libro come ad un oggetto sorpassato. Quelli della mia generazione, quando si potevano permettere di comprarne uno, guardavano al libro come all’oggetto di massimo desiderio, se lo scambiavano con gli amici ed erano capaci, poi, di passare ore a discuterne, confrontandosi, scontrandosi anche, ma crescendo. In quanto alla classe politica, che dire? Oggi forse non hanno tempo, dovendo sempre ricucire liti e strappi.
Però mi pare che questa fragilità costruttiva finisca poi per tradursi paradossalmente, sul piano pratico, in un vantaggio in favore della Regione quando quest’ultimo soggetto si fa a sua volta editore per motivi apparentemente istituzionali. Insomma, non crede che il Consiglio e la Regione per altri versi siano pure parte in causa e cioè che nonostante vi diano il contentino di portarvi a Roma e a Torino, la dura realtà è che l’istituzione regionale dal punto di vista editoriale resti un vostro agguerrito concorrente?
Lei esagera a parlare di agguerrito concorrente, ma una cosa è certa: sia la Regione che il Consiglio non dovrebbero fare gli editori…
Allarghiamo il campo. Come reputa nei confronti della sua casa editrice l’interesse di un’Università come quella della Basilicata?
Ecco, a proposito dell’Università, il ruolo della Regione doveva essere anche quello di raccordo tra i diversi soggetti che si occupano di cultura e penso anche alle associazioni culturali che ci sono in questa regione. Sarebbe straordinario se si incontrassero case editrici, associazioni, università per la costruzione di progetti di vasto respiro, il tutto mediato dagli uffici competenti regionali. In quanto all’attenzione dell’Università, non so che dire, forse perché la maggior parte dei docenti viene da altre regioni e non conosce la realtà locale.
Nel suo intervento a seguito del mio reportage su Torino ha detto che scarso è il sostegno delle istituzioni bibliotecarie lucane. In che senso?
In Basilicata abbiamo una Biblioteca Nazionale, due Provinciali e circa settanta Comunali di cui solo pochissime funzionano, nel senso che sono aperte al pubblico, la maggior parte sono sempre chiuse o aprono a singhiozzo, inoltre non tutte hanno un direttore, al massimo un dipendente comunale a cui è stato conferito l’incarico e non sempre in base alle competenze.
Cosa significa questo? Che non acquistano libri, non aggiornano, non organizzano nulla per avvicinare i giovani alla lettura con una ricaduta negativa sugli editori e sulle librerie. Insomma, sono tanti i problemi da affrontare da parte di chi dovrebbe, se solo ce ne fosse la volontà.
Un quadro desolante. Un’ultima domanda, la scuola dell’obbligo adotta libri del suo catalogo?
Né la scuola dell’obbligo, né quella superiore.
Intervista a Rosetta Maglione
Questa intervista è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 13 Settembre 2009.
_____________
Leggendo s’impara
La storia delle Edizioni Osanna di Venosa
“Chi non legge pagherà”. Così sta scritto nella pagina di presentazione del sito delle Edizioni Osanna di Venosa. La frase, attribuita al premio Nobel per la letteratura Josif Brodskij, suona minacciosa e al contempo vera, perché segnala un reale pericolo di spaccatura tra chi in una società legge, pensa e decide liberamente e tutti gli altri. Ma la Basilicata, si sa, è un mondo capovolto e chi legge e pensa non viene messo nella condizione di decidere liberamente, di essere aiutato a essere più forte e autonomo. A pagare lo scotto di questa situazione, anche le case editrici lucane.
A proposito delle Edizioni Osanna, abbiamo conosciuto Rosetta Maglione durante la scorsa edizione di “Più Libri Più Liberi” di Roma: una signora dai modi cortesi ed eleganti, ma anche una donna pienamente conscia del proprio status di più importante e strutturato editore lucano. L’abbiamo nuovamente sentita a proposito della nostra breve indagine sullo stato dell’editoria lucana.
Come avete iniziato lei e il Prof. Vaccaro? Quali i perché della vostra iniziativa imprenditoriale?
Alle prime esperienze di pubblicazione di nostri lavori abbiamo scoperto il fascino del pensiero che si fa parola scritta e si diffonde. Da assidui lettori crediamo da sempre nella lettura che “aiuta a salvarsi” dall’ignoranza e dall’errore come bene da promuovere.
Perché il marchio è stato denominato “Osanna”?
Osanna è il cognome dei miei tre Figli, Rocco Aldo, Massimo e Antonio, ormai professionisti affermati: cardiologo emodinamico il primo, docente e direttore della scuola di specializzazione in Archeologia dell’Università di Basilicata, il secondo, con sede a Matera, dottore commercialista il terzo. Nella loro primissima infanzia abbiamo perso il compagno e il padre, giovanissimo ginecologo venosino. Dopo oltre un decennio, un nuovo matrimonio ricostruiva il nucleo familiare. È stato il padre acquisito dei miei figli a volere che la casa editrice portasse il loro cognome.
A partire da quanto dichiarato nel vostro sito Internet, in che senso i vostri libri sono capaci di “autopromuoversi”? Non crede che ci voglia ben altro? Che sforzi può fare un Editore come lei in marketing, comunicazione, grafica ecc.?
Sono capaci di autopromuoversi per la qualità del prodotto, compreso la grafica, per i contenuti d’interesse sovraregionale, per la correttezza e puntualità dei rapporti con i committenti. Non vedo che altro fare, per ora, da una cittadina di provincia del Sud, isolata per la disastrata situazione viaria e l’assenza di comunicazione ferroviaria. Inoltre non si può accedere alle grandi reti di distribuzione in quanto come primo requisito si richiede la pubblicazione stabile di 30/40 volumi annui. Per la Osanna è molto funzionale (oltre quello con i distributori) il rapporto diretto con privati, con le quaranta librerie fiduciarie (che hanno stabilmente un buon quantitativo di volumi in conto deposito, con contabilizzazione semestrale) e con le circa trecento librerie che ricorrentemente ordinano volumi che forniamo contrassegno.
Sempre nella presentazione e nella dichiarazione di intenti della casa editrice pubblicata sul vostro sito si legge un’interpretazione del mondo editoriale legata a una prospettiva d’impostazione pedagogica della cultura e dei comportamenti di lettura. In tale quadro apparite meno preoccupati dalla “cattiva maestra” televisione che non invece dai pessimi libri e dagli atteggiamenti negativi ingenerati dalla famiglia e dalla scuola. Perché?
Abbiamo motivo di credere che ad allontanare i giovani dalla lettura non sono la televisione o i mezzi informatici, essi in una strategia multimediale possono avvicinare al libro in una reciprocità di sollecitazioni, per la curiosità e l’interesse che possono suscitare verso i vari ambiti culturali. Grande responsabilità ha la scuola gremita di insegnanti che non leggono, fatta qualche eccezione per i docenti di lettere. Mentre attraverso il libro, si dovrebbe stabilire un nuovo equilibrio tra progresso materiale e progresso culturale (quanti degli allievi delle nostre scuole, troppi, hanno raggiunto dignità economica ma non culturale). Un equilibrio tra modernità opulenta delle cose materiali e miseria dei pensieri e delle idee, che oggi segna contraddizioni clamorose. Siamo passati da generazioni di padri storicamente analfabeti, per un contesto di povertà e disagi, a generazioni di figli alfabetizzati, ma solo teoricamente alfabetizzati, nonostante il contesto di relativa agiatezza in cui vivono. E così i giovani italiani detengono il record della non lettura perché i modelli di comportamento giovanile legati al tempo libero propongono attività diverse dalla lettura, legate ad un mercato giovanile dai rapacissimi, grandi interessi economici.
Le istituzioni scolastiche (scuola dell’obbligo, superiore) adottano vostri titoli?
Vi sono stati periodi di grande interesse per i nostri volumi della collana “Narrativa Scuola”, con cicli di adozioni nella Scuola media inferiore legati alla sensibilità di qualche preside. L’entità della cosa ha destato la gelosia di alcune librerie ed è cominciata la guerra tra poveri, con il risultato di affossare alcune iniziative. Tuttavia continuano adozioni sporadiche nei vari ordini di scuola, e segnalazioni nelle università. In Venosa, nostri titoli vengono donati dalle scuole superiori in occasione di convegni e del Certamen Horatianum.
Quanto potrebbe fare la scuola per gli editori lucani?
In particolare le scuole superiori trascurano del tutto la lettura da parte degli allievi. Potrebbero doverosamente far apprendere a leggere e ad amare la lettura con ricorrenti indicazioni bibliografiche, con
Come si potrebbe promuovere meglio la lettura in Basilicata? una legge basterebbe? Con un aumentato concerto delle istituzioni in tal senso? Investendo maggiormente sui giovani?
Una legge sarebbe una buona base.
Per quali motivi secondo lei la Regione non ha mai prodotto un qualsiasi provvedimento in vostro favore? Crede che c’entri la debolezza strutturale dell’editoria lucana? Ma allora non crede che il meccanismo ingeneratosi sia quello tipico del cane che si rincorre la coda? Oppure è perché la Regione tende a farsi vostro concorrente?
Ricorrentemente la Regione edita in proprio, contravvenendo alle promesse di non farci concorrenza. Inoltre, le pubblicazioni regionali di rilievo economico sono dalla Regione e dalla Provincia commissionate a case editrici del Nord
La Dott.ssa Calice ci ha accennato al vostro primo incontro con l’allora presidente Bubbico: ci può dire come andò?
Già prima di quell’incontro il presidente Bubbico, in occasione della presentazione del volume di E. Soave, “Dopo Scanzano storia di scorie”, in Scanzano nel 2004 (eravamo al tavolo dei relatori), si impegnava a predisporre una legge per l’editoria. Il seguito è noto.
Non crede che oggi i politici leggano poco? E se prima leggevano di più, perché non è mai stata varata una legge per l’editoria libraria?
Forse perché in Basilicata il numero degli editori è esiguo e di irrilevante entità e quindi non assicura un ritorno in termini di consensi elettorali.
Dott.ssa Maglione, nell’intervista concessami dalla Dott.ssa Calice è stato detto (sia per le fiere che per le coedizioni e quant’altro) che i rapporti con gli altri editori lucani sono buoni e cordiali, ma le iniziative comuni latitano. Secondo lei per quali motivi? Come si può ovviare? Cosa farebbe dal canto suo?
Le distanze, aggravate da quanto sopra, sono un ostacolo a rapporti frequenti. Infatti la collaborazione è più assidua con la Calice. Con le altre recenti esperienze editoriali sono dissimili le strutture, le tematiche e anche gli obiettivi. Per ora non ravvisiamo alternative di respiro.
Tra le fiere, per lei, meglio Roma, Torino o altro?
Decisamente la preferenza cade su Roma, per la minore distanza, per il maggiore interesse dei visitatori per le tematiche meridionalistiche. Partecipiamo inoltre annualmente alle fiere che si organizzano in varie località della Basilicata e nelle regioni limitrofe, Puglia, Campania.
È più facile lavorare con singoli professori universitari per singoli titoli o con l’Università per collane?
Con singoli professori universitari. Le limitate esperienze dell’avvio di collane con l’Università di Basilicata si sono interrotte ai primi titoli. Per assenza di sostegno economico e di diffusione dell’università stessa e per l’esaurirsi della motivazione contingente di chi aveva dato avvio all’iniziativa, come è accaduto per la collana “Biblioteca di etnografia” ferma ai due primi volumi. Non si esclude che da parte nostra non si sia risposto alle attese.
Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi (Roma, 2009)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 10 Dicembre 2009.
_____________
C’è aria di “lucanità” alla Fiera di Roma
A Roma, uscita EUR Fermi del metrò ci accoglie un sole pigro e piacevole. È ancora presto e preferiamo andare in Fiera a piedi invece di utilizzare il bus navetta. Ci aggiriamo tra le masse severe dei palazzi monumento e il vuoto quasi perfetto di uomini in un giorno feriale. Finalmente incontriamo una ragazza. Fa la nostra stessa strada, ci chiede come meglio raggiungere il Palazzo dei Congressi dove si tiene la manifestazione dedicata ai libri. Raggiungiamo un’arteria principale, finalmente, questa, rombante di un traffico senza particolari eccitazioni. Intanto scopriamo che è appassionata di teatro e di letture, stagista di una casa editrice prestigiosa. E scopriamo che è di Melfi, il che ci pare subito di buon auspicio per il nostro reportage, ma poi anche prodigioso come facciano a ritrovarsi i lucani sempre nei posti più insoliti e deserti.
Comunque sia, appena giunti in Fiera, l’impressione complessiva è che la gente l’abbiano fabbricata lì di notte in quantità, una folla generata dal nulla che ci fa perdere in un attimo la nostra stagista tra la ressa, le cose da fare, le persone da vedere di una mostra che è l’antitesi di Torino: fagocitante come quella, ma non per gli spazi, la quantità, l’enormità. Roma è più serrata prossemica di intellettualità, di amicalità, una dimensione piccola, ma proprio per questo meno freddamente rituale, più densa e coinvolgente.
E infatti quasi subito, non sappiamo ancora come, riusciamo a trovare quella traccia di lucanità che cercavamo, stavolta in un luogo letteramente saturo di umanità. Abbracciamo così Andrea Di Consoli, gli facciamo gli auguri per la sua ultima fatica poetica portata a termine, quel Quaderno di legno voluto dalla piccola e coraggiosa Edilet. Ne parliamo come un libro che chiude un’ideale cerchio apertosi nel 2003 con Discoteca (Palomar di Altenative) e proseguito con La navigazione del Po (Aragno, 2007). Versi, questi lasciati al Quaderno, in cui di Consoli veleggia verso le terre estreme della sua scrittura, tendendo il suo cordame tra geometrie orizzontali (i luoghi, ad esempio: Roma, la sua Lucania interiore) e tutti i sensi percorribili tra la carne e dio, condensati in uno stile semplice e prosastico, ma non certo facile.
Il tempo di dare uno sguardo agli scaffali per cogliere due lampi (una copia di “Decanter”, il periodico di Calice, nella rivisteria; la torrida copertina di Deserti della nostra conterranea Raffaella Spera, esposta nello stand Manni), il tempo di scambiare un’impressione su Catozzella, ed ecco che il tempo dell’esordiente Dora Albanese è già venuto. C’è aria di partecipazione alla presentazione del libro Non dire madre (Hacca) un’anteprima del quale abbiamo già potuto gustare recentemente sulle pagine del nostro Quotidiano. Alla presentazione sono lo scrittore Andrea Caterini e il critico letterario Arnaldo Colasanti. Caterini sottolinea come la scritura di Albanese riesca bene a dirci la rabbia e il dolore di una scrittura che, mai lasciando sul testo tracce di incontrollato espressionismo, riesce a rimenere sempre ottimamante centrata sulla voce delle protagoniste del suo mondo. Colasanti, a ruota, ci offre invece un’acuta e penetrante (sbaragliante, diremmo quasi) analisi del testo della scrittrice materana, incentrata sul profumo (cioè su una matericità tanto individuabile quanto allo stesso tempo indefinibile) di una scrittura che altro non è che un’infanzia notturna e negata che lega e collega il voto più nascosto delle protagoniste della raccolta. Racconti che si concatenano e finiscono per sospendersi in una narrazione che rende, invece, un tono da romanzo.
Chiude il cerchio di questa ottava edizione della Fiera colui che l’aveva aperto a Torino, Gaetano Cappelli. Non avevamo fatto in tempo a lasciarlo nella capitale piemontese poco prima di scendere in lizza per lo Strega, che ecco rispuntarlo ora, sempre per parlarci del suo La vedova, il Santo e il segreto del Pacchero estremo (Marsilio) stavolta a gareggiare per la proclamazione del seguitissimo “Libro dell’Anno”, a cura della Redazione di Fahrenheit, che raccoglie i voti dei numerosissimi ascoltatori della trasmissione radiofonica emessa da RaiRadio3. E infatti ci pare salire sul palco perfettamente a suo agio con altri due pretendenti al titolo, Nicola Lagioia e Filippo Bologna. Pungolato da un ironico Giuseppe Antonelli, Cappelli si diffonde, per quanto consentito dai tempi parecchio stretti delle presentazioni, sulla sua ultima e avvincente commedia di costume e sulle suggestioni sprigionate dal suo protagonista, Dario Villalta, legato alla sua terra di origine, ma capace allo stesso modo di sentirsi perfettamente integrato nei più differenti contesti (questa volta il Nord Italia), sia pure un po’ sorpreso dai risvolti che un diverso contesto antropologico gli oppone. Parlando del suo Villalta, Cappelli molto ironicamente si sofferma, ad esempio, sui costumi delle vedove settentrionali e della loro troppo veloce elaborazione del lutto. E poi continua sugli ingredienti di un carnoso e carnale pacchero senza svelarcene, e fa bene, più di tanto gli ingrdienti. Insomma, anche come affabulatore e presentatore dei suoi libri Cappelli ci sembra uno scrittore ormai perfettamente padrone di un futuro che sembra lanciato verso traguardi di grande soddisfazione. Che gli auguriamo.
Contrariamente a quanto successo a Torino, non abbiamo, invece, troppa voglia di indignarci per l’ennesimo vuoto lasciato dalle istituzioni lucane alla Fiera della piccola e media editoria, stavolta lasciata orfana anche dell’attivismo del Consiglio regionale, che negli anni scorsi a Roma, nella promozione della nostra editoria, si era pure prodigato. Problemi di bilancio? Forse. Velenosi dissapori tra Consiglio e Regione? Gira voce. La scelta (sorprendente quanto spiazzante) di preferire la kermesse torinese in luogo di quella romana? Ma a pro di chi? Si mormora di associazioni culturali di lucani presenti in Piemonte. Comunque non certo in pro degli editori, ancora abbastanza diffidenti per organizzarsi insieme e in autonomia. E, del resto, a rimetterci sono stati proprio questi ultimi, cioè proprio chi, a Torino, con più ardore aveva difeso dalle critiche l’operato del Consiglio. Di cosa parlare, allora, se non dell’insostenibile peso della gratitudine? Tuttavia, al di là degli affari e del sostegno istituzionale, l’editoria lucana, anche per propri limiti, si presenta sostanzialmente tagliata fuori da ogni benefica vicinanza con editori di altra estrazione editoriale e provenienza geografica, nonché da ogni genere di visibilità. Il che, oggi, ha il suo peso.
Alla fine usciamo sotto un cielo mutato. Ma la pioggia a scrosci è una metafora che non ci appartiene se non per il rammarico. Singhiozzi e lacrime troppo poco credibili per essere con certezza creduti.
———————
La rassegna in cifre
Boom di visite e vendite
Si è appena chiusa a Roma la manifestazione “Più Libri Più Liberi”, Fiera (in qualche modo anche festa) della piccola e media editoria italiana. Complice il lungo ponte dell’Immacolata, la mostra mercato si è allungata di un giorno rispetto al solito, prolungandosi dal 5 all’8 di dicembre. L’evento era chiamato a un’attesa conferma o smentita di alcune tendenze che, a cominciare dalla seconda metà dello scorso anno, avevano coinvolto il settore. I dati hanno però sgomberato il campo da ogni preoccupazione soverchia, anche se molti dati di fondo rimangono per alcuni versi ancora da chiarire.
I visitatori, ad esempio, sono stati oltre 55.000 con un incremento di oltre il 10% rispetto alla scorsa edizione e con un giro di vendita agli stand che ha fatto segnare un più 20%. Un successo che Enrico Iacometti, Presidente del Gruppo dei piccoli editori dell’AIE, ha così commentato: “massima soddisfazione per gli ottimi risultati di affluenza e vendita malgrado le difficoltà oggettive date dallo spazio e dalla crisi economica; dati che hanno superato i risultati già molto positivi della scorsa edizione. La maggior parte dei piccoli e medi editori ha dichiarato che Più libri più liberi dal punto di vista delle vendite è la manifestazione di gran lunga migliore rispetto agli altri eventi legati al libro in campo nazionale”. Obiettivo degli organizzatori è ora quello di “risolvere il problema di oltre 100 editori che a oggi vorrebbero partecipare alla Fiera ma non possono per problemi di spazio”.
Oltre a proporre interessanti dibattiti sulla promozione della lettura, sulle previsioni di vendita di piccola e grande editoria, sull’aumento delle traduzioni dall’italiano all’estero, la Fiera “Più Libri Più Liberi” pare però, metodologicamente, far propri i migliori atteggiamenti dei piccoli editori di ricerca. Spesso, cioè, anticipando le tendenze future di mercato.
Non a caso, in tal senso, la Fiera ha proposto due interessanti spazi. Il primo, nello spazio DigItal Cafè, dedicato agli ebook di nuova generazione (ma altrove non sono mancati anche gli audiolibri). Strumenti tecnologici capaci di contenere con pochissimo ingombro centinaia di libri, hanno, dei ritrovati più recenti della tecnica, anche l’innegabile fascino. Ne abbiamo provati della Bookeen, della Amazon Kindle, della Bebook, Foxit e altri, sicuramente tutti insieme capaci di essere in futuro una valida alternativa alla carta stampata. Risolti oggi i problemi di retroilluminazione (che incidono sull’affaticamento degli occhi) e, parzialmente, quelli della gestione della sottolineatura, degli appunti e delle illustrazioni (rimangono sempre in bianco e nero e non ad alta definizione) sono oggi proposti in una fascia media di prezzo che varia dai 200 ai 6-700 euro.
L’atro spazio è stato dedicato alla lettura dei più giovani. Una scelta sensatissima se pensiamo che la lettura e la cultura del libro potrà salvarsi solo attraverso grandi investimenti, non solo di danaro, sui giovani. Allo spazio ragazzi non hanno mai smesso di succedersi presentazioni di fiabe, romanzi, racconti, persino poesia con un continuo afflusso di giovani e scolaresche fatte oggetto anche di dibattiti molto interessanti intorno allo specifico tema. E pensare che molti giovani che oggi approdano all’università, sono dati del Censis, scoprono di non essere capaci di scrivere non solo in un decente italiano, ma anche (e la cosa inquieta molto di più) di narrare, cioè di strutturare (strutturandosi) logicamente un discorso di qualsiasi disciplina sia umanistica che scientifica.
Clicca sull’immagine JPEG per visualizzare l’articolo
Yoani Sánchez
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 15 Novembre 2009.
_____________
La libertà sulle stampelle
La blogger Yoani Sánchez rapita e picchiata
È ormai di un paio di giorni fa la notizia del rapimento e del maltrattamento subito a Cuba dalla scrittrice dissidente Yoani Sánchez, ora ridotta alle stampelle. Tuttavia, proprio per questo, si può procedere a qualche riflessione in merito.
Ci sono persone, ci sono intellettuali che, meglio di altri, sono capaci di restituirci l’epoca che viviamo, la sofferenza o le difficoltà di un luogo, l’arroganza o la doppiezza di un potere. Apparentemente raccolgono fatti non necessariamente eclatanti, spesso nemmeno collegati nel tentativo di costruire una tesi, tuttavia sempre capaci di svelarci immancabilmente il puzzle complessivo di un sistema scellerato e dannoso. Uno di questi è Roberto Saviano. Non è un caso che Yoani Sánchez – come ha dichiarato – abbia pensato proprio a lui nel momento in cui la violenza si è abbattuta non solo sul suo corpo.
La giovane blogger avanera era saltata l’ultima volta all’onore delle cronache italiane lo scorso aprile, quando il regime castrista le impedì di recarsi a Torino per partecipare alla Fiera del Libro, dove avrebbe dovuto presentare, a maggio, il suo Cuba libre. Vivere e scrivere all’Avana, una raccolta (edita in prima edizione mondiale da Rizzoli) dei più significativi pezzi raccolti nel suo blog. Il che già dice la mancanza d’acume di un potere che avrebbe potuto lasciarla partire evitando di alimentarne il caso. Un surplus di attenzione e vigilanza internazionale che la camorra e Khomeini, con gli stessi macabri metodi, seppero suscitare rispettivamente anche per il già citato Saviano e per Salman Rushdie. Da parte sua la Sánchez, più volte attaccata direttamente da Castro, era ben cosciente del pericolo: «questa proprio è una grande sciocchezza – commentava – pubblico le mie opinioni su un blog che non nasconde né foto né nome». E la sua rete di appoggi all’estero stavolta non è riuscita a evitarle il peggio.
Yoani Sánchez è nata a Cuba nel 1975. Emigrata in Svizzera nel 2002 ha poi deciso di tornare nell’Isola, contro il parere di tutti. Per vivere ha insegnato illegalmente spagnolo ai turisti. Laureata in filologia si è poi appassionata di informatica unendo queste due attitudini in un cocktail di formidabile efficacia contro il regime di Castro e di suo fratello Raúl. Yoani fa parte di quegli avaneri che oggi abitano e rifiutano un’utopia non più loro, costruita con sacrificio da una generazione ormai anziana e impossibilitata a potersene scrollare di dosso il fallimento e il peso liberticida.
Tuttavia la scrittrice è una dissidente atipica che non porta le stimmate dell’eroina: non è una guerrigliera, non ha cicatrici sul suo volto allungato, non spara, non contesta, non denuncia (anche se qualche volta, come Gesù nel Tempio, mostra con fermezza il suo carattere). Yoani semplicemente racconta nel suo blog Generación Y cosa significa vivere ogni giorno nel regime comunista cubano. Lo fa con un uso preciso della parola che non è pietra pronta a colpire, quanto ricostruzione di fatti, circostanze, stati d’animo di fronte alla sofferenza, alla fame, alle aspettative di libertà tradite. È una scrittura al femminile, forte ma priva di coloritura ideologica, stesa con un linguaggio fatto di quotidiana disperazione, che il traduttore e curatore piombinese Gordiano Lupi sa rendere al meglio sulle pagine che «La Stampa» quotidianamente le dedica sul web e una volta a settimana sulla carta stampata.
Yoani iniziò a scrivere cosa vedeva e cosa pensava su un computer assemblato con pezzi di seconda mano recuperati al mercato nero. Poi, salvato tutto su memoria portatile, con grandissime difficoltà, si connetteva (a Cuba Internet è appannaggio quasi esclusivo dei funzionari del regime) per poter spedire i suoi post a chi poteva collocarli nel suo sito (in italiano: http://www.desdecuba.com/generaciony_it) che nell’Isola è oscurato. Oggi ci informa anche con l’ausilio di un telefono, ma il concetto di fondo è lo stesso.
Così ogni giorno veniamo a sapere che faticose avventure si possano vivere nel cercare un limone che possa alleviare un fastidioso mal di gola o di quanto sia difficile per le donne cubane procurarsi anche i pannolini per il ciclo. Veniamo a conoscenza dell’importanza del mercato nero e di come la repressione, colpendolo, scateni feedback economici devastanti che finiscono per consumarsi solo sulla pelle del popolo avanero. Di come a scuola vengano premiati i più ligi alle attività politico-patriottiche; di come le notizie debbano essere decrittate più servendosi del non detto che di quanto viene propagandato; di come i cubani siano ormai ossessionati dal cibo, dalle loro case che vanno giù a pezzi, da una voglia insana di fuggire per mare, nell’alcol, lasciandosi andare, addirittura chiudendosi in casa per evadere – così – da fermi.
La minuta Yoani ha combattuto insomma con un mezzo moderno, imprevisto e spiazzante per l’inadeguato regime, ma tutto ciò non sarebbe bastato se, a differenza dei dissidenti che l’hanno preceduta, la scrittrice non avesse scoperto un’inaspettata radura nel fitto del potere castrista. Uno spazio che è poi il punto debole di ogni potere che si assopisca senza più mettersi in discussione. E che dormendo (per dirla con Hobbes e con Neumann), si appare in sogno come il Leviatano – ordine e rigore assoluto – invece russando con la pancia elefantiaca di un Behemoth – il corpulento demone del caos.
Yoani era stata già richiamata pesantemente dalla polizia. Del resto poca cosa, commentò chi oggi crede che l’intellettuale cubana per far parlare di sé si sia inflitta da sola le ferite di cui soffre, e chi pensa che il regime dei fratelli Castro non sia così odioso come quello del vecchio blocco sovietico. Pure, anche così, resta netta la sensazione che i sostenitori occidentali del comunismo in salsa caraibica siano più preoccupati di difendere un baluardo della lotta contro i nemici statunitensi, piuttosto che essere convinti realmente dell’efficienza del regime. Loro, come i turisti presi dai secolari monumenti, non guardano le buche nelle vie, ma in alto, verso un cielo troppo lontano per qualsiasi cubano. E girano la testa quando la violenza di stato picchia per strada e tappa la bocca al giusto dissenso. Come i turisti, amano portare a casa solo il souvenir, magari carino, fatto per generare assenso e approvazione. Ma che, tuttavia, resta un balocco di scarso valore, come il potere che lo ha generato.
Resisti, Yoani.
Intervista a Giuseppe Bufalari
Questa intervista è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basilicata» il 31 Maggio 2009.
_____________
Il prezzo del progresso
Intervista a Giuseppe Bufalari per i cinquant’anni del libro “La masseria”
L’uomo che mi riceve nella centrale ma tranquilla via Dei Macci a Firenze ha la barba e i capelli bianchissimi. Ha gesti cortesi e semplici, come il suo modo di vestire: una camicia a quadri, un pantalone scuro di tela, un paio di sandali aperti. Chi mi ospita nella sua casa accogliente di libri, di legno e di un senso antico è Giuseppe Bufalari, classe 1927, autore del libro “La masseria”, uno dei capolavori del romanzo meridionalista. Accanto a lui il figlio Vieri e la moglie Ketty, a cui lo scrittore dedicò il volume.
Bufalari è lucidissimo: “venni in Basilicata nel 1953 e per un anno sono stato in una masseria. Successivamente fui trasferito a Calvello per altri tre anni. Il libro lo scrissi solo dopo, quando ormai ero a Porto Ercole. Lo terminai là nel 1959, fu pubblicato l’anno successivo”.
D.: Il suo libro raccolse davvero molte critiche positive. Dopo averle lette resta però la curiosità di chiarire meglio le circostanze dei suoi esordi di scrittore…
R.: Vasco Pratolini era originario del rione San Niccolò dove sono nato anche io e lì abitava il suo babbo, ormai anziano. Lo conobbi e quando gli rivelai che scrivevo mi esortò a far leggere le mie cose al figlio. Vasco era già a Roma e mi consigliò di mettermi in contatto, a Firenze, con Romano Bilenchi, il quale era da sempre molto interessato alle giovani leve di scrittori. Bilenchi era molto amico di Luzi e me lo fece conoscere. Di Romano ammiravo la capacità di vedere il suo mondo, di saperlo dire, di saperlo far diventare profondo. Con Luzi c’era invece c’era un comune legame con il cattolicesimo. Io me ne ero staccato, ma dentro me ne era sempre rimasta una profonda traccia. Due amicizie diverse che si compensavano.
D.: Che genesi ebbe “La masseria”?
Bilenchi mi disse che a Milano la casa Lerici gli aveva dato il compito di curare una collana che aveva preso avvio con la pubblicazione del siciliano Antonio Pizzuto. Al momento non avevo nulla da pubblicare. Quando invece scesi in Basilicata, presi a scrivere delle lettere che inviavo a mia moglie, alla mamma e a Romano. Parlavo del mondo antico e profondo che avevo trovato: un cattolicesimo antichissimo e la capacità degli uomini, nonostante un mondo duro e avverso, di poter vivere, lottare, vincere o perdere. Nelle lettere c’era tutto questo ma io non me n’ero ancora accorto. Invece Bilenchi mi esortò a scrivere ancora perché le avrebbe volute pubblicare sulla “Chimera”, una rivista di Enrico Vallecchi. Ma a lui era rimasta in mente l’idea di volermi pubblicare in quella collana. Quando poi nacque il libro ebbi subito la fortuna di una recensione scritta da Montale. Da allora tutti si accorsero di me.
D.: Che idea poté farsi del mondo contadino lucano di quegli anni uno come lei che veniva dalla Toscana della mezzadria, delle città a misura d’uomo, da una regione che dell’equilibrio tra tradizione e innovazione già allora faceva vanto?
R.: Fu una scoperta straordinaria. Ero sempre stato in questo mondo cittadino ingombro di cose, fatto di giornali, di macchine, di chiacchiere. Invece mi trovai scaraventato in questa masseria in un tempo antico, antichissimo. Lì i contadini erano autosufficienti. L’unica cosa che mancava era il sale e infatti le donne avevano il gozzo. Facevano il sapone, il vino, l’olio, il pane, tutto. Per cui era un mondo autosufficiente non solo materialmente, ma anche psicologicamente, perché tutto era spiegato: se uno si faceva male era perché era passato tra due alberi posti in un certo modo; se di notte uno si sentiva male era per la fattura di una “maciara” eccetera. I rimedi che si potevano adottare erano certo semplici: una scopa fuori dalla porta, ad esempio. Insomma c’era una tranquillità interiore. Cioè “so perché accadono certe cose, so cosa posso fare per affrontarle, dunque sono tranquillo”. Intendo interiormente. Insomma non c’erano delle nevrosi perché, se c’erano, allora si ricorreva ai balli o a rituali del tutto diversi. Devo aggiungere che essermi confrontato con Luzi su questi aspetti della spiritualità mi fece giungere più preparato a entrare dentro quel mondo, a viverci.
D.: In quel mondo riuscì ad adattarsi così bene anche alle condizioni materiali di vita, spesso così difficili?
Guardi che non era affatto un mondo povero. Lì c’era tutto, avevano tutto. Era percepito materialmente e culturalmente povero solo da chi proveniva dalle città. Ma altro che poveracci! Lì, tra l’altro, mi accorsi di cose che oggi tutti quanti vedono, cioè che questo nostro mondo ha perso tante cose che cerca affannosamente di recuperare in qualche maniera.
D.: Avrebbe potuto scegliere per il suo romanzo un punto di vista diverso: le classi medie, i paesani, privilegiando di più la tematica del rapporto tra comuni e campagne. Invece scelse questa campagna che continua a vivere ignara dell’apocalisse che incombe e che la spazzerà via.
Avrei potuto scegliere parecchi punti di vista alternativi, ma a me non premeva il paesano che avrebbe potuto scegliere di lavorare per la Riforma magari poi rifacendosi una vita altrove. A me interessava rendere pienamente lo stato dei contadini: non solo con l’intelligenza, ma con l’empatia, con tutto me stesso.
D.: Eppure dal suo libro pare che i contadini, proprio a Calvello, che la visse, non abbiano mai attraversato la stagione delle lotte agrarie provando così a inserirsi nell’ampio processo di democratizzazione del secondo dopoguerra…
Ripeto, non è questo ciò che mi interessava, perché i contadini che descrissi quell’esperienza non l’avevano fatta. Le dico solo, tanto per farle capire, che per andarli a trovare dal luogo in cui ero ci mettevo tre quarti d’ora buoni a passo sostenuto. Erano isolatissimi. Oppure che quando c’era da andare a dare il voto loro si recavano a Picerno e andavano da “Don Raffaele” per farsi spiegare bene che cosa fare. Certo qualche contadino della Riforma l’ho conosciuto, ma io volevo rendere un mondo che se ne va, che non avrei più visto.
D.: A questo proposito: è tornato poi in Basilicata?
Per quasi cinquant’anni non sono più tornato, volevo mantenere intatto il ricordo di quell’esperienza. Poi nel 2003 o 2004, non ricordo bene, la Biblioteca Nazionale di Potenza mi invitò per un convegno e partii. Andai anche a Calvello, chiesi informazioni sulla masseria. C’era il vecchio ponte, ma anche una strada nuova, persino la fiumara non aveva esattamente lo stesso corso di prima. Tutto era cambiato. Poi decisi di orientarmi con la punta del campanile di Picerno che io vedevo sempre spuntare da una parte del monte, come descrivevo nel romanzo. Non ritrovai nulla se non delle pietre in terra con vicino una casa nuova costruita dopo il terremoto del 1980. Nella casa c’era un vecchio: mi disse che la masseria non c’era più e mi chiese chi fossi. Presentatomi, mi riconobbe: era uno dei bambini a cui avevo fatto scuola. Chiamò tutti i parenti della vecchia masseria che avevo conosciuto. Vennero in Mercedes: mi fecero una festa che non scorderò mai. Insomma, i luoghi non c’erano più, erano stati resi irriconoscibili dal tempo. Ma l’impasto delle persone, le loro qualità umane erano restate intatte. Quel giorno ho sentito che cinquant’anni fa ero entrato nella loro vita per non uscirne più.
D.: Ma allora lei è per il cambiamento o no?
Nella sua recensione al mio libro Moravia colse con molta precisione il mio atteggiamento verso quell’esperienza: ogni avanzamento del progresso è necessario perché crea nuovi acquisti, ma è comunque pagato con perdite della stessa entità, anche se queste non appartengono necessariamente alla sfera economica.
———————–
Il libro in breve
Scritto nel 1959 e pubblicato per i tipi di Lerici nel 1960, “La masseria” nacque dall’esperienza che Giuseppe Bufalari fece in qualità di maestro nelle campagne intorno a Calvello.
Sono gli anni della Riforma. Nel romanzo il protagonista è inviato in Basilicata dalla Cassa per il Mezzogiorno come assistente sociale per preparare la popolazione ai cambiamenti imminenti in quelle zone. Lasciatosi alle spalle Calvello, dove i giovani aspettano positivamente la Riforma come possibilità di riscatto economico e sociale, si addentra nelle campagne verso la masseria della famiglia Torraca. Qui trova una realtà fatta di reciproci odi e una vita scandita dalle feste propiziatorie. È un mondo isolato dove le poche notizie giungono solo con i rari venditori ambulanti che lo attraversano. L’assistente sociale, pur convinto della necessità del cambiamento, si rende conto che il tempo per operare mutamenti nella mentalità dei contadini non può essere che lungo.
Intanto la Riforma si è avviata e ben presto si presenta alle porte della masseria con operai, macchine, strade. Nessuno si è curato delle relazioni inviate dall’assistente sociale che scrive per informare del disastro che provocherebbe l’arrivo così subitaneo delle trasformazioni. In pochi mesi, con la costruzione di una diga, si formerà nei terreni della masseria un lago che la cancellerà. Intanto l’assistente è sostituito e trasferito in Calabria.
Intervista a Franco Arminio
Questa intervista è stata pubblicata su «Il Quotidiano della Basiicata» il 20 Maggio 2009.
_____________
La Lucania? potrebbe essere una nuova frontiera
Intervista al paesologo Franco Arminio
Durante la Fiera del Libro di Torino Franco Arminio è stato ospite di un paio di dibattiti. Ne abbiamo parlato a margine. Arminio, paesologo, classe 1960, è di Bisaccia, in provincia di Avellino. Poeta, scrittore, giornalista, organizza eventi culturali ed è animatore di numerose battaglie civili. Attualmente anima il blog “Comunità Provvisoria”.
D.: Quest’anno a Torino hai esordito con un doppio impegno. Il primo in compagnia della redazione di “Cartaditalia” la nuova rivista edita a cura dell’Istituto italiano di cultura “Carlo Maurilio Lerici” di Stoccolma. Con te Davico Bonino, Domenico Scarpa, Andrea Bajani e Roberto Alajmo. Una compagnia di intellettuali sicuramente atipica…
R.: Di Scarpa sono amico. Bajani mi ha scritto una bellissima lettera sul mio ultimo libro (“Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia”, ndr). Gli altri li ho incontrati in questa occasione, ma spero di conoscerli bene in futuro.
D.: Come ritieni che oggi un Paese colto, evoluto, ma pure così distante come quello svedese possa percepire il tuo sud fatto di piccoli paesi che non superano i due-tremila abitanti e di cui racconti una malattia forse terminale?
R.: Non so, certo l’Italia non è più un paese esotico come una volta. In fondo io racconto un sud molto diverso da quello che racconta Saviano, un sud per certi aspetti nordico. Il clima di Bisaccia non è molto diverso da quello svedese.
D.: Pensi sia più facile raccontare il sud al resto d’Europa che al resto d’Italia?
L’Italia del nord non è interessata più di tanto al sud. Per certi aspetti si potrebbe trovare più ascolto in Europa, ma il problema è che i libri belli non superano le alpi.
D.: Speriamo “Cartaditalia” possa contribuire… Il tuo secondo impegno è stato invece quello di partecipare, in compagnia di Marcello Fois, al dibattito “La strada del cambiamento. Come è cambiata l’Italia. Qui l’alta velocità non passa”. Come valuti il tema sapendo che la tua Italia è fatta soprattutto di sud?
R.: Io racconto quello che vedo e quello che vedo è un sud con molte ombre. Alla durezza della civiltà contadina si sono aggiunte le miserie dell’universo piccolo-borghese: l’ipocrisia, il provincialismo. Il paesaggio umano al sud è decisamente sconfortante. Le persone migliori vivono isolate. I comuni sono gestiti da gente senza idee. D’altra parte al sud, almeno in certe zone, resiste ancora il paesaggio. E questo mi conforta molto. Secondo me i territori vuoti, i territori non invasi dalla modernità incivile possono essere il punto di partenza per un nuovo modo di abitare il sud.
D.: Dunque bene o male che l’alta velocità non passi da qui?
R.: Se deve fare gli effetti che ha fatto altrove è bene che non passi. Oggi per me l’Italia più bella è quella dei paesi più affranti e sperduti. So bene che il mio è un giudizio estetico e non si vive solo di estetica, ma credo che questa bellezza possa diventare anche un fattore di sviluppo economico, uno sviluppo che però deve essere inteso assai diversamente dal passato.
D.: A proposito di paesi sperduti: tu che vivi con un piede in Campania e un altro in Lucania cogli una specifica diversità di fondo tra i piccoli paesi delle due regioni, oppure sono solo minime variazioni a un tema comune?
R.: La Lucania è meno ingombra di cose. Si vede molta campagna tra un paese e l’altro. Direi che ha una densità ottimale. In Campania, a parte le zone più interne, è veramente un disastro. Io mi sento più lucano che campano. E spero tanto che il mio paese prima o poi finisca per appartenere alla Lucania. A Bisaccia c’è la stessa aria di Potenza. Quando vado a Napoli mi sento all’estero. Napoli non capisce i piccoli paesi, non li ha mai capiti. Abbiamo bisogno di politiche e di una cultura che parta dai piccoli paesi. Da questo punto di vista la Lucania potrebbe essere la frontiera di una nuova Italia, ma non sento molti fermenti. È importante che ci sia una saldatura tra i lucani che stanno fuori e quelli che sono rimasti. Una saldatura per riabitare, per riabilitare questi luoghi bellissimi, ma troppo spesso trascurati proprio da chi li vive.
Clicca sull’immagine JPEG per visualizzare l’articolo
Fiera internazionale del libro di Torino (2009)
Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano della Basilicata» il 20 Maggio 2009.
_____________
Alla Fiera di Torino la ricerca di una Basilicata fuori dal guscio
L’uovo è dappertutto. Ci segue attraversando Torino fino a giungere al Lingotto, scorre le lunghe file di visitatori che attendono di fare il biglietto d’entrata, rotola tra i padiglioni e gli stand degli espositori. La presenza dell’immagine che meglio riassume il senso della ventiduesima edizione della Fiera del libro ci accompagna costantemente: un uovo che sta per dischiudersi e che chiama chi lo guarda a farsi forza, a uscire fuori dall’isolamento del proprio guscio per aprirsi agli altri, al mondo esterno. Durante la Fiera, da quell’involucro esce davvero di tutto, inondando i 51 mila metri quadrati di spazi che hanno accolto gli oltre 1.400 editori presenti. Scrittori vecchi e nuovi, editori grandi e piccoli, istituzioni specializzate, operatori, temi affascinanti, presentazioni, dibattiti, spunti interessanti, lettori forti e in erba, intellettuali, semplici curiosi. Un fiume che ci trascina via insieme a migliaia e migliaia di persone che scorrono, si fermano, creano ingorghi che si sciolgono improvvisamente, attratti da un dibattito, da un libro a lungo cercato, da un autore a cui chiedere un autografo.
In tutto questo turbinare a un tratto ci fermiamo e ci chiediamo se da quel guscio d’uovo possa uscire mai anche la Basilicata. La domanda ci sorge spontanea appena incappati nel padiglione della Regione Campania, si ripete davanti a quello animatissimo della Regione Puglia, ci ossessiona ai piedi di quello ricolmo di libri della regione Calabria (così finiamo anche per emozionarci al cospetto dello scaffale espositivo dedicato alle vecchie edizioni delle opere di Saverio Strati). Ci chiediamo insomma se il pulcino Basilicata sia rimasto ancora una volta rintanato nel guscio, pauroso di mescolarsi alla festa. Non ci consolano le sparute presentazioni a cura del nostro Consiglio regionale che presenta, con Prospero De Franchi, un libro di El Idrisi in un incontro intitolato “Sollazzo chi si diletta di girare per il mondo (e giunge quindi in Basilicata)”. Né ci conforta la totale assenza degli editori lucani. Certo, si dirà, come paragonare i poveri mezzi delle case editrici lucane al catalogo di alcuni editori calabresi, sardi o campani? Non ci crediamo, perché gli editori calabresi e sardi sopperiscono anche con orgoglio, voglia di fare, soprattutto con un pizzico di intelligenza. Perché si consorziano, ottimizzando gli utili e dividendo i costi, peraltro costantemente supportati dalle loro istituzioni regionali. Un atteggiamento coraggioso di cui la regione Basilicata ha saputo far sfoggio, non si sa quanto una tantum, solo alla fiera libraria di Roma dello scorso anno. Invece alla festa di tutta l’editoria, quella grande e piccola, nulla.
Però cediamo all’amarezza e allo sconforto solo quel tanto che basta prima di scoprire che invece un’altra Basilicata ha deciso di uscire fuori dal quel benedetto guscio mettendo fuori le zampette già forti. A interrompere il magone interviene infatti una gigantografia che a un tratto ci giunge dallo stand di un editore importante come è Marsilio. Il viso che ci sorride è quello di Gaetano Cappelli. A Torino lo ha da poco presentato il suo maggiore sostenitore e promotore, il critico Antonio D’Orrico che lo ha portato non solo agli onori della cronaca letteraria, ma dritto filato nella quindicina dello Strega, il più ambito (e remunerativo in termini di vendite) premio letterario italiano. Ci conferma tutto Filiberto Zovico, che ci accoglie con molta cortesia nello stand della casa editrice veneta: “la candidatura di Cappelli l’abbiamo valutata proprio a seguito di una provocazione lanciata da D’Orrico in una delle sue entusiastiche recensioni allo scrittore lucano. Detto fatto. Certo, avremmo potuto prendere in considerazione la cosa già ai tempi di ‘Storia controversa…’, ma forse i tempi non erano ancora maturi e comunque questo libro è resta assolutamente all’altezza di uno scrittore in cui crediamo fermamente. Dopo che il fiuto di uno scopritore di talenti della sensibilità di De Michelis ci aveva consentito di scoprire Cappelli e di pubblicarlo, ritenemmo opportuno crescere con editori allora più importanti del nostro, seguendo una politica che abbiamo sempre fatto nostra. Finché non è cambiata la situazione tanto da poter rinsaldare con Cappelli un rapporto sempre restato molto stretto”.
Prima di lasciarci Zovico non ci nasconde di essere soddisfatto anche di Giuseppe Lupo sia per le vendite che per lo spessore artistico di uno scrittore comunque commercialmente più “difficile” in quanto legato a tematiche più territoriali e di diversa profondità storica, a cui Lupo “reagisce” con una capacità davvero unica di scrittura e scioltezza.
Di Consoli lo troviamo invece un po’ dappertutto: tra i libri dell’Ancora del Mediterraneo, editore partenopeo, e tra quelli Rizzoli, suo editore attuale che non ha certo bisogno di presentazioni. Sulle sue tracce finiamo alla piccola ma promettente Hacca di Macerata, casa presa ora per mano da Francesca Chiappa che ha pensato bene di affidare a Di Consoli una collana che ha saputo subito far levitare con autori del calibro di Carraro e Paris, Veneziano e Bonina. Ci parlano più diffusamente di lui anche Anna Grazia e Agnese Manni, dell’omonima casa editrice leccese: “Andrea lo abbiamo seguito fin dai suoi esordi e siamo state molto felici di averlo in catalogo con un piccolo libro ma davvero ben scritto e ricco di vissuto e nostalgia come ‘Marisdea’. Insieme a Raffaele Nigro, uno scrittore che nel carattere unisce dolcezza e determinazione, (nella stessa collana di Di Consoli ha pubblicato ‘Maschere serene e disperate’, ndr) è probabilmente uno degli scrittori più interessanti delle ultime generazioni di scrittori lucani. In catalogo abbiamo avuto poi anche il piacere di avere Giancarlo Tramutoli, uno scrittore giovane, spigliato e irriverente. Il lavoro editoriale su ‘Uno che conta’ è stato davvero divertente”.
Usciamo dal Lingotto con sentimenti contrastanti, sempre costretti come siamo a trovare una Lucania che non è mai dove dovrebbe essere, sempre costretta fuori da se stessa, lasciata a diluirsi nel mondo. Il che ci amareggia, ma pure ci allieta, perché il talento non è mai così provinciale.
____________________________
“Io, gli altri” alla XXII Fiera del libro di Torino
Si è appena conclusa la ventiduesima Fiera del libro a Torino (Lingotto, 14-18 maggio). Solo tra qualche giorno conosceremo i dati di affluenza definitivi e soprattutto di volume di affari sviluppato da una rassegna che pare essere giunta alla fine di un lungo ciclo e in attesa di un rinnovamento non più rinviabile tra notevoli problemi di budget e il ritorno all’antico nome di “Salone del libro” che ovviamente comporta in sé problemi non solo semantici.
Paese ospite di questa edizione l’Egitto, fin dal primo Ottocento meta ambita dagli italiani, prima archeologi oggi turisti. Paese-mondo dalla ricca cultura, anche letteraria – animata da scrittori come Naguib Mahfouz o Ala Al-Aswani – che certo merita di essere conosciuta quanto le piramidi o le incantevoli spiagge di Sharm.
Filo conduttore della Fiera, invece, il tema “Io, gli altri”, una lunga riflessione ispirata dall’osservazione, tanto semplice quanto sistematicamente trascurata, che la conoscenza e la tolleranza verso gli altri passa necessariamente dalla conoscenza di se stessi. Innegabile quanto oggi l’Io sia malato. “Esibizionista, egoista, autoreferenziale, indifferente al destino e alle necessità degli altri, ha perso il senso della comunità ed è incapace di elaborare progetti condivisibili, di riconoscersi in una causa di utilità comune. Un Io che non sa guardarsi dentro”, che preferisce creare alter-ego virtuali offrendo di sé un’immagine edulcorata che non è il ritratto di quello che si è, ma di quello che si vorrebbe essere. Un tema che non ha mancato di investire le discipline più disparate: dalle neuroscienze alla psicoanalisi, dalla politica alla storia al diritto fino all’etno-antropologia con il concorso di autori del calibro di Edoardo Boncinelli, Luciano Canfora, Alberto Manguel, Elena Loewenthal e molti altri. Un tema centrale forte che però, perfettamente in linea con le sue premesse, non ha fatto ombra alle tante altre questioni discusse – impossibile seguirle tutte – collegate all’attualità: la giustizia, i diritti umani, la crisi della sinistra, il mondo del lavoro, il caso Rai, le mafie, le politiche della Chiesa.
Una congerie davvero senza fine di dibattiti, autori, editori, appassionati e operatori del settore. Senza farsi mancare qualche vip (uno su tutti Emanuele Filiberto di Savoia) della quale onnipresenza il mondo del libro, pur da sempre di bocca buona, non si sa francamente quanto abbia bisogno per rilanciarsi. Più gradite le numerosissime scolaresche che si sono accalcate tra sale e stand: la sopravvivenza futura del libro, questo semplice oggetto ad alto concentrato idee, ha molto bisogno di loro.
Clicca sull’immagine JPEG per visualizzare l’articolo









































